Mi chiamo Thomas Baglioni, e porto dentro di me tre anime che raramente si incontrano tutte insieme attorno a un film. Sono uno psicologo clinico , un biochimico di professione e per formazione e in parte anche un cinefilo appassionato per vocazione. Queste tre identità convivono, talvolta in conflitto e talvolta in armonia, influenzando il mio sguardo sul mondo e sull’arte. Quando ho sentito parlare per la prima volta di Bugonia – il nuovo film di Yorgos Lanthimos, uscito nel 2025 – ho avvertito immediatamente il richiamo irresistibile di una storia che sembrava fatta apposta per intrecciare i miei interessi più profondi. Bugonia è infatti un termine antico che evoca miti di vita nata dalla morte, un concetto a cavallo fra psicologia del profondo, biologia arcaica e simbolismo culturale. Allo stesso tempo, Bugonia (il film) è un’opera cinematografica ricca di riferimenti, di echi di altri film, e di spunti postmoderni che solo uno spettatore cinefilo può cogliere appieno. Come psicologo, intravedo nelle trame di questo film un viaggio nel trauma e nell’ossessione, un caleidoscopio di difese mentali e di dinamiche relazionali estreme. Come biotecnologo, rimango affascinato dal modo in cui un antico mito sulla generazione spontanea – credenza proto-scientifica superata dalla scienza moderna – venga ripreso e attualizzato per parlare di crisi ecologiche e manipolazioni biomediche contemporanee. E come amante del cinema, non posso che esultare di fronte alla rete di citazioni filmiche e influenze che Lanthimos tesse con maestria, da Hitchcock a Kubrick, dai classici della fantascienza anni ’60 fino al cinema surreale e postmoderno dei nostri giorni.
Scrivere di Bugonia per me non è solo recensire un film: è intraprendere un viaggio personale e multidisciplinare. Mi vedo, ancora prima di iniziare a digitare queste parole, seduto in una sala buia con il cuore in gola, mentre scorrono le immagini iniziali di Bugonia. Sullo schermo, due figure maschili un po’ goffe ma determinate – Teddy e suo cugino Don – si preparano a compiere qualcosa di folle nella penombra di una casa di campagna. Nel frattempo, altrove, una donna in carriera di nome Michelle corre su un tapis roulant ultramoderno, ignara del destino che l’attende. Nel montaggio parallelo di queste scene iniziali riconosco già l’inconfondibile tocco di Lanthimos: uno humour nero latente, un’atmosfera sospesa tra il grottesco e il surreale, e sotto la superficie una tensione psicologica pronta a esplodere. Ma soprattutto, come psicologo colgo subito i segni di un delirio condiviso: Teddy e Don indossano tute argentate logore, preparandosi come soldati di un esercito immaginario, e fanno esercizi bizzarri auto-infliggendosi disciplina e persino dolore (arrivano a castrarsi chimicamente, ci verrà mostrato). Quale motivo può spingerli a tanto? La risposta risuona potente nel titolo stesso del film e nelle ossessioni dei protagonisti: Bugonia, le api che muoiono e rinascono, la vita che si rigenera dalla putrefazione, e l’idea che forse l’umanità stessa sia marcia fino al midollo e meriti un drastico “reset”.
Ho deciso di recensire Bugonia in chiave psicologica e culturale perché poche altre opere recenti offrono una tale stratificazione di significati. Da studioso della mente umana mi affascina il profilo di Teddy, questo apicoltore paranoico convinto di complotti alieni, e la sua relazione di dipendenza reciproca col giovane Don, spettro autistico e coscienza frammentata. Da esperto di biotecnologie mi intriga la figura di Michelle, spietata CEO farmaceutica che dietro un volto umano nasconde – forse – l’alterità radicale di un alieno: un perfetto simbolo delle nostre paure attuali verso le élite tecnoscientifiche, i vaccini, le sperimentazioni cliniche andate storte. E da amante del cinema, non posso fare a meno di esaltarmi nel riconoscere in Bugonia omaggi a film che hanno segnato la storia: un interrogatorio claustrofobico che odora di Rope di Hitchcock, un mondo sull’orlo dell’apocalisse che rievoca Il pianeta delle scimmie, sequenze oniriche che riportano alla mente Jacob’s Ladder o Brazil, e un generale sentimento di assurdità che potrebbe essere uscito dalla penna di Kafka o dalla cinepresa di Kubrick.
Questa non sarà dunque una semplice recensione, ma una sorta di “mega-saggio” in cui guiderò il lettore attraverso vari livelli di profondità. In primo luogo esploreremo cosa significa veramente “bugonia”: scopriremo le radici storiche, etimologiche, scientifiche e mitologiche di questo termine così insolito, viaggiando indietro nel tempo tra gli scritti di Virgilio e Ovidio, tra antiche credenze di generazione spontanea e le loro successive confutazioni scientifiche. In secondo luogo, analizzeremo tutte le citazioni cinematografiche che Bugonia dissemina lungo il suo percorso visivo e narrativo: dall’esplicito richiamo ad Alfred Hitchcock (in particolare al congegno teatrale di Nodo alla gola), ai rimandi alla fantascienza degli anni Sessanta come L’uomo che visse nel futuro (con la figura dei Morlock) e Il pianeta delle scimmie, fino ad arrivare a riferimenti più sottili a film come Allucinazione perversa (Jacob’s Ladder), Brazil, Il processo di Orson Welles, e all’influenza onnipresente di Stanley Kubrick. Discuteremo anche del carattere surreale, postmoderno e citazionista del cinema di Lanthimos, mettendolo in dialogo con autori contemporanei come Ari Aster e i fratelli Coen. In terzo luogo, dedicheremo uno spazio approfondito alla natura di Bugonia come remake occidentale del film sudcoreano Save the Green Planet! (2003): capiremo cosa significhi rifare un film di culto cambiando contesto culturale, e useremo questa lente per parlare più in generale di remake, citazione, autocitazione e cinema postmoderno. Infine, nella parte più corposa e, per me, più sentita, condurremo una lunga analisi psicologica del film e dei suoi personaggi: esploreremo il trauma di Teddy legato alla madre in coma e agli abusi (fisici ed emotivi) da lui subiti; interpreteremo il complottismo come difesa psicologica di fronte a un mondo insensato; leggeremo la dinamica tra Teddy e Michelle come una sorta di seduta di psicoterapia inversa, dove chi è legato e imprigionato finisce per fare da specchio terapeutico al suo aguzzino; approfondiremo il concetto della “morte bianca” della madre di Teddy (una madre viva ma assente, simile a un fantasma che ancora lo tormenta); analizzeremo momenti chiave come la scena dell’antigelo, in cui il desiderio di guarigione si mescola al desiderio di annientamento in un atto terribile; rifletteremo sul significato delle scosse elettriche e delle sperimentazioni tortuose che Teddy conduce, e su come esse rivelino il suo rapporto distorto con la figura materna e con il Femminile; esamineremo il personaggio di Don e il modo in cui il suo spettro autistico e la sua identità frammentata giocano un ruolo cruciale nel dramma; infine, considereremo come Bugonia utilizzi narrativamente la camera dell’eco delle ideologie complottiste e il filtro percettivo del trauma per mostrarci il mondo attraverso occhi deformati dalla sofferenza.
Sarà un percorso lungo – questo saggio si snoderà come un viaggio in più atti, non diversamente dai tre giorni/atti scanditi dal film stesso – ma spero coinvolgente. Vi invito a prendere posto accanto a me: immaginate di entrare nel mio studio, dove alle pareti ci sono tanto locandine di film quanto certificati di laurea in discipline scientifiche, e di ascoltare il racconto appassionato di un analista che seziona un’opera cinematografica come farebbe con un sogno complesso di un paziente. Bugonia è un film che mi ha parlato in prima persona, pungolando ricordi, paure, idee e persino antiche conoscenze dimenticate nei libri di mitologia e di biologia. È un film che unisce thanatos ed eros, morte e (ri)nascita, disperazione e speranza – il tutto con l’ironia crudele e la poesia visiva tipica di Lanthimos. Ed è un film che, alla fine, mi ha lasciato con domande profonde sullo stato dell’umanità, sul futuro che ci attende e sul ciclo eterno di vita-morte-rinascita su cui si regge la nostra esistenza.
Intraprendiamo dunque insieme questa esplorazione. Come Aristeo sceso negli abissi alla ricerca di risposte dagli dei, anche noi scenderemo nelle profondità oscure di Bugonia – nei suoi miti, nelle sue citazioni, nelle sue viscere psicologiche – con la speranza di far emergere qualche verità, o almeno di godere del viaggio intellettuale ed emotivo che un’opera d’arte complessa può offrire.
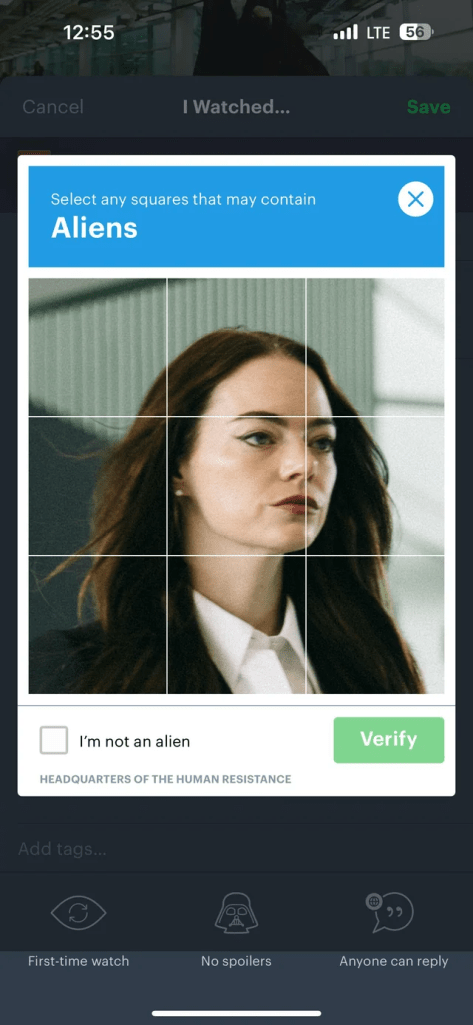
Bugonia: mito, etimologia e scienza di un’illusione antica
La parola “bugonia” ha un suono strano e arcaico, che profuma di terra, di pergamene antiche e di alchimia rustica. Non è un termine inventato dagli sceneggiatori di Bugonia, bensì un riferimento colto a un mito agricolo dell’antichità. Per capire appieno il significato di questa scelta – e dunque il cuore simbolico del film – dobbiamo fare un passo indietro di duemila anni e più, fino a un’epoca in cui gli uomini osservavano il brulicare misterioso della vita e cercavano spiegazioni nel meraviglioso e nel divino. Bugonia, in greco antico βουγονία (bougonía), significa letteralmente “generazione dal bue” o “nato da un bovino”. Il termine descrive infatti l’antica credenza che dalle carcasse in decomposizione dei bovini – e in particolare di un toro sacrificato – potesse spontaneamente generarsi uno sciame di api. In altri termini, i nostri antenati mediterranei erano convinti che uccidendo un bue in un certo modo e lasciandolo marcire, la morte dell’animale si sarebbe trasformata magicamente in nuova vita sotto forma di api ronzanti. Un’immagine potente, che unisce la crudezza del sangue e della putrefazione alla dolcezza del miele e al miracolo della nascita: non stupisce che bugonia sia diventata per gli antichi un simbolo di morte e rinascita, un rituale quasi sacro per rigenerare ciò che era perduto.
La fonte più famosa e influente su questo mito ci viene dal poeta latino Virgilio, che nelle sue Georgiche – poema didascalico dedicato alle arti agricole, pubblicato attorno al 29 a.C. – ne offre una descrizione vivida e poetica. Siamo nel quarto libro delle Georgiche: Virgilio narra la storia del pastore Aristeo, figlio della ninfa Cirene, il quale allevava api. Un giorno Aristeo vide improvvisamente morire tutte le sue api, decimate da malattie e carestia; disperato e confuso, cercò aiuto presso la madre divina Cyrene. Fu proprio la madre, dal suo regno nelle profondità di un fiume, a rivelargli la soluzione: “Devi compiere un sacrificio rituale”. Aristeo, per ordine materno, sacrificò un toro – anzi, in alcune versioni quattro tori e quattro giovenche – e sigillò le carcasse in un luogo chiuso e oscuro, evitando che ne colasse sangue. Trascorsi alcuni giorni (Virgilio parla di “giorni” nella prima descrizione e di “settimane” nella successiva variante del mito all’interno del poema), dal corpo in putrefazione del bue emerse miracolosamente un nuovo sciame di api, che andò a rimpiazzare quelli perduti. Le api erano “nate” dal toro morto, e Aristeo poté riprendere la sua attività apicola: la vita era stata generata dalla morte, grazie all’intervento divino e al macabro rituale. Virgilio inserisce questo episodio meraviglioso come culmine del libro IV, fondendo in esso mito e precetto agricolo: da un lato l’episodio della bugonia serve come aition (spiegazione mitica) di una pratica, dall’altro chiude simbolicamente il poema sull’agricoltura con un messaggio di rigenerazione e speranza, dopo la digressione tragica sul mito di Orfeo ed Euridice intrecciato alla vicenda di Aristeo.
Va detto che nelle Georgiche Virgilio presenta due descrizioni della bugonia: una più tecnica all’inizio della seconda parte del libro IV (versi 281-314) in cui pare dare istruzioni pratiche – quasi un “manuale” – su come effettuare il rito (un singolo vitello ucciso e chiuso in un piccolo spazio ermetico, da cui dopo alcuni giorni scaturiscono sciami di api), e una seconda narrazione, più elaborata e mitologica, in cui Aristeo sacrifica diversi animali all’aperto come offerta agli dèi e come purificazione per la propria colpa (la morte indiretta di Euridice di cui era stato causa). In quest’ultima versione, dopo il sacrificio quadruplo, le api rinascono dalle carcasse – ed è interessante notare come Virgilio vari i dettagli per scopi poetici e simbolici. In ogni caso, l’idea centrale rimane: il prodigio delle api generate dal corpo del toro morto.
Virgilio non si è inventato di sana pianta questo mito. Studi storici e fonti ci dicono che la credenza nella bugonia circolava già da tempo nel mondo antico. Forse l’eco più antica è in un autore greco del III secolo a.C., Nicandro di Colofone, che pare menzionarla, e alcuni attribuiscono l’origine addirittura agli Egiziani. Si diceva infatti – riferisce ad esempio Antigono di Caristo, scrittore greco – che in Egitto i contadini usassero davvero seppellire un bue con solo le corna sporgenti dal terreno; dopo qualche settimana, tagliate le corna, da lì uscivano sciami di api nuove. Non sappiamo se ciò fosse mai praticato realmente o fosse solo leggenda etnografica, ma il fatto è che variazioni del mito compaiono in tutto il Mediterraneo antico, dalla Grecia a Roma. Poeti ellenistici come Callimaco e Teocrito ne fanno cenno, e persino la Bibbia, nel libro dei Giudici, contiene un racconto che riecheggia il tema: Sansone trova un alveare di api con miele nel cadavere di un leone, e ne trae un indovinello (“Dal forte è uscito il dolce…”). Nel contesto biblico non è presentato come miracolo intenzionale, ma più tardi molti commentatori giudeo-cristiani hanno usato l’episodio come prova che la bugonia fosse possibile – dopotutto, se Sansone trovò miele in un leone morto, vorrà dire che le api nacquero da quel cadavere. Persino il filosofo ebreo Filone di Alessandria, nel I secolo d.C., menziona la bugonia: argomentando sul perché la legge mosaica vieti di offrire miele in sacrificio a Dio, suggerisce (forse ironicamente) che il motivo potrebbe essere che il miele è prodotto da un animale impuro come l’ape, la quale – “così almeno si racconta” – nasce dalla putrefazione di buoi morti. Dunque la bugonia, oltre che un curioso aneddoto naturalistico, aveva perfino risvolti teologici per alcuni.
Al di fuori della poesia e del mito, la bugonia si insinuò nelle enciclopedie e nei trattati di storia naturale antichi. Plinio il Vecchio, erudito romano del I secolo d.C., nella sua Naturalis Historia la cita come un fatto reale, descrivendo il procedimento (pur con scetticismo su alcune varianti, come quella che da cavalli morti nascano vespe). Colpisce che persino nei secoli successivi la credenza persista: fonti medievali e rinascimentali ne parlano ancora. Il Geoponica, compilazione bizantina del X secolo sulle pratiche agricole, riporta nei dettagli le istruzioni per effettuare la bugonia – descrizione sostanzialmente uguale a quella di Virgilio, con il toro ucciso a bastonate (per non far uscire sangue), gli orifizi sigillati, il corpo lasciato in una piccola casa chiusa per alcune settimane, e infine l’apertura della stanza per trovarvi sciami di api appese a grappoli. Nel Medioevo, autori come Pietro de’ Crescenzi (circa 1304) la menzionano. E perfino nel ‘700 manuali di apicoltura ancora riportavano metodi di bugonia – segno di quanto radicata fosse l’idea, o quantomeno la fascinazione per essa, nella cultura popolare dell’Europa pre-scientifica.
Ma davvero le api possono nascere da un bue morto? Oggi sappiamo con assoluta certezza che no: la bugonia non è altro che un caso pittoresco di quella che gli antichi chiamavano generazione spontanea, ovvero la teoria secondo cui forme di vita potevano originarsi dalla materia inanimata o in decomposizione. Prima dell’avvento della biologia moderna, l’idea di generazione spontanea era diffusa: si credeva ad esempio che i vermi e le mosche nascessero dalla carne putrefatta, che i topi potessero generarsi spontaneamente da stracci sporchi e grano (un celebre “esperimento” descritto da alcuni autori medievali), o che persino i coccodrilli nascessero dal fango del Nilo al primo sole di primavera. La bugonia era la variante applicata alle api. Alcuni antichi pensatori, tuttavia, già dubitavano: Aristotele, nel IV sec. a.C., pur sostenendo la generazione spontanea per alcune creature semplici, nega che le api possano nascere da altro che non siano api stesse, e anzi distingue bene i fuchi, le api operaie e l’ape regina (che lui chiama “re”) – segno che aveva intuito il ciclo riproduttivo proprio di quegli insetti e non credeva alle leggende. Autori latini come Columella (esperto di agricoltura) e lo stesso medico Celsio pare fossero scettici sul metodo. Insomma, non tutti ci credevano, ma l’idea rimase affascinante per molti secoli, probabilmente perché rispondeva a simbolismi e desideri profondi (il desiderio di controllare la natura, di ottenere vita dalla morte, di compiere in fondo un piccolo miracolo domestico). Inoltre, c’era forse qualche osservazione empirica distorta alla base: un vitello morto lasciato in campagna attirerà sicuramente insetti. Ad esempio, alcune mosche dell’ordine Sirfidi (come Eristalis tenax) hanno larve che proliferano nei cadaveri in decomposizione e sfarfallano adulti che somigliano vagamente a api o vespe. Un contadino antico, vedendo uno sciame di insetti simili ad api levarsi da un carcassa, poteva facilmente prendere lucciole per lanterne, o meglio sirfidi per api, e convincersi di aver assistito al prodigio. A ciò si aggiunga che le api domestiche (Apis mellifera) talvolta costruiscono nidi in cavità ossee o tronchi cavi, persino in carcasse vuote di animali grandi: quindi trovare api dentro un animale morto, per quanto raro, non è del tutto impossibile – e la mentalità pre-scientifica scambia correlazione per creazione.
È però con l’età moderna e la nascita del metodo scientifico sperimentale che la bugonia (e la generazione spontanea in generale) iniziano a vacillare. Un nome spicca su tutti: Francesco Redi, medico e naturalista italiano, che nel 1668 pubblicò il celebre esperimento che confutava la generazione spontanea degli insetti nella carne in putrefazione. Redi mostrò che se si protegge un pezzo di carne con delle garze in modo che le mosche non vi possano deporre le uova, non compaiono vermi (larve) nella carne stessa. Bastava questo semplice test per capire che i vermi derivano da uova di mosca e non dalla carne che marcisce. Redi, nelle sue Esperienze intorno alla generazione degl’insetti, gettò così il primo granello di sabbia nell’ingranaggio secolare della credenza spontaneista. Nei decenni e secoli successivi, ulteriori esperimenti – da Spallanzani a Louis Pasteur – avrebbero esteso la confutazione della generazione spontanea anche ai microrganismi, stabilendo il principio fondamentale che “ogni vita proviene da altra vita” (omne vivum ex vivo). Con Redi e la scienza moderna, la bugonia fu relegata definitivamente nel regno del folklore e della storia della scienza, come curiosità del pensiero antico.
Eppure, nonostante sia scientificamente una falsità, la bugonia continua ad affascinare l’immaginario proprio per il suo forte valore simbolico. Morte che genera vita, corruzione che diventa purezza (miele), sacrificio cruento che porta salvezza: sono temi che risuonano in tanti miti e religioni. Il sacrificio del toro per ottenere api ricorda, in altra forma, rituali di morte e resurrezione presenti nelle religioni misteriche antiche; fa pensare al culto di Osiride smembrato da cui germoglia il Nilo, o al sangue dei sacrifici che fertilizza la terra. Per la psiche umana, vedere uno sciame di piccole creature nascenti da un corpo grande in decomposizione doveva avere la forza di un’allegoria: la speranza che dal disastro possa emergere qualcosa di utile e buono (le api, produttrici di miele, erano viste come creature preziose, collegate perfino alle anime pure). Non a caso, autori cristiani medievali reinterpretarono la bugonia in senso morale: ad esempio, il fatto che dal corpo putrefatto di un animale impuro nasca un insetto laborioso e produttore di dolcezza veniva visto come simbolo di redenzione, oppure – in negativo – come ragione per considerare le api impure (come fa Filone). Insomma, la bugonia era più di una “fake news” scientifica: era un simbolo culturale.
Yorgos Lanthimos, scegliendo di intitolare il suo film Bugonia, attinge precisamente a questa ricca rete di significati. Egli riprende una parola quasi dimenticata e le dà nuova linfa, consapevole che il suo film parla di ciclo vita-morte, di sacrifici, e in particolare di api che muoiono e di un mondo contaminato da cui forse può nascere qualcosa di nuovo. Nel film infatti Teddy è – non casualmente – un apicoltore, e la sua ossessione nasce dal vedere le proprie api morire misteriosamente. Viene menzionato esplicitamente il fenomeno del Colony Collapse Disorder (spopolamento degli alveari), un problema reale del nostro tempo in cui le api operaie scompaiono dagli alveari lasciando le regine a morire, fenomeno forse legato a pesticidi o cambiamenti ambientali. Teddy interpreta la morìa delle sue api come un segno di un complotto deliberato: secondo lui c’è un piano degli alieni (incarnati dalla CEO Michelle) per sterminare le api e così devastare l’ecosistema terrestre. Notiamo qui un primo ribaltamento ironico: nell’antico mito la morte del toro produce nuove api, mentre in Bugonia la morte delle api prelude alla morte degli esseri umani. Teddy compie il percorso inverso ad Aristeo – non cerca di far rinascere le api con un sacrificio, ma decide di “sacrificare” (metaforicamente e letteralmente) il presunto alieno colpevole per salvare l’umanità. Tuttavia Lanthimos dissemina richiami al mito: dal sacrificio cruenta di un essere vivente per un bene superiore (Teddy non esita a torturare e pianificare l’uccisione di Michelle come fosse un’offerta per placare l’ira del destino), al tema della prolungata sofferenza senza spargimento di sangue (Teddy e Don catturano Michelle e la percuotono, rasandole i capelli, ma cercano di non ucciderla subito, quasi volessero “spremere” da lei una rivelazione o un cambiamento – questo riecheggia il dettaglio di non far colare sangue dal toro nella bugonia, prolungandone l’agonia). E soprattutto, l’atto conclusivo del film rispecchia in modo oscuro la struttura della bugonia: dal sacrificio dell’umanità (la strage finale) rinasce la vita delle api, le quali nel montaggio conclusivo vengono mostrate ritornare agli alveari e ripopolare la Terra vuota. L’antico rituale viene così, in un certo senso perverso, messo in scena su scala globale: non più un toro, ma l’intera umanità viene “immolata” affinché le api possano rifiorire e il pianeta si rinnovi senza di noi. Lanthimos quindi prende il simbolo classico di morte-rinascita e lo applica in maniera radicale, nichilista: se l’uomo è il toro marcio che avvelena il mondo, allora eliminando l’uomo (il grande sacrificio finale operato dagli alieni) la natura potrà rinascere (le api salve, i fiori di nuovo impollinati). È una bugonia cosmica, con un retrogusto amaro: ciò che rinasce non è la nostra società, ma qualcosa dopo di noi.
Prima però di arrivare a discutere in dettaglio quel finale e il suo senso filosofico, proseguiamo nell’esplorare altri livelli dell’opera. Abbiamo chiarito cos’è la bugonia sul piano storico-mitologico e perché il titolo non è affatto arbitrario: è il fulcro metaforico del film, che getta un’ombra di significato su tutta la vicenda (le api di Teddy, il tema del sacrificio, la dicotomia vita/morte). Con in mente questa chiave di lettura, possiamo ora addentrarci in un altro aspetto fondamentale di Bugonia: il suo dialogo con la storia del cinema, ovvero le numerose citazioni e riferimenti che arricchiscono l’esperienza visiva per lo spettatore cinefilo. Lanthimos è notoriamente un regista cinefilo ed eclettico, e in Bugonia sembra divertirsi a giocare con i rimandi ad altri film e generi, in un gioco intertestuale tipicamente postmoderno. Nel prossimo capitolo, dunque, passeremo in rassegna queste citazioni cinematografiche, per scoprire come Bugonia si collochi in una tradizione di opere precedenti e cosa evochi attraverso queste somiglianze volute.
Echi e citazioni cinematografiche in Bugonia
Guardando Bugonia, un appassionato di cinema può provare la gioia quasi fanciullesca di chi, durante una caccia al tesoro, scorge in un angolo luccicare un indizio familiare. Lanthimos ha disseminato il suo film di riferimenti, omaggi e suggestioni che richiamano altri celebri lavori cinematografici. Questi richiami non sono mai pedissequi o gratuiti: al contrario, s’integrano organicamente nella storia, arricchendola di ulteriori stratificazioni di senso. Di seguito esploreremo le principali citazioni e influenze dichiarate (o sottintese) presenti in Bugonia, dalle più evidenti alle più sfumate, spaziando tra generi diversi – dal thriller hitchcockiano alla fantascienza classica, dall’horror psicologico anni ’90 al cinema distopico, fino alle influenze dei maestri come Kubrick e dei contemporanei come Aster o i Coen. È un viaggio affascinante che dimostra come Bugonia sia un film postmoderno nel vero senso della parola: consapevole del cinema che l’ha preceduto e desideroso di dialogare con esso, citandolo e rielaborandolo creativamente.
Il nodo scorsoio di Hitchcock: due cospiratori in una stanza
Uno dei primi accostamenti che Bugonia suscita è con il cinema di Alfred Hitchcock, in particolare con un film del 1948 divenuto celebre per la sua unità di luogo e la tensione continua: Nodo alla gola (Rope). Perché proprio Rope? In apparenza, la trama di Bugonia è diversa – qui abbiamo un rapimento con sequestro in cantina, lì avevamo un assassinio nascosto in salotto durante una festa. Eppure la struttura di base presenta sorprendenti somiglianze: in entrambi i casi ci sono due giovani cospiratori che commettono un grave crimine insieme, condividendo un segreto mostruoso; c’è una vittima presente (nel caso di Rope, il cadavere nascosto in un baule attorno a cui si svolge l’azione; in Bugonia, la CEO Michelle viva ma tenuta prigioniera e legata in cantina); e c’è un ambiente quasi teatrale, chiuso, dove si consuma un gioco di nervi intenso. Hitchcock girò Rope in modo sperimentale, simulando un unico lungo piano-sequenza in tempo reale dentro l’appartamento dei protagonisti, per aumentare il senso di claustrofobia e di coinvolgimento dello spettatore. Lanthimos, pur non adottando la stessa tecnica, ottiene un effetto non dissimile quando focalizza gran parte del film nella casa isolata di Teddy e Don, soprattutto nel basement angusto dove Michelle è incatenata. La macchina da presa indugia su lunghe scene di dialogo teso tra carcerieri e prigioniera, creando un’unità di luogo e tempo che amplifica la suspense. Si ha quasi l’impressione di assistere a una pièce teatrale dell’assurdo, dove da un momento all’altro qualcosa può andare storto.
In Rope, i due assassini (interpretati da John Dall e Farley Granger) hanno un rapporto di dominante e dominato: Brandon è freddo, vanitoso, convinto dell’“omicidio come arte”, mentre Phillip è più fragile, tormentato dal rimorso e dal timore di essere scoperto. Anche in Bugonia riconosciamo una dinamica simile tra Teddy e Don. Teddy (Jesse Plemons) è l’ideologo carismatico, colui che trascina l’altro nel piano folle; Don (Aidan Delbis) è l’esecutore fedele ma interiormente combattuto, talvolta dubbioso sul piano o sul grado di violenza da impiegare. C’è persino una scena in cui Don, vedendo Michelle sofferente, mostra esitazione e pietà, chiedendo a Teddy se non stiano andando “troppo oltre” – e ciò funge da reminder morale, come nota un critico: Don in fondo è la voce di una coscienza residua, colui che ricorda a Teddy che “anche nel suo universo paranoico c’è un limite da non superare”. Questo elemento richiama fortemente Phillip di Rope, che durante la festa non riesce a mascherare il turbamento e quasi confessa ad alta voce, spinto dal senso di colpa. In Bugonia, Don non arriva a tradire Teddy (almeno non intenzionalmente), ma il conflitto interiore lo logorerà fino a spingerlo a un gesto estremo (il suicidio improvviso di fronte a Michelle). Tale gesto – il colpo di pistola con cui Don si toglie la vita – echeggia la tensione crescente di Rope che esplode quando il complotto viene infine svelato. In entrambi i film, la presenza di un “terzo elemento” avvia la catastrofe: in Rope è l’intuito del professor Rupert Cadell (James Stewart) che smaschera i giovani; in Bugonia è Michelle stessa, astuta e manipolatrice, che instilla in Don un dubbio morale tale da spezzarlo. Anche la messa in scena presenta analogie: Hitchcock posizionava la cinepresa in angoli bassi per cogliere i volti colti nel thrill della colpa; Lanthimos, nelle scene d’interrogatorio, riprende Teddy dal basso e Michelle dall’alto, invertendo i ruoli consueti (il carnefice appare enorme e minaccioso dal basso, la vittima piccola e in posizione elevata quasi fosse un’icona sacra da giudicare). Questa scelta visiva può ricordare il modo in cui Hitchcock giocava con le inquadrature per trasmettere potere o vulnerabilità dei personaggi in spazi ristretti.
Al di là di Rope, la presenza di Hitchcock si sente anche nel miscuglio di suspense e humor macabro. Il rapimento di Michelle non è privo di momenti ironici: ad esempio, Teddy e Don la rapiscono indossando ridicole maschere fatte in casa e tute da ginnastica luride, un’immagine che potrebbe stare in una commedia nera. Lo stesso Hitchcock amava inserire ironia nei suoi thriller più cupi – pensiamo al dialogo surreale sul ruolo dell’omicidio come esperienza intellettuale in Rope, che ha un tono sottilmente comico nella sua morbosità. In Bugonia, l’umorismo nero affiora quando i due rapitori, per convincersi e prepararsi al gesto terribile, recitano tra loro frasi ad effetto e pseudoscientifiche (come l’idea che “i capelli lunghi sono l’antenna con cui gli alieni comunicano” – motivo per cui rasano a zero la povera Michelle appena catturata). Questa trovata – apparentemente folle – è in realtà una strizzata d’occhio ai cliché dei film di fantascienza B-movie, e insieme una situazione che genera uno humor scomodo: lo spettatore ride nervosamente di fronte alla serietà con cui Teddy e Don credono a tali assurdità. Hitchcock sarebbe fiero: prendere la tensione e allentarla con un sorriso raggelante era una sua specialità.
In conclusione di questo parallelo, si può dire che Bugonia non imita Nodo alla gola, ma ne echeggia lo spirito. L’unità spazio-temporale con due complici e un segreto orribile, la dialettica psicologica tra manipolatore e coscienza debole, e la calibratura di suspense claustrofobica e ironia nerissima – tutto ciò fa pensare a un ideale ponte fra Lanthimos e Hitchcock. È come se il regista greco avesse preso la lezione hitchcockiana del “far esplodere la bomba che tutti vedono ticchettare sotto il tavolo” e l’avesse applicata alla bomba metaforica (e poi letterale) che cova nel seminterrato di Bugonia.
Fantascienza anni ’60: Morlock, Eloi e scimmie parlanti
Un’altra fonte di ispirazione per Bugonia affonda nel filone della fantascienza classica, in particolare quella degli anni Sessanta, periodo in cui il cinema di genere rifletteva in modi allegorici le ansie sociali e le paure apocalittiche del tempo (piena Guerra Fredda, incubo nucleare, trasformazioni culturali). Due titoli in particolare emergono come possibili riferimenti evocati da Lanthimos: The Time Machine (1960) e Planet of the Apes (1968). Vediamo perché.
Ne L’uomo che visse nel futuro (titolo italiano di The Time Machine), tratto dal romanzo di H.G. Wells, il protagonista viaggia nel lontanissimo futuro e scopre che l’umanità si è evoluta in due razze: gli Eloi, esseri superficiali che vivono in superficie in uno stato di ingenua beatitudine, e i Morlock, creature mostruose che vivono sottoterra e allevano gli Eloi come bestiame, cibandosi di loro. Questa potente metafora di classismo e sfruttamento (i Morlock come ex proletari oppressi divenuti mostri, gli Eloi come discendenti dell’élite decadenti e prede) può sembrare lontana da Bugonia, eppure c’è un curioso parallelo: Teddy e Don, due uomini di condizione modesta (Teddy vive in maniera semplice, fa il magazziniere per la ditta di Michelle; Don è un giovane precario) rappresentano un po’ i “subalterni” della società. Essi vivono quasi in un mondo a parte, isolati nella loro casetta di campagna, un mondo che potrebbe metaforicamente essere “il sottosuolo” (la loro casa è vecchia e sporca, soprattutto la cantina dove passano molto tempo è letteralmente sotto terra). Michelle, invece, incarna la classe dirigente, i potenti che vivono “in alto” – e infatti ci viene mostrata inizialmente nella sua villa ultra-moderna, tra palestra privata e comfort di lusso. Quando Teddy e Don la rapiscono e la trascinano nel loro seminterrato, è difficile non pensare ai Morlock che portano giù gli Eloi nel buio. C’è perfino una battuta tagliente in cui Teddy, irritato dalla presunzione di Michelle, le dice qualcosa come: “Noi siamo i mostri che vivono nell’ombra, quelli di cui la tua gente non vuole sapere nulla”. Questa frase riecheggia la dinamica Eloi/Morlock, dove ognuno agli occhi dell’altro è mostruoso: per i Morlock gli Eloi sono cibo; per gli Eloi i Morlock sono demoni terrificanti sotto terra. In Bugonia, Teddy vede Michelle come un alieno lucertola malvagio, Michelle vede Teddy come un pazzo fanatico sporco e violento – due specie diverse incapaci di comprendersi. L’accostamento non è mai esplicitato, ma un appassionato di fantascienza coglierà l’analogia di fondo. Inoltre, l’idea del sottosuolo come rifugio dei paria e luogo di cospirazione contro chi sta “sopra” ha attraversato molta narrativa (si pensi anche a Metropolis di Lang, altro antecedente: operai nel sottosuolo, elite in superficie). Bugonia la ripropone in chiave contemporanea: i “Morlock” qui sono complottisti isolati, i “padroni/Eloi” sono i CEO ricchi e apparentemente sereni nel loro mondo patinato. Quando poi i ruoli si invertono e i “Morlock” prendono il controllo – ovvero quando Teddy e Don incatenano letteralmente il rappresentante dell’élite e ne dispongono a piacimento – la fantasia di rivalsa tipica di certa fantascienza sociale si realizza, anche se temporaneamente e in modo distorto.
Passando a Il pianeta delle scimmie, qui il collegamento con Bugonia è forse ancora più tematico. Il film del 1968 (dal romanzo di Pierre Boulle) racconta di un futuro in cui la Terra è dominata da scimmie evolute e gli esseri umani sono una specie inferiore ridotta a selvaggi muti, finché un astronauta del passato non scopre la terribile verità: i ruoli si sono invertiti e la civiltà umana è collassata (celeberrima la scena finale con la Statua della Libertà semisommersa nella sabbia). Il pianeta delle scimmie è una satira feroce sulla natura umana, che in un ribaltamento (le scimmie civilizzate, gli uomini bestiali) mostra i nostri difetti dall’esterno. Bugonia ha un’anima simile: anch’esso presenta il potenziale ribaltamento del rapporto umani/animali o umani/esseri superiori. Nel nostro caso, gli “alieni” Andromedani (se esistono davvero come specie superiore) guardano agli umani un po’ come le scimmie guardavano agli uomini nel film del ’68: esseri rozzi, distruttivi, non meritevoli di pietà. Michelle, specialmente nel monologo finale quando confessa la storia della sua razza, sostiene che non sono gli alieni a voler distruggere l’umanità – anzi, sarebbero venuti per aiutarla – ma che “gli umani stanno distruggendo la Terra, gli animali e loro stessi da soli, con guerre, inquinamento, ecc.”, tanto che forse l’umanità è un esperimento fallito e merita di essere abbandonata al proprio destino. Questo riecheggia il tema di Planet of the Apes: “avete distrutto voi stessi, maledetti maniaci!” come grida Charlton Heston di fronte ai resti della Statua della Libertà. Nel film di Schaffner, la colpa dell’umanità era stata la guerra atomica; in Bugonia, più attuale, la colpa è la somma di crisi ambientale, avidità corporativa (rappresentata da Michelle stessa, che è sia aliena sia CEO di Big Pharma), disuguaglianze sociali. In ambo i casi, però, l’idea è che la specie umana ha fallito e qualcuno dall’esterno la giudica.
Non solo: la scena finale di Bugonia è un diretto rimando all’immaginario apocalittico di Planet of the Apes e anche di un altro classico, Dr. Strangelove di Kubrick (che citava la canzone “We’ll Meet Again” su immagini di esplosioni nucleari). In Bugonia vediamo – dopo che Michelle, rivelatasi imperatrice aliena, decide di porre fine all’“esperimento Terra” – la sequenza in cui ogni essere umano sul pianeta cade a terra morto all’istante, in una sorta di sterminio di massa incruento ma totale. Segue un lungo montaggio di immagini del mondo pieno di cadaveri abbandonati nelle strade, nei luoghi quotidiani, mentre in sottofondo suona la canzone pacifista “Where Have All the Flowers Gone?” cantata da Marlene Dietrich. È impossibile non pensare all’ultimo atto di Il pianeta delle scimmie (dove Heston scopre che la civiltà umana è scomparsa) o al montaggio finale di Strangelove. C’è lo stesso intento di colpire lo spettatore con un’immagine grottesca e potente: il mondo post-umano. In Planet of the Apes, il mondo post-umano è governato dalle scimmie (perciò quell’opera aveva comunque una continuazione, una ciclicità: l’uomo cade, un’altra specie sale). In Bugonia, vediamo segno che la natura continua – le api tornano agli alveari, la Terra “respira” senza l’uomo. Il cerchio si chiude: gli esseri umani sono stati spazzati via come parassiti, e le api, simbolo di armonia naturale, possono rifiorire. È un finale comicamente cupo, che sembra uscito da un incubo di fantascienza anni ’60: in quegli anni c’erano film audaci che terminavano con l’umanità distrutta (oltre a Planet of the Apes, anche film come L’ultima spiaggia o lo stesso Strangelove). Lanthimos recupera quel coraggio narrativo e quell’ironia macabra tipica della fantascienza distopica di mezzo secolo fa, attualizzandola ai timori odierni (il collasso ecologico).
C’è persino un dettaglio visivo interessante: nel conto alla rovescia degli ultimi tre giorni, Bugonia mostra di volta in volta un’immagine del globo terrestre che diventa sempre più piatto, come se si stesse trasformando in una sorta di disco. Questo simpatico particolare – la Terra che diventa piatta – può essere letto come una satira verso le teorie cospirazioniste (il terrapiattismo, appunto, tra le tante credenze “alternative” sul mondo) e strizza l’occhio alla fantascienza retrò in cui spesso comparivano rappresentazioni fantasiose del pianeta. E chissà, magari è un’allusione voluta a Il pianeta delle scimmie dove l’astronauta crede inizialmente di essere su un pianeta alieno per poi scoprire che era sempre la Terra: in Bugonia Teddy è convinto che la Terra sia sotto attacco alieno e che persino la sua forma stia cambiando (diventa piatta nei suoi deliri), per poi scoprire (troppo tardi) che la minaccia era reale ma in forma diversa da come la immaginava.
In definitiva, le influenze della fantascienza anni ’60 in Bugonia servono a contestualizzare il film in un filone che usa scenari estremi e twist finali pessimisti per criticare l’umanità. Lanthimos sembra dire: come i classici di quell’epoca riflettevano le paranoie e i sensi di colpa del loro presente, così Bugonia riflette i nostri, parlando di api che muoiono (metafora dell’ambiente che collassa) e di hubris umana punita. E nel farlo, cita con rispetto e arguzia visiva quelle opere seminali, permettendo ai cinefili di cogliere un ulteriore livello di lettura.
Labirinti mentali: Allucinazione perversa, Brazil e Il processo
Bugonia non è un film di genere facilmente classificabile: è thriller, è commedia nera, è dramma psicologico, è un po’ fantascienza distopica. Questa commistione di toni richiama alla mente anche pellicole dal sapore onirico e surreale di decenni più tardi rispetto agli anni ’60. In particolare, emergono affinità con film che esplorano la realtà deformata dalla psiche, l’incubo burocratico o allucinatorio che riflette un trauma. Tre titoli spiccano tra le possibili fonti d’ispirazione o paralleli: Allucinazione perversa (Jacob’s Ladder, 1990), Brazil (1985) di Terry Gilliam, e Il processo (1962) di Orson Welles, tratto dal romanzo di Kafka. Ciascuno di questi offre una lente attraverso cui osservare momenti e aspetti di Bugonia.
Allucinazione perversa di Adrian Lyne è un viaggio nelle spaventose visioni di un uomo (interpretato da Tim Robbins) reduce dal Vietnam, che sperimenta flashback e allucinazioni demoniache mentre la realtà attorno a lui si fa sempre più incerta. Senza rivelare troppo quel film, diciamo che esso ruota attorno a concetti di trauma, sperimentazione segreta (si scopre che il protagonista fu vittima di un esperimento con droghe chimiche per aumentare l’aggressività dei soldati, chiamato “La scala di Giacobbe”) e una continua mescolanza di incubo e realtà. In Bugonia, la dimensione onirica è meno esplicita – non abbiamo draghi o demoni con teste oscillanti come in Jacob’s Ladder – ma c’è una forte componente di paranoia allucinatoria. Teddy vive in un mondo interpretato attraverso il filtro del suo trauma e delle sue ossessioni: egli vede segni ovunque (le api che muoiono non sono un fenomeno naturale, ma “prove” del complotto; i podcast e siti cospirazionisti che consulta confermano i suoi timori fino alla paranoia). Questa condizione mentale può essere assimilata a una sorta di allucinazione paranoide condivisa. La regia di Lanthimos sottolinea a tratti la soggettività distorta di Teddy con brevi flashback in bianco e nero che mostrano frammenti della sua memoria – in particolare, scene legate alla madre Sandy (Alicia Silverstone) durante il trial farmaceutico che l’ha ridotta in coma. Questi inserti monocromatici, quasi onirici, interrompono la narrazione “presente” come delle schegge intrusive, proprio come in Jacob’s Ladder i ricordi della guerra e visioni infernali interrompevano la quotidianità del protagonista. Inoltre, Bugonia contiene almeno una sequenza di forte impatto surreale: quella in cui Michelle, dopo essere fuggita temporaneamente dalle sue catene, scopre la “camera segreta” di Teddy con i resti dei precedenti soggetti delle sue folli sperimentazioni. Immagini di corpi e pezzi umani conservati – trofei o vittime – rivelano che Teddy non è nuovo alle atrocità. Questa scena ha la qualità di un incubo, in cui il malcapitato (qui Michelle) si aggira in un luogo oscuro scoprendo l’orrore estremo dietro la facciata. Ricorda, per tono, momenti di Jacob’s Ladder in cui il protagonista esplora luoghi inquietanti (come l’ospedale deformato, coi corpi macellati attorno). Non sto suggerendo che Lanthimos abbia voluto omaggiare direttamente Lyne, ma di certo c’è una parentela: Bugonia è, tra le altre cose, il ritratto di una psiche traumatizzata e dissociata (quella di Teddy, e in parte quella di Don) che impone la propria visione distorta sul reale. In Jacob’s Ladder, l’intera realtà era forse una costruzione allucinatoria (c’è una celebre interpretazione per cui tutto il film sarebbe il delirio di un morente); in Bugonia, fino a un certo punto, lo spettatore potrebbe anche credere che gli alieni non esistono affatto e siano solo la costruzione delirante di Teddy – ipotesi che renderebbe Bugonia quasi un Jacob’s Ladder in cui il protagonista si è inventato un nemico per dare senso al suo dolore. Naturalmente poi il finale smentisce questo, mostrando che gli alieni esistono davvero. Ma fino ad allora il film gioca sul confine: noi vediamo la storia prevalentemente attraverso la prospettiva di Teddy e Don, cioè di due personaggi inaffidabili, il che genera un clima di incertezza simile a un’allucinazione condivisa. Questo aspetto “mentale” di Bugonia ci invita a interpretare molte scene su due livelli: quello letterale (stanno davvero combattendo alieni) e quello psicologico simbolico (stanno esternando i propri demoni interiori). In altre parole, Bugonia può essere letto come un’enorme metafora psicotica, dove gli alieni sono il capro espiatorio inventato per reggere il peso di troppi traumi – esattamente come il protagonista di Jacob’s Ladder vedeva demoni e complotti perché non poteva affrontare direttamente il trauma della guerra e della propria morte.
Veniamo a Brazil, l’opera visionaria di Terry Gilliam. Brazil è ambientato in un futuro distopico altamente burocratizzato, dove un impiegato, Sam Lowry (Jonathan Pryce), evade la grigia realtà tramite sogni di eroismo e amore, finché non si ritrova braccato e infine catturato da un sistema totalitario assurdo. Il film alterna toni grotteschi, satira del consumismo e della burocrazia, humour nero e momenti di autentica tragicità onirica. L’accostamento con Bugonia può sembrare curioso, dato che Brazil è su larga scala sociale e politica, mentre Bugonia è un dramma concentrato su pochi individui. Ma ci sono elementi paralleli: innanzitutto, Brazil condivide con Bugonia la critica di un sistema oppressivo (in Brazil lo Stato burocratico e tecnologico che opprime l’individuo; in Bugonia la corporazione farmaceutica e in generale le élite che opprimono le persone comuni e la natura). Michelle rappresenta un po’ la “burocrate” senz’anima, con il suo linguaggio corporate passivo-aggressivo che fa infuriare Teddy, non diversamente dai funzionari ottusi di Brazil che parlano gergo amministrativo mentre compiono atti atroci. C’è una vena di satira sociale in come Bugonia dipinge Michelle: anche legata nuda a un letto, rasata e umiliata, lei continua a usare il linguaggio manageriale, a fare la gaslighting psicologica su Teddy come fosse in una riunione d’ufficio – il che la rende quasi un personaggio da commedia nera alla Gilliam. Inoltre, Brazil è celebre per il suo finale in cui (SPOILER) Sam Lowry viene torturato e lui si rifugia in un sogno di fuga: la realtà è insopportabile, quindi la mente la nega. In Bugonia, dopo la sequenza terribile dell’antigelo (dove Teddy, manipolato, avvelena sua madre credendo di salvarla), Teddy ha un crollo psicologico. Non vediamo sogni di fuga come in Brazil, ma percepiamo che la sua adesione al piano vacilla: egli stesso comincia a sembrare confuso su cosa sia reale e cosa no, specie quando Michelle successivamente gli “confessa” di essere aliena e racconta una storia complessa. In quella scena, la realtà potrebbe di nuovo essere ambigua: Teddy è devastato, e Michelle potrebbe star mentendo per manipolarlo oppure dicendo la verità; sta di fatto che Teddy appare quasi catatonico, come Sam Lowry sul finale di Brazil. I ruoli si ribaltano: chi è ora il prigioniero? Teddy spiritualmente lo diventa, preso nella narrazione di Michelle. Insomma, Bugonia a tratti sembra un delirio satirico dove le posizioni di potere sono capovolte e ricapovolte, in stile Gilliam. A livello visivo, poi, Lanthimos costruisce alcuni ambienti che ricordano Brazil: la casa di Michelle è tutta design minimalista e lussuoso – quasi eccessivamente fredda e modern, proprio come l’appartamento della madre di Sam Lowry in Brazil pieno di orpelli cosmetici e tecnologia vacua. E quando Michelle porta Teddy nel suo ufficio high-tech con l’ascensore e il misterioso armadio che fungerebbe da teletrasporto, sembra di entrare in uno scenario alla Gilliam, surreale e beffardo (difatti la scena sfocerà in una beffa: il “teletrasporto” era una trappola, Teddy entra e… boom!). Anche il registro di Bugonia, che mescola temi serissimi (ecocidio, follia, dolore) con momenti da fumetto grottesco (Teddy e Don che indossano tute argentate sporche sembrano due cosplayer malridotti; il contatore numerico premuto come teletrasporto è volutamente ridicolo), richiama quell’umorismo dark e camp di Brazil.
Infine, parliamo de Il processo di Orson Welles, tratto dall’omonimo romanzo di Franz Kafka. Qui siamo nel regno dell’assurdo giudiziario: Joseph K. (Anthony Perkins) viene arrestato senza sapere il motivo e trascinato in un labirinto legale grottesco che lo porterà a una fine tragica. In Bugonia troviamo il concetto di processo invertito: Teddy imprigiona Michelle per “processarla” – infatti lui la interroga come un giudice di un tribunale rivoluzionario, accusandola di ogni peccato (dall’avvelenare le api all’avvelenare la madre al far parte di un complotto intergalattico). Michelle, legata al letto, si ritrova in un surreale processo privato dove gli accusatori sono due individui paranoici e autoproclamatisi giuria e giustizieri. Questo ribaltamento – il potente trascinato in un tribunalino clandestino – fa pensare a certe storie kafkiane al contrario, e in particolare a Il processo per l’atmosfera da incubo giudiziario. Welles, nel suo adattamento, enfatizzò l’aspetto onirico e spersonalizzante di quell’iter legale: scenografie smisurate, stanze piene di fascicoli fino al soffitto, corridoi labirintici, e il protagonista spesso ripreso con grandangoli deformanti dal basso, per apparire piccolo sotto incombenze enormi. Lanthimos, pur in scala domestica, crea qualcosa di analogo: nel basement di Teddy, Michelle è incatenata ad un letto al centro di una stanza spoglia, circondata da strumenti improvvisati e cose inquietanti (barattoli, attrezzi sporchi, cavi – un po’ come i fascicoli e i giudici deformi attorno a K.). Quando Teddy la interroga, lei appare in alcune inquadrature con gli occhi sbarrati e il capo rasato, illuminata da una luce cruda: i critici hanno notato che Emma Stone in queste scene ricorda Renée Jeanne Falconetti ne La passione di Giovanna d’Arco, ovvero un’altra prigioniera di un processo assurdo e già condannato. È come se Lanthimos avesse voluto darle un’aura di vittima sacrificale, in contrasto ironico col fatto che lei potrebbe essere il vero mostro. Ma tornando a Kafka/Welles: Il processo termina (nel libro e diversamente nel film) con l’esecuzione di K. da parte di figure del tribunale in un luogo desolato: Welles scelse di farlo saltare in aria con della dinamite, in modo crudo e teatrale. Orbene, cosa succede a Teddy in Bugonia? Egli si presenta all’ufficio di Michelle con indosso un giubbotto esplosivo – ultima follia suicida forse, un gesto da terrorista disperato – e alla fine, entrando nel presunto armadio teletrasporto, salta in aria letteralmente, dilaniato dalla sua stessa bomba (che esplode dentro la cabina). La somiglianza con l’esito del Processo wellesiano (bomba, deflagrazione come metafora di annientamento) è notevole. Anche qui, possiamo vederla come una citazione indiretta: Joseph K. vittima del tribunale muore esploso; Teddy, che aveva creato un suo tribunale privato, finisce con l’essere lui a subire un’esplosione fatale. Il suo processo si è rovesciato contro di lui. In quel momento, Michelle è come se fosse giudice e boia insieme, e Teddy diventa l’imputato condannato (per i suoi “peccati” o semplicemente per la sua inferiorità rispetto a un potere più grande). Siamo dunque sempre in ambito kafkiano, per quanto traslato nella fantascienza: il ribaltamento finale rivela un tribunale supremo alieno che giudica e condanna l’umanità intera. Quell’assemblea degli Andromedani dove Michelle riferisce e decide la sorte della Terra è in effetti l’incarnazione più cupa di un processo kafkiano: non c’è difesa, non c’è spiegazione, la sentenza è già scritta (umanità colpevole in blocco, pena: estinzione). Kafka scriveva dell’impotenza del singolo di fronte a un potere insondabile; Lanthimos ci mostra l’impotenza dell’intera umanità di fronte a un potere altro e quasi divino (gli alieni che giocano a fare Dio – e qui c’è anche eco di Ultimatum alla Terra o di giudizi universali fantascientifici).
In conclusione, Bugonia assorbe l’influenza di questi film – Jacob’s Ladder, Brazil, Il processo – nel suo tessuto stilistico e narrativo. Di Jacob’s Ladder condivide la dimensione del trauma psicologico e della percezione distorta (con tanto di sperimentazioni segrete e paranoia governativa – in Bugonia le sperimentazioni le fa la corporate aliena, in Jacob’s Ladder le faceva l’esercito sui suoi). Di Brazil riprende la satira sociale surreale e il mix di umorismo e tragedia nel destino del protagonista, vittima di un sistema troppo grande. Di Kafka/Welles riprende il senso di un giudizio assurdo che incombe e una conclusione nichilista dove il protagonista viene spazzato via. Tutto questo arricchisce Bugonia di riferimenti colti che amplificano il suo messaggio: Lanthimos riesce a far dialogare la sua opera con questi illustri predecessori, creando rime tematiche e visive che un attento spettatore può cogliere e che aggiungono profondità al racconto.
L’ombra di Stanley Kubrick
È quasi impossibile discutere di cinema postmoderno, allegorico e misantropico senza evocare il nome di Stanley Kubrick, e infatti Bugonia non fa eccezione: la critica ha subito notato il tocco “kubrickiano” nell’opera di Lanthimos, tanto che Owen Gleiberman su Variety ha scritto che Lanthimos sta lavorando nella tradizione di Kubrick, esercitando una sorta di “misantropia illuminata” nel suo film. Ma in che modo specifico Bugonia richiama Kubrick? Cerchiamo di isolare alcuni elementi, consapevoli però che l’influenza di Kubrick su Lanthimos è più di atmosfera e visione del mondo che non di puntuali citazioni di singoli film.
Un primo aspetto è la combinazione di pessimismo sull’umanità e precisione stilistica glaciale. Kubrick ha spesso esplorato l’idea che l’essere umano sia governato da pulsioni distruttive e da un’insanabile follia: che siano i generali folli di Dr. Strangelove pronti a distruggere il mondo, o la violenza innata di Alex in A Clockwork Orange, o l’incapacità di comunicare e amare genuinamente in Eyes Wide Shut, Kubrick tendeva a un giudizio piuttosto freddo sull’umanità. E faceva passare questo giudizio attraverso uno stile visivo controllatissimo, geometrico, spesso distaccato. Lanthimos fa qualcosa di analogo in Bugonia: il film è in definitiva molto arrabbiato con l’umanità, con la nostra specie, eppure non è girato in maniera scomposta o “arrabbiata” emotivamente – al contrario, è studiato, composto in ogni inquadratura, con una bellezza formale che fa da contrappunto al caos morale rappresentato. Pensiamo ad esempio alla scelta dei colori e della fotografia: Bugonia alterna la freddezza metallica (nella casa di Michelle domina il bianco, l’acciaio, il vetro) al caldo sporco e rosso ruggine del seminterrato di Teddy. Questa opposizione cromatica sottolinea razionalmente il conflitto di classe e di visione (tecnocrazia contro natura decadente), un po’ come Kubrick in 2001: Odissea nello spazio contrapponeva gli interni asettici dell’astronave alla primitiva Terra delle scimmie dell’alba dell’uomo. Kubrick era anche un maestro nell’uso della musica per creare ironia e straniamento (di nuovo, Strangelove con la canzone anni ’40 sull’Apocalisse nucleare, o Arancia Meccanica con la Nona di Beethoven su scene di ultraviolenza). Lanthimos segue la lezione: l’uso di “Where Have All the Flowers Gone?” – canzone pacifista e malinconica – sulla visione dei cadaveri umani in Bugonia è un momento degno dell’umorismo tagliente di Kubrick. Quella scena, già citata, è quasi un’aggiornamento del finale di Dr. Strangelove: lì avevamo le bombe atomiche che cadevano accompagnate da “We’ll Meet Again”; qui abbiamo i cadaveri accompagnati da Dietrich che canta dei fiori scomparsi (metafora delle giovani vite spezzate in guerra). L’effetto è di tragica ironia: lo spettatore è colpito al cuore ma anche invitato a un ghigno amaro.
Visivamente, Lanthimos adotta in Bugonia alcune soluzioni che paiono un omaggio allo stile kubrickiano. Un esempio: la cura delle inquadrature simmetriche o comunque ben architettate geometricamente. Quando la camera indugia sull’arredamento clinico di Auxolith (l’azienda di Michelle) o sui corridoi, possiamo quasi ritrovare l’eco delle celebri prospettive centrali di Shining o 2001. Anche la già menzionata trovata del countdown con la Terra che diventa piatta è presentata come una serie di schermate grafiche nitide, quasi da computer: Kubrick nei suoi film futuristici amava inserire schermate, interfacce e segnali visivi rigorosi come parte della narrazione (ad esempio, le istruzioni del bagno zero-G in 2001 o i menu del computer HAL). Bugonia forse strizza l’occhio a questa tradizione di graphic design integrato nel film. Altro dettaglio: la violenza improvvisa e scioccante punteggia Bugonia in pochi momenti chiave (ad esempio, la morte di Don con il colpo di fucile in testa, molto grafica e inattesa; l’esplosione di Teddy; la visione dei resti umani in cantina). Kubrick spesso teneva il pubblico in attesa e poi inseriva esplosioni di violenza quasi grottesche (il corpo di Gomer Pyle in Full Metal Jacket, o l’aggressione iniziale di Arancia Meccanica). Lanthimos adopera questa shock therapy in modo parco ma efficace, come avrebbe potuto fare Kubrick in un contesto simile. Si sente insomma un’eco kubrickiana nel tono misurato e insieme disturbante. Non è un caso che la critica parli di Lanthimos come uno dei continuatori di quell’approccio intellettuale e chirurgico al cinema: come Kubrick, Lanthimos costruisce parabole universali pur usando storie assurde; e come Kubrick, non ha paura di risultare sgradevole o estremo per servire la sua visione.
C’è poi un riferimento specifico a Kubrick che potremmo intravedere in Bugonia: il film Eyes Wide Shut (1999), ultimo di Kubrick, dove una setta di persone potenti compie rituali orgiastici mascherati. Nel nostro film, Teddy e Don compiono un rituale a modo loro – non sessuale, ma pur sempre travestiti (con maschere grezze) e con un intento quasi sacrale (per loro, salvare il mondo). La differenza è che in Kubrick l’élite mascherata era il villain, mentre qui i “mascherati” sono gli underdogs. Ma la sensazione di straniamento di quelle figure mascherate di notte in un contesto altrimenti mondano è simile. Non sappiamo se Lanthimos pensasse a Eyes Wide Shut, ma è un parallelo interessante notare come in Bugonia ci sia l’elemento del mascheramento e del rituale segreto che sovverte l’ordine sociale, cose che Kubrick aveva esplorato.
Infine, possiamo dire che Bugonia condivide con Kubrick un certo sguardo filosofico gelido sull’umanità. Verso la fine del film, tramite Michelle, arriva un messaggio molto kubrickiano: “Gli esseri umani non possono fare a meno di autodistruggersi”. Questo suona come qualcosa che avremmo potuto sentire in 2001 (dove un’intelligenza aliena testava gli umani per farli evolvere, ma chissà se li troverebbe degni) o in Strangelove. Ed effettivamente, la conclusione di Lanthimos è in linea con quell’idea: se non rinunciamo al nostro egoismo, allora forse meritiamo di estinguerci. Kubrick, alla fine di Strangelove, lasciava intendere proprio questo: la follia umana porta all’annientamento e la vita continuerà senza di noi (nel film germi e spore sopravvivono alle radiazioni, qui le api sopravvivono all’uomo). Lanthimos dunque, come Kubrick, allarga il discorso dai singoli personaggi all’intera specie umana, giudicandola severamente. In ciò si sente la “mano del maestro” in spirito, pur se ovviamente Bugonia è un film profondamente lanthimosiano.
Tirando le somme, Stanley Kubrick aleggia su Bugonia sia come modello stilistico (per l’eleganza formale e l’uso di musiche e simbologie), sia come riferimento tematico (misanthropia, satira bellica/umanistica, apocalisse ironica). Non è una citazione diretta come per altri film menzionati, ma piuttosto una sintonia. Lo stesso Lanthimos ha dichiarato in passato l’ammirazione per Kubrick, e qui ne fa tesoro per dare alla propria opera una risonanza che va oltre il racconto specifico, facendola entrare – umilmente ma ambiziosamente – nel dialogo con i grandi affreschi cinematografici sulla condizione umana.
Surrealismo postmoderno: da Ari Aster ai fratelli Coen
Concludiamo questa panoramica sulle citazioni cinematografiche situando Bugonia nel contesto più ampio del cinema surreale e citazionista contemporaneo, dove spiccano autori come Ari Aster e i fratelli Coen (nominati espressamente nella richiesta). Questi nomi possono sembrare distanti tra loro – Aster è un giovane regista di horror psicologici e dramma familiare, i Coen sono veterani di commedie nere, noir e pastiche di generi – eppure entrambi rappresentano modi postmoderni di fare cinema, mescolando toni e riferimenti con forte personalità.
Ari Aster, noto per film come Hereditary (2018) e Midsommar (2019), e più di recente Beau ha paura (2023), condivide con Lanthimos un interesse per la dimensione traumatica e familiare dell’orrore, nonché una propensione a inserire elementi surreali e simbolici nelle sue storie. Non a caso, Aster risulta tra i produttori di Bugonia, quasi a suggellare una fratellanza artistica. Cosa ha in comune Bugonia con i film di Aster? Molto sul piano del clima emotivo: la presenza di un trauma familiare centrale (in Hereditary la perdita e una pesante eredità occulta; in Bugonia la madre in coma e la vendetta filiale), la rappresentazione di dolore mentale che sfocia nel mostruoso (personaggi che compiono atti atroci spinti da sofferenze interiori), e uno sguardo spietato sull’inevitabilità della tragedia. Aster inoltre spesso cita estetiche di altri generi (ad esempio Midsommar cita il folk horror anni ’70 come The Wicker Man, Beau ha paura ha echi kafkiani e di tragicommedia alla Charlie Kaufman). Lanthimos fa un’operazione analoga in Bugonia con i suoi riferimenti vari, come abbiamo visto. L’etichetta di postmoderno calza bene ad entrambi: sanno usare il passato cinematografico rielaborandolo in qualcosa di nuovo e personale. Una scena di Bugonia che potrebbe essere uscita da un film di Aster è quella dell’antigelo: l’inquietante quiete con cui Teddy somministra alla madre quella “cura” letale potrebbe ricordare la tensione atroce di certe scene di Hereditary (come quando – SPOILER – il figlio guida in silenzio dopo l’incidente della sorellina, in shock). C’è la stessa sensazione di un dramma familiare intimo che si mescola all’orrore corporeo e al destino irreparabile. Ari Aster inoltre ama punteggiare i suoi film di immagini simboliche disturbanti (il colpo di scena con la testa dell’uccello in Hereditary, o certe sequenze gore in Midsommar), e Lanthimos in Bugonia fa altrettanto con i resti umani nella stanza segreta e la morte improvvisa di Don. In un certo senso, Bugonia potrebbe quasi essere immaginato come un film di Aster se questi avesse preso Save the Green Planet! e l’avesse adattato: avrebbe probabilmente mantenuto il trauma materno, la setta immaginaria (il complotto) come rifugio psicotico, e l’esito nichilista. Dunque, più che di citazioni specifiche, qui parliamo di affinità di tono e temi: lanthimos e Aster propongono entrambi un cinema che unisce l’analisi psicologica al grottesco, e che cita il passato (Aster cita i classici horror, Lanthimos cita un po’ di tutto come abbiamo visto) creando però opere nuove che parlano del presente. Non a caso, la critica ha accostato Bugonia al film immaginario di Aster chiamato Eddington – una pellicola fittizia nominata in alcuni contesti critici come esempio di film sul complottismo pandemico – suggerendo che Bugonia e quell’opera (nell’universo narrativo in cui esiste) condividono un approccio. Questo testimonia quanto Lanthimos e Aster vengano percepiti in continuità.
Quanto ai fratelli Coen, qui il legame è forse meno immediato, ma non inesistente. I Coen sono maestri nel fare film che omaggiano e al contempo parodiano i generi (il noir in Il grande Lebowski, il gangster movie in Miller’s Crossing, il western in La ballata di Buster Scruggs, etc.), mantenendo sempre una vena surreale e un humor nero particolarissimo. Bugonia non ha il tono spiccatamente comico dei Coen, ma condivide con loro la tendenza a mettere personaggi eccentrici in situazioni tragicamente comiche. Pensiamo a Fargo: due criminali maldestri rapiscono una donna e tutto va storto in modo sanguinoso – non suona vagamente come la storia di Teddy e Don? Certo, Bugonia è più serioso di Fargo, tuttavia la figura di Don il cugino ingenuo e fedele fa quasi pensare a un personaggio coeniano, uno di quei complici un po’ sempliciotti e dal cuore meno duro che finiscono male (come Steve Buscemi in Fargo, appunto). Anche la modalità con cui la vicenda criminale degenera è da commedia nera: i rapitori si fanno uccidere dal proprio stesso piano (Don si spara, Teddy si fa esplodere) – un’ironia crudele che i Coen avrebbero potuto apprezzare, loro che amano punire l’hybris dei loro antieroi con risultati beffardi. Un altro elemento coeniano è il mélange di toni: i Coen sanno farti ridere e subito dopo rabbrividire; Lanthimos fa qualcosa di simile in Bugonia, dove magari in un momento sorridi per l’assurdità di Teddy che indossa un casco ridicolo per “proteggersi dai raggi alieni”, e pochi minuti dopo assisti sconvolto a una morte orrenda. Questo altalenare è tipico di autori postmoderni che non si sentono legati a un unico registro emotivo – e i Coen ne sono esempi per eccellenza. Non a caso, Bugonia è stato definito “una giostra grottesca di idiozia umana” da un critico, definizione che potrebbe adattarsi anche a film come Burn After Reading dei Coen, dove l’insensatezza delle azioni di personaggi sciocchi porta a esiti violentissimi e inutili. Teddy e Don, pur mossi da un dolore reale, compiono atti idioti e distruttivi, e alla fine la “morale” è simile a quella che il capo della CIA pronuncia in Burn After Reading: “Quindi… che abbiamo imparato da tutto questo? … Niente, immagino.” In Bugonia, l’universo (o Lanthimos) sembra dire: “Cosa avete ottenuto, umani, con tutte le vostre violenze e paranoie? Nulla, solo la rovina.” Un fatalismo sardonico che i Coen spesso trasmettono (pensiamo al finale di A Serious Man, dove un tornado in arrivo forse annienterà tutto senza spiegazioni).
Potremmo trovare anche una micro-citazione: in Bugonia, quando Teddy e Don imbracciano il fucile e si agitano di fronte a Michelle, la critica (RogerEbert.com) li paragona a Pacino e Cazale in Quel pomeriggio di un giorno da cani, ma a me ha ricordato anche Non è un paese per vecchi dei Coen nella figura di due uomini non proprio brillanti alle prese con violenza che li supera. È una suggestione laterale, ma era per dire che l’immaginario coeniano di losers in vicende troppo grandi aleggia.
In sintesi, dire “da Ari Aster ai fratelli Coen” significa riconoscere che Bugonia si colloca in un continuum che va dall’horror psicologico surreale al crime movie grottesco, unendo elementi di entrambi. È un film citazionista perché richiama modelli passati (come abbiamo visto) ma anche autoreferenziale nel senso del suo regista: Lanthimos attinge al proprio stile già mostrato in film come The Lobster o Il sacrificio del cervo sacro (che pure avevano quell’aria coeniana di humor nero e quell’aria asteriana di situazione familiare disturbante). I Coen e Aster qui fungono da indicatori di coordinate: i Coen per l’aspetto dark comedy e postmodern pastiche, Aster per l’aspetto horror psicologico e allegorico contemporaneo. Bugonia riesce a sposare questi lati, risultando un’opera che può soddisfare sia chi cerca un thriller allegorico ricco di riferimenti, sia chi ama il cinema d’autore più insolito, dove l’ibridazione di toni è veicolo di originalità.
Abbiamo dunque visto come Bugonia dialoghi con una pluralità di opere e autori: da Hitchcock e la golden age hollywoodiana fino ai nostri giorni, passando per la fantascienza classica e i maestri visionari come Gilliam o Kubrick. Questa rete di citazioni non è semplice esercizio di stile, ma parte integrante del linguaggio postmoderno del film, che si costruisce per accumulo di senso e rimandi. Ogni citazione rafforza un tema: Rope enfatizza la claustrofobia e la relazione tra complici, Planet of the Apes e Brazil evidenziano la critica sociale e la fine del mondo, Jacob’s Ladder e Il processo sottolineano il labirinto mentale e giudiziario, Kubrick e Coen forniscono il timbro di qualità nella misantropia raffinata e nell’umorismo nero. Lanthimos orchestra tutti questi elementi in una sinfonia cinematografica coerente e personale.
Con questa consapevolezza intertestuale, siamo pronti a esaminare un aspetto specifico cruciale: la natura di Bugonia come remake di un film precedente (Save the Green Planet!), e ciò che questo comporta in termini di originalità, citazione e poetica postmoderna. Questo sarà oggetto del prossimo capitolo, prima di immergerci infine nella profonda analisi psicologica della trama e dei personaggi.
Riferimenti a Hitchcock e al Nodo alla gola di Alfred Hitchcock
Uno dei filoni cinefili più evidenti in Bugonia è l’eco del cinema di Alfred Hitchcock, in particolare del classico Nodo alla gola (Rope, 1948). Come nel film di Hitchcock, Bugonia costruisce una tensione crescente in uno spazio ristretto e quasi teatrale: gran parte dell’azione si svolge infatti all’interno di una casa isolata, precisamente nel seminterrato dove la rapita Michelle viene tenuta prigioniera. La situazione ricorda da vicino la premessa di Nodo alla gola, in cui due studenti assassinano un compagno di classe e nascondono il cadavere in un baule, organizzando poi un’elegante cena nello stesso appartamento per provare il brivido di farlo sotto gli occhi degli ospiti ignari. In Bugonia non c’è un cadavere occultato, ma troviamo comunque un “elefante nella stanza”: la presenza di una donna legata e rasata, creduta un’aliena, che viene coinvolta in una surreale cena conviviale con i suoi rapitori. Questa scena a tavola è costruita su dialoghi carichi di doppio senso e falsa cortesia, riprendendo proprio il modello hitchcockiano di tensione sotto la superficie delle buone maniere. Come sottolinea Gabriele Niola, in Bugonia la cena diventa una “battaglia intellettuale, fatta di conversazioni, ma anche una battaglia reale, fatta d’azione”, in cui Plemons e Stone recitano “a due livelli di profondità: ognuno ha un fine da raggiungere con la conversazione, ma deve nascondere le intenzioni dietro le buone maniere”. Lo spettatore coglie così il contrasto tra ciò che i personaggi dicono e ciò che realmente intendono, un meccanismo di suspense che Hitchcock padroneggiava alla perfezione.
Visivamente, Lanthimos sembra omaggiare l’esperimento tecnico di Rope: il film di Hitchcock era celebre per i suoi lunghi piani-sequenza montati per apparire come un’unica ripresa in tempo reale. Anche Bugonia adotta in diverse sequenze uno stile fatto di piani prolungati e movimenti di macchina fluidi, accentuando la sensazione di assistere in diretta al confronto psicologico tra i personaggi. L’unità di luogo – la maggior parte del film si svolge in cantina, con poche incursioni all’esterno – e l’unità di tempo (ci sono continui riferimenti a una scadenza imminente, l’eclissi lunare entro quattro giorni) richiamano la concentrazione drammatica di un testo teatrale, proprio come Nodo alla gola era originariamente tratto da un’opera teatrale di Patrick Hamilton. Inoltre, il rapporto tra i due rapitori in Bugonia – Teddy, il cervello fanatico, e il cugino Don, mentalmente più debole e manipolabile – può ricordare la dinamica tra i due studenti assassini di Rope, uno carismatico e dominante, l’altro più insicuro e succube. In entrambi i casi, una coppia di complici condivide un oscuro segreto che li lega in una tensione crescente fino al climax.
Infine, vale la pena notare un parallelo tematico: in Rope i protagonisti commettono un omicidio ispirati da un’ideologia distorta ( l’idea del delitto come privilegio di pochi “eletti”), mentre in Bugonia il rapimento nasce da una convinzione paranoide complottista. In entrambe le storie, il delitto o atto criminale viene giustificato dai perpetratori come un gesto quasi “necessario” o intellettualmente coerente con la propria visione del mondo. Questo rende i dialoghi carichi di ironia tragica: in Nodo alla gola gli assassini e il loro ex professore discutono accanto a un cadavere sul concetto del delitto perfetto; in Bugonia rapitore e vittima dibattono di cospirazioni aliene e crimini industriali mentre ognuno finge una calma civile. L’ispirazione hitchcockiana emerge dunque sia nello stile registico – fatto di spazi chiusi e tempi dilatati per aumentare la suspense – sia nella struttura di dialoghi e situazioni carichi di drammaticità sotto la facciata dell’ordinario. Lanthimos, noto per il suo humor nero e la messa in scena rigorosa, sembra raccogliere questa eredità di Hitchcock per tenerci “col fiato sospeso” nella cantina di Bugonia, in bilico tra paura e ironia sottile.
Rimandi alla fantascienza anni ’60: dai Morlock ai post-umani
Oltre ai richiami al thriller classico, Bugonia si inserisce anche nel solco della fantascienza anni ’60, omaggiandone l’estetica e i temi attraverso riferimenti sottili. In particolare, la figura degli esseri alieni nascosti tra noi richiama molti immaginari fantascientifici del dopoguerra, epoca in cui il cinema e la TV popolari spesso rappresentavano paure di invasioni e mutazioni. Un riferimento esplicito evocato dal film è The Time Machine (1960) di George Pal, tratto dal romanzo di H.G. Wells. In quella storia il protagonista viaggia nel futuro fino all’anno 802.701 e scopre che l’umanità si è evoluta in due specie: gli Eloi, gente superficiale e pacifica che vive in superficie, e i Morlock, creature mostruose e pelose che vivono nel sottosuolo e allevano gli Eloi come bestiame da macello. Questa visione cupa – con esseri post-umani deformi che predano altri esseri umani – costituisce un potente archetipo di paura evolutiva e di critica sociale (in Wells, era una metafora delle divisioni di classe). Bugonia sembra capovolgere e insieme riecheggiare quel paradigma: i rapitori Teddy e Don potremmo vederli come moderni “Morlock” improvvisati, che si ribellano contro un’élite tecnologica indifferente (la CEO Michelle e la sua corporazione) proprio come i Morlock si ribellavano contro gli Eloi. Allo stesso tempo, la rivelazione finale di Bugonia – spoiler alert: Michelle è davvero un’aliena, anzi l’imperatrice di un’altra specie – ripropone l’idea di una razza superiore nascosta che alleva gli umani come cavie, non diversamente da come i Morlock allevavano gli Eloi per nutrirsene. Anche se nel film di Lanthimos gli alieni Andromediani non vengono mostrati come creature bestiali e pelose, concettualmente essi svolgono un ruolo simile di predatori dell’umanità, decretandone infine lo sterminio perché considerano fallito “l’esperimento umano”. È un’eco diretta di tanta fantascienza classica dove la specie umana veniva messa di fronte alla propria insignificanza o degenerazione di fronte a intelligenze superiori.
Un altro tocco che rievoca i sixties è l’uso di elementi visivi e sonori dal sapore retro. Ad esempio, la scena in cui Michelle (una volta tornata libera in ufficio) attiva il teletrasporto digitando un numero lunghissimo su una semplice calcolatrice tascabile – un espediente volutamente bizzarro – strappa un sorriso e sembra un omaggio ironico alla tecnologia ingenua della fantascienza d’altri tempi. Negli anni ’60 spesso i dispositivi fantascientifici apparivano come macchinari semplici o oggetti quotidiani modificati: la trovata di Lanthimos di far usare alla sua aliena un calcolatorino per aprire un portale spaziale può ricordare le soluzioni creative (e un po’ low-tech) di serie TV d’epoca come Doctor Who o episodi di The Outer Limits. Anche la colonna sonora nel finale di Bugonia contribuisce a questo richiamo temporale: sulle immagini apocalittiche degli esseri umani che crollano a terra morti istantaneamente, Lanthimos inserisce “Where Have All the Flowers Gone?” cantata da Marlene Dietrich. Questa è una celebre canzone pacifista dei primi anni ’60, simbolo del movimento contro la guerra – un riferimento culturale che colloca emotivamente la scena in un contesto di disillusione storica. L’uso di quel brano evoca la malinconia post-bellica e la domanda “dove sono finiti tutti i fiori?” riecheggia, in modo beffardo, la domanda “dove sono finiti tutti gli uomini?”. In Bugonia, infatti, alla fine gli esseri umani svaniscono e rimangono solo le api a popolare un mondo silenziosotime.com. È un finale comicamente cupo, che diversi critici hanno definito audace per un film contemporaneo, paragonandolo ai finali pessimisti tipici della fantascienza e dell’horror anni ’60-’70. Basti pensare al finale del pianeta delle scimmie in Planet of the Apes (1968), dove il protagonista Charlton Heston scopre la Statua della Libertà distrutta e capisce di essere sulla Terra post-nucleare: lì gli scimmioni evoluti avevano preso il posto dell’uomo come specie dominante, riducendo gli umani a primitivi muti e schiavizzati. Bugonia offre una variazione altrettanto drastica: gli alieni prendono atto del fallimento dell’umanità e la eliminano in un colpo solo, lasciando dietro di sé un pianeta vuoto pronto a rigenerarsi – le api che tornano all’alveare inquadrate negli ultimi fotogrammi sono un segno di speranza per la Natura, ma di totale sconforto per la civiltà umana. Questa cupezza, mitigata dall’ironia grottesca, allinea il film al filone pessimista della fantascienza d’epoca, quando non era raro che un racconto sci-fi o distopico finisse malissimo per l’umanità. Lanthimos sembra attingere a quell’immaginario: il suo Bugonia dialoga con le paure anni ’60 – l’apocalisse nucleare o ecologica, la sostituzione dell’uomo da parte di “altri” (fossero essi alieni, mutanti o scimmie intelligenti) – aggiornandole però ai timori odierni (il collasso climatico, la scomparsa delle api, le teorie del complotto). In questo senso Bugonia può essere letto come un remake spirituale non solo di Save the Green Planet!, ma di decenni di fantascienza sociopolitica, richiamando alla memoria le fantasie oscure di autori come H.G. Wells, Rod Serling, o i film apocalittici della Guerra Fredda.
Il mito della bugonia tra scienza e mitologia
Il termine bugonía deriva dal greco antico e letteralmente significa “progenie dal bue”. Esso fa riferimento a un curioso mito agro-pastorale secondo cui le api nascerebbero spontaneamente dal corpo in decomposizione di un bovino. Questa credenza, per quanto oggi bizzarra, era diffusa nell’antichità e perdurò fino all’epoca premoderna come esempio della teoria della generazione spontanea degli esseri viventi. La fonte più nota del mito è il IV libro delle Georgiche di Virgilio (I sec. a.C.), dove si narra la vicenda leggendaria di Aristeo, apicoltore figlio del dio Apollo. Aristeo, dopo aver involontariamente causato la morte della ninfa Euridice, vede il suo alveare decimato da una pestilenza come punizione divina. Disperato, chiede consiglio a Proteo e viene istruito su un rituale propiziatorio: deve sacrificare alcuni tori e lasciare i loro corpi al sole. Miracolosamente, dalle carcasse in putrefazione dei bovini sacrificiali sorgono sciami di api nuove, risanando così la perdita – è il prodigio della bugonia. Questa scena virgiliana, insieme a varianti successive (Ovidio ne racconta una versione nei Fasti, e persino la Bibbia allude a un leone morto con api nel ventre nel famoso enigma di Sansone), consolidò l’idea che le api potessero generarsi dalla carne morta di grossi animali. In realtà, dal punto di vista biologico, ciò derivava probabilmente dall’osservazione di insetti simili alle api – come certi sirfidi detti drone fly – che depongono le uova nei cadaveri; le larve, dette “vermi a coda di topo”, si sviluppano nei liquami e poi sfarfallano in insetti adulti simili ad api, ingenerando l’illusione che queste ultime fossero nate dal nulla.
Per molti secoli il mito della bugonia fu preso sul serio non solo dalla mitologia, ma anche dalla scienza naturale. La generazione spontanea era una teoria accettata da filosofi come Aristotele e rimase influente fino all’Età moderna. Solo nel Seicento iniziarono le prime confutazioni sperimentali: il biologo italiano Francesco Redi nel 1668 dimostrò con celebri esperimenti (i pezzi di carne in vasi sigillati e non) che i vermi non nascevano spontaneamente, ma dalle uova depositate dalle mosche, minando così la credenza che la vita animale potesse sorgere dalla materia inerte. Successivamente Lazzaro Spallanzani nel XVIII secolo estese le confutazioni, e infine nel 1864 Louis Pasteur, con i suoi esperimenti sui microorganismi (col famoso matraccio dal collo di cigno), diede il colpo di grazia scientifico all’idea di generazione spontanea. Dunque, la bugonia come fenomeno reale venne smentita definitivamente in ambito scientifico nel XIX secolo, ma il suo significato simbolico rimase potente. L’idea di vita che nasce dalla morte – di nuove api che sorgono dal sacrificio di un grande animale – conservò un fascino poetico e fu spesso citata come metafora di rinascita. Ad esempio, nel Rinascimento e oltre, alcuni alchimisti e poeti vedevano nella bugonia un’allegoria della trasformazione e della ciclicità naturale, dove dalla corruzione nasce nuova vita.
Nel film di Lanthimos, il richiamo alla bugonia è carico di implicazioni. Innanzitutto, rispecchia letteralmente il mestiere e l’ossessione del protagonista: Teddy è un apicoltore dilettante che assiste impotente al collasso dei propri alveari, attribuendo la colpa alle sostanze chimiche prodotte dalla corporazione di Michelle. Egli teme la sindrome dello spopolamento degli alveari (Colony Collapse Disorder) – un problema reale della nostra epoca – e cerca una spiegazione quasi mistica o complottista a questo flagello. Il mito antico viene quindi reinterpretato al negativo: anziché vedere api nascere da un sacrificio, Teddy vede le api morire a causa di un “sacrificio” involontario imposto dall’uomo (inquinamento, pesticidi) o addirittura orchestrato da alieni malvagi secondo le sue fantasie. La bugonia era in origine un rituale per placare gli dèi e ripristinare l’equilibrio perduto; in Bugonia la situazione di partenza è già squilibrata – le api stanno scomparendo, segno di un disordine nel rapporto uomo-natura. Teddy, in un certo senso, cerca a suo modo di compiere un sacrificio: individua in Michelle il “toro” da sacrificare sull’altare del bene del pianeta. È convinto che eliminando lei (e trattando con i fantomatici Andromediani) possa far rifiorire le api e salvare la Terra. Come commenta una recensione, Teddy è un apicoltore che “a sua volta è un’ape: un umile operaio nella società in cui Michelle, aliena o no, incarna il capitalismo spietato e quindi la morte delle api”. Nel suo delirio, Teddy vede Michelle come il grande nemico da abbattere, l’animale da sacrificare per propiziare una rinascita – esattamente come Aristeo dovette sacrificare i buoi per riavere le sue api. Questa metafora è volutamente ironica: Teddy crede di essere l’eroe che salva la vita (le api, e per estensione il mondo), ma nei fatti è disposto a uccidere e a distruggere – dunque a portare morte – pur di arrivarci. Lanthimos sembra suggerire che ogni bugonia comporta un costo di sangue: nel mito il sangue del toro morto (anzi, il suo cadavere “senza sangue”, secondo la variante in cui gli animali venivano soffocati) genera nuova vita; nel film, la scia di violenza lasciata da Teddy, Don e poi da Michelle stessa genera un nuovo inizio con l’eliminazione dell’umanità e il ritorno delle api. Un terribile paradosso ciclico dove alla fine sono le api a rinascere dalle carcasse degli uomini.
Interessante è anche l’aspetto etimologico e rituale: nella bugonia classica, il sacrificio andava compiuto in un modo preciso – spesso si descriveva di rinchiudere il corpo dell’animale sacrificato e aspettare un certo numero di giorni finché sciami di api ne uscivano. In Bugonia c’è un dettaglio che richiama le tempistiche rituali: Teddy dà a Michelle “quattro giorni” di tempo per confessare prima dell’eclissi lunare. L’eclissi funge quasi da momento astronomico sacro, un termine temporale oltre il quale si compirà il destino: o gli alieni si rivelano, o Michelle verrà uccisa. Anche qui possiamo scorgere un’analogia: quattro giorni è circa il tempo che, nelle versioni del mito, si attendeva perché le larve trasformassero un bue morto in un alveare ronzante. Nel film, allo scadere dei quattro giorni avviene la rivelazione (Michelle si teletrasporta durante l’eclissi) e subito dopo la punizione finale dell’umanità. In un certo senso, l’intera vicenda è concepita come un rituale di bugonia al contrario: invece di far nascere api da un sacrificio animale, si sacrifica simbolicamente l’umanità (che per gli alieni è il “bue” da cui estrarre qualcosa di utile?) per far rinascere la Natura. Will Tracy, sceneggiatore del film, ha dichiarato esplicitamente che Bugonia può leggersi come “metafora della civiltà contemporanea” in cui dalle ceneri di qualcosa di corrotto può sorgere nuova vita. Dalle macerie del nostro mondo – presentato nel film come intrinsecamente violento, ingiusto e inquinato – potrebbe nascere un mondo migliore, sembra suggerire la provocatoria parabola finale. Certo, è un’idea amara, poiché implica la scomparsa dell’umanità come prezzo della rigenerazione. Eppure, nella logica del mito, il sacrificio è inevitabile: “bisogna ammettere che il sacrificio è inevitabile”, osserva la critica parlando di Bugonia, paragonando l’azione di Teddy all’idea arcaica che per salvare un bene maggiore occorre un’offerta di sangue.
In definitiva, Bugonia utilizza il mito omonimo sia come chiave narrativa sia come layer tematico: è la chiave narrativa perché dà il titolo e l’immaginario (le api, i sacrifici) attorno a cui ruota la vicenda; è un layer tematico perché porta con sé riflessioni filosofiche sulla vita e la morte, sulla colpa e l’espiazione, e sul rapporto uomo-natura. Nel film, la mitologia greca e la storia della scienza diventano uno specchio per leggere il presente: l’antica bugonia era una risposta magica a un disastro (la morìa delle api di Aristeo) e implicava una responsabilità morale (Aristeo doveva espiare la colpa verso Euridice). Allo stesso modo, oggi il disastro ecologico (lo spopolamento degli alveari e la crisi ambientale in generale) ci mette di fronte alle nostre colpe collettive. Bugonia mette in scena in forma paradossale questa espiazione: l’umanità paga in prima persona – anzi, con la propria estinzione – per rimediare ai propri errori. È una visione estrema, che Lanthimos tratta con vena satirica e crudele ironia, ma che affonda le radici in quei miti antichi che vedevano nella morte un preludio necessario alla rinascita.
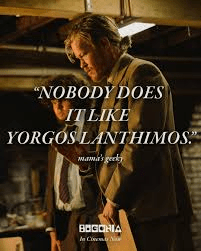
Remake e autocitazione nel cinema moderno
Bugonia occupa un posto singolare nel panorama contemporaneo anche come remake di un film di culto e come opera ricca di citazioni cinefile, quasi un gioco di specchi metacinematografici. Nel cinema moderno, i remake sono diventati molto frequenti – spesso Hollywood “ricicla” film stranieri di successo per proporli a un pubblico più ampio, oppure reinterpreta classici del passato in chiave aggiornata. Lanthimos in questo caso riprende fedelmente la trama di Save the Green Planet! (2003), un film coreano dalle tonalità simili di commedia nera e fantascienza paranoica. Secondo la critica, la sceneggiatura adattata da Will Tracy cambia molto poco rispetto all’originale, persino l’incredibile finale rimane praticamente identi. In effetti, chi ha visto l’opera di Joon-hwan Jang ritrova in Bugonia quasi tutte le svolte narrative: anche nel film coreano il protagonista rapiva un dirigente credendolo un alieno e alla fine si scopriva che gli alieni esistevano davvero e volevano distruggere il pianeta. Lanthimos dunque realizza un remake rispettoso, ma ciò non significa che manchi di personalità autoriale. Al contrario, egli “fa un apprezzabilissimo lavoro di regia per adattarlo a sé” – come nota Wired – inserendo il proprio stile e i propri temi dentro la struttura preesistente. Bugonia diventa così un esempio di come un remake possa essere anche un dialogo tra due culture cinematografiche (la satira fantascientifica coreana e l’assurdo grottesco greco/europeo di Lanthimos) e tra passato e presente.
Un aspetto interessante è il gioco di citazioni interne ed esterne al film. Lanthimos dissemina Bugonia di riferimenti non solo ad altri film (come abbiamo visto con Hitchcock o The Time Machine), ma anche richiami al proprio cinema e a quello dei suoi contemporanei. Ad esempio, il film è suddiviso in capitoli con titoli enfatici sullo schermo – una trovata che può ricordare il collega danese Lars von Trier, noto per l’uso dei capitoli nei suoi film, e che qui aggiunge un tono ironicamente solenne alla vicenda. Alcuni recensori hanno persino paragonato Bugonia all’estetica provocatoria di registi come Ari Aster (autore di Hereditary e Midsommar) e ai fratelli Coen, individuando nel film “una spietata ironia e amore per il grottesco” a metà strada tra quelle influenzeartesettima.it. Queste considerazioni suggeriscono che Lanthimos, consapevole di essere un cineasta postmoderno, gioca con gli elementi già visti altrove: Bugonia contiene momenti di satira sociale che strizzano l’occhio ad altri film recenti. Ad esempio, la feroce presa in giro del linguaggio “corporate” inclusivo di Michelle – con lei che parla come un comunicato stampa pieno di politiche di diversità, mentre dietro le quinte la sua azienda fa cose orribili – richiama tematiche affrontate anche in Eddington di Ari Aster (un film immaginario citato in alcune recensioni come simbolo della satira sui potenti e sui complottisti). Allo stesso modo, l’idea di un complottista che crede ciecamente alle fake news e sequestra qualcuno ricorda altre storie degli ultimi anni, come 10 Cloverfield Lane (2016) o certi episodi della serie Black Mirror, sebbene Bugonia ribalti le aspettative confermando i deliri del protagonista. Lanthimos sembra divertirsi a citare stereotipi del genere: la figura del poliziotto che sospetta qualcosa (il film include uno sceriffo locale, Casey, con cui Teddy ha un conto in sospeso) è un topos di tanti thriller, ma qui viene risolta in modo beffardo e brutale – Casey fa una brutta fine, ucciso da Teddy durante un sopralluogo, quasi a dire che nel mondo caotico di Bugonia non c’è spazio per l’eroe esterno che salva la situazione all’ultimo minuto, come avverrebbe nei film di genere più convenzionali.
L’autocitazione vera e propria nel cinema di Lanthimos si coglie in alcuni temi ricorrenti. Chi conosce i suoi film precedenti noterà in Bugonia la prosecuzione di un discorso caro al regista: la natura animale dell’uomo e le dinamiche di potere nei sistemi chiusi. In Kynodontas (Dogtooth) esplorava una famiglia isolata dal mondo con proprie regole distorte; in The Lobster trasformava letteralmente gli umani in animali se fallivano nel trovare l’amore. Qui in Bugonia gli esseri umani sono di nuovo paragonati ad animali (api operose contro “regine” spietate), e l’isolamento della cantina crea un microcosmo dove vigono regole brutali di dominazione e sottomissione. Lanthimos cita se stesso anche nell’estetica: l’uso di inquadrature simmetriche e freddi toni pastello nelle scene corporate con Michelle rievoca The Killing of a Sacred Deer o The Favourite, mentre le improvvise esplosioni di violenza grottesca riportano alla mente Il sacrificio del cervo sacro (dove pure recitava Colin Farrell in una vendetta quasi soprannaturale). Un altro elemento di continuità è la presenza di Emma Stone, ormai musa del regista, che qui offre un’altra performance notevole dopo La favorita e Poor Things. La Stone in Bugonia incarna perfettamente quell’ambiguità tipica dei personaggi lanthimosiani: glaciale e calcolatrice, ma non priva di un umorismo nero e di momenti di vulnerabilità. Si potrebbe dire che Lanthimos “autocita” la maschera che Emma Stone ha già indossato per lui – pensiamo alla sua regina Anna stralunata ne La favorita, o alla creatura ingenua e feroce in Poor Things – adattandola ora alla figura di un’aliena/CEO che nasconde sotto la facciata di girlboss una natura letteralmente sovrumana.
Dal punto di vista della struttura narrativa, Bugonia intreccia remake e citazionismo in modo quasi ironico: pur essendo “un prodotto astuto più che una visione del tutto originale” come notato da alcuni critici, il film riesce comunque a sorprendere e a giocare con le aspettative dello spettatore moderno. Ad esempio, la maggior parte del pubblico oggi è abituata ai tropi narrativi e magari aveva intuito che in fondo Michelle potesse davvero essere un’aliena. Lanthimos e Tracy lo sanno e seminano indizi con intelligenza – dai comportamenti algidi di lei alla precisione con cui le teorie strampalate di Teddy spesso trovano riscontro nei dettagli (il fatto che i capelli rasati impediscano davvero le comunicazioni telepatiche, o che il modellino di astronave che Teddy ha costruito corrisponda esattamente a quello vero). In questo la sceneggiatura compie una fine metacitazione del genere fantascientifico complottista: di solito, nelle storie, il cospirazionista ha torto e impara la lezione, mentre qui ha ragione su tutta la linea – un ribaltamento che strizza l’occhio allo spettatore navigato, quasi a dirgli: “credi di sapere come va a finire? Ripensaci.” È il genere di astuzia narrativa che ricorda i finali beffardi di alcuni episodi di Ai confini della realtà (serie anni ’60 notoriamente piena di twist ending) o di film come Invasion of the Body Snatchers (la versione del ’56 finiva con un grido disperato “They’re here!” non creduto da nessuno). Bugonia aggiorna quell’approccio: il suo finale distruttivo è quasi una parodia dei finali “a sorpresa”, portato all’estremo con humour nero.
In conclusione, come remake Bugonia mostra che rifare un film non significa solo copiarlo, ma anche dialogare con esso e col pubblico contemporaneo. Lanthimos utilizza la storia di un altro per riflettere sui temi a lui cari e al contempo fa un commento sul cinema stesso – citando, omaggiando, sovvertendo modelli. In un’epoca di cinema “autoreferenziale” e strapieno di sequel, prequel e reboot, Bugonia si distingue perché è consapevole di questa condizione e la sfrutta creativamente. Ci troviamo di fronte a un’opera che, pur essendo un remake, è anche un meta-remake: un film che parla anche di altri film (Hitchcock, i B-movie di fantascienza vintage, il cinema di satira moderno) e che invita lo spettatore cinefilo a cogliere i rimandi. È un approccio in linea con il postmodernismo cinematografico, dove ogni storia nuova è fatta anche di pezzi di storie vecchie. Bugonia abbraccia questo concetto e, come un puzzle, mette insieme i pezzi di miti antichi, film cult e riferimenti pop, riuscendo comunque a creare un insieme coerente e dal forte impatto visivo ed emotivo.
Bugonia come remake postmoderno di Save the Green Planet!
Non tutti gli spettatori di Bugonia probabilmente sanno che il film è in realtà un remake – ovvero una nuova versione – di un lungometraggio sudcoreano del 2003 dal titolo Save the Green Planet! (in coreano: Ji-gu-reul jikyeora!). Yorgos Lanthimos e lo sceneggiatore Will Tracy hanno adattato quella storia alle sensibilità occidentali e contemporanee, mantenendo la struttura di base ma apportando variazioni significative. Analizzare Bugonia come remake ci permette di parlare del concetto stesso di remake e citazione nel cinema odierno, nonché di capire come Lanthimos si inserisca in un filone di cinema postmoderno dove rifare, citare e rimescolare materiali esistenti è spesso parte integrante della creazione artistica.
Dal culto coreano al mainstream occidentale: perché rifare Save the Green Planet!?
Save the Green Planet! (2003, regia di Jang Joon-hwan) è un film di nicchia ma venerato dagli appassionati, un’opera di genere ibrido che mescolava thriller, horror, commedia e fantascienza in modo del tutto originale. La trama essenziale coincide con quella di Bugonia: un uomo tormentato e ossessionato dai complotti alieni rapisce un ricco dirigente, convinto che sia un extraterrestre venuto a distruggere la Terra; lo tortura cercando la “confessione” e la prova dell’invasione incombente. Nel film coreano, questo protagonista si chiamava Byeong-gu ed era aiutato dalla sua ragazza; il CEO si chiamava Kang Man-shik. Sullo sfondo, si dipanava pian piano il tragico passato di Byeong-gu (traumi familiari, ingiustizie subite) e, in un crescendo folle, il film culminava con la rivelazione che l’alieno era reale e un finale apocalittico in cui (nella versione coreana) gli alieni decidono effettivamente di distruggere la Terra dopo la morte di Byeong-gu. Save the Green Planet! era dunque già di per sé un prodotto postmoderno, pieno di riferimenti alla cultura pop e ai generi (in Corea fu considerato atipico proprio per la sua miscela tonale).
Perché Lanthimos, autore noto per idee originali e bizzarre, ha scelto di rifare proprio questo film? Possiamo ipotizzare diverse ragioni. Primo, la storia di Save the Green Planet! si adatta perfettamente alle sue corde tematiche: è incentrata sulla follia umana, sulla paranoia, su una critica sociale (in quel caso alla società coreana, alla corruzione, ecc.) e ha un misto di grottesco e tragico che sembra fatto apposta per Lanthimos. In altre parole, Lanthimos può aver visto nel film di Jang Joon-hwan una “gemma grezza” da reinterpretare a modo suo, portandola al pubblico internazionale. Secondo, i tempi erano maturi: nel 2003 internet e i social erano appena agli inizi, mentre nel 2025 i complottismi e la sfiducia nelle élite sono temi caldissimi a livello globale (dalle teorie del complotto sulle pandemie, ai QAnon, ai no-vax, ecc.). Bugonia come remake aggiorna e rilocalizza la storia, spostandola dalla Corea di inizio millennio agli Stati Uniti post-Covid e impregnati di tensioni sociali. Infatti Teddy è esplicitamente un cospirazionista post-2020: ascolta podcast complottisti, parla di “tecnoschiavitù” e di big pharma che avvelena il mondo, risentendo del clima successivo alla pandemia. In Save the Green Planet! l’elemento di critica c’era (industriali senza scrupoli, poliziotti violenti), ma Lanthimos lo filtra attraverso temi come l’avidità farmaceutica (gli esperimenti clinici, il ritiro di un farmaco che rovina vite) e l’ecologia (le api che muoiono, la Terra avvelenata), temi molto cari al pubblico occidentale odierno. Dunque rifare quel film significava anche parlare del presente usando una storia potente e adatta. Will Tracy, lo sceneggiatore, ha esplicitamente detto in un’intervista che il titolo Bugonia si riferisce metaforicamente proprio all’idea che dalla corruzione attuale potrebbe nascere qualcosa di nuovo – concetto che calza alla situazione globale dove molti si chiedono se dall’“impero” del capitalismo malato potrà emergere un futuro diverso o se tutto crollerà. E la frase “potrebbe sorgere nuova vita dalle ceneri di qualcosa di marcio” è stata una motivazione chiave nella scelta di questo soggetto. Il remake quindi è motivato artisticamente e tematicamente, non solo commercialmente.
Va anche detto che Save the Green Planet! non era un titolo noto al grande pubblico internazionale – era un cult tra cinefili. Rifarlo con attori hollywoodiani (Emma Stone, Jesse Plemons) e un regista acclamato significa portare quell’idea folle a un’audience più ampia. Non per nulla Bugonia è stato presentato a festival prestigiosi (Venezia, Telluride) e distribuito come un film d’autore di alto profilo, con campagne pubblicitarie curiose (Focus Features ha lanciato sfide al pubblico tipo radersi i capelli per promuovere il film. Insomma, Lanthimos ha “tradotto” Save the Green Planet! in un contesto mainstream occidentale, operazione tipica di molti remake (si pensi a The Ring, rifacimento di Ringu, o The Departed, rifacimento di un film di Hong Kong – in tutti questi casi un soggetto di nicchia viene reinterpretato per il pubblico occidentale con grande successo).
Fedeltà e variazioni: Bugonia vs Save the Green Planet!
Analizziamo ora come Bugonia differisce e coincide con l’originale, per capire la poetica del remake. Secondo Jordan Ruimy di World of Reel, Lanthimos ha sepolto nei titoli di coda un riconoscimento al film originale, “quasi fosse un ripensamento”, a indicare che chi conosceva già Save the Green Planet! avrebbe riconosciuto la trama immediatamente, ma molti altri no. E infatti gran parte del pubblico di Bugonia probabilmente ha vissuto la storia come nuova. Trama e personaggi principali: rimangono grossomodo gli stessi (due rapitori – qui cugini, lì fidanzati; un prigioniero potente – lì un CEO chimico, qui una CEO farmaceutica; madre del protagonista in coma per colpa del CEO; finale con invasione aliena). Tuttavia, Bugonia apporta sfumature proprie: ad esempio, il personaggio di Don in Bugonia sostituisce la fidanzata di Byeong-gu. Questa scelta modifica la dinamica: in originale c’era un legame d’amore disturbato e la ragazza era un po’ succube di Byeong-gu; qui c’è un legame di sangue (cugini) e un forte accenno all’autismo di Don, che dà a quella relazione un aspetto diverso. Don non è spinto dall’amore romantico ma dalla lealtà familiare e dalla sua natura ingenua – è letteralmente un “credente” in Teddy, tanto che l’articolo del LA Times lo definisce “il cuore del film” e rimarca che Don crede in Teddy. Questo rende la sua fine (si spara per l’impossibilità di conciliare la fedeltà a Teddy con il senso di colpa) ancora più tragica, come una sorta di innocente sacrificale che non esisteva esattamente nell’originale. L’originale aveva la fidanzata che (SPOILER) moriva in un tentativo di aiutare Byeong-gu e anche lì c’era tragedia, ma qui con Don autistico c’è un tema di inclusione e fragilità che Lanthimos ha voluto sottolineare (anche scegliendo un attore realmente nello spettro, Aidan Delbis). Questo è un tocco moderno che riflette sensibilità odierne verso la neurodiversità. Non che Bugonia faccia discorsi espliciti su ciò, ma è presente come colore: Don è differente, ed è proprio la sua purezza semplice a reggere per un po’ Teddy e poi a crollare. L’originale invece rappresentava la ragazza come un po’ mentalmente instabile e suggestionabile, ma non aveva la dimensione dell’autismo.
Un’altra variazione: la figura del poliziotto/sbirro. In Save the Green Planet! c’era un subplot con un detective eccentrico e le indagini, mentre in Bugonia questo aspetto è ridotto a un solo personaggio secondario, lo sceriffo locale Casey, presentato come un tonto che possiede un oscuro segreto (forse un crimine passato). Casey è un elemento quasi di contorno, spazzato via anch’egli dall’apocalisse finale. Lanthimos e Tracy hanno quindi snellito la trama, togliendo parecchio di esterno (nel film coreano c’era molta più interazione con l’esterno, anche scontri con la polizia). Bugonia rimane ancor più concentrato sui tre personaggi centrali nella casa. Questo riflette forse lo stile di Lanthimos: predilige microcosmi isolati (come la famiglia chiusa di Dogtooth, la coppia di Alps, ecc.), e qui ha isolato al massimo la vicenda per farne quasi un dramma da camera. Questo spiega perché, nonostante la premessa fantascientifica, Bugonia sembri molto “teatrale” in certi momenti: c’è pochissima azione esterna, giusto la scena iniziale del rapimento fuori dalla villa di Michelle e poi quasi tutto indoor. L’originale era più movimentato e action in alcune parti. Alcuni critici hanno notato che questa essenzialità rende Bugonia a tratti più prevedibile se si conosce l’originale, perché “chi ha visto il film coreano non troverà nulla di sorprendente, mentre i neofiti sì”. In effetti, Lanthimos non rivoluziona la trama, la segue abbastanza fedelmente, perciò gran parte delle sorprese (come l’alieno vero e l’estinzione) sono analoghe. Ciò che cambia è il tono: la recensione di Robert Daniels evidenzia che Bugonia è un film “arrabbiato” e “deliberato” nel costruire la sua rabbia, e che però si percepisce un certo controllo morale dell’autore nel rappresentare i conflitti (a differenza dell’originale che era anarchico e wild). Questo riflette la prospettiva di Lanthimos: lui, come “outsider greco in America”, vuole fare un discorso su tutti i lati del problema – vede la rabbia di Teddy come in parte giustificata e in parte folle, e vede anche Michelle non solo come mostro ma come possibile alter ego dell’autore stesso (il dubbio: Lanthimos simpatizza coi vigilanti proletari o con l’élite cinica? Il film lascia ambiguità). Save the Green Planet! invece era più chiaro nel far simpatizzare con Byeong-gu nonostante i suoi crimini, perché il CEO era mostrato più negativamente come un vero meschino (anche se poi era alieno). Lanthimos semina più ambivalenza: c’è critica alle corporazioni (Michelle rovina la vita di Teddy con i suoi farmaci, questo è chiaro) ma c’è anche uno sguardo critico sul fanatismo di Teddy. In parte, ciò riflette i contesti: in Corea l’originale sottolineava la cattiveria dei potenti e il torto subito dal protagonista (anche lì comunque Byeong-gu è colpevole di omicidi, ma lo si comprende come prodotto di un sistema violento). In Bugonia, ambientato in USA, Lanthimos sembra voler dire che entrambi – tanto il complottista quanto il capitalista – sono facce della stessa medaglia umana fallimentare. C’è, se vogliamo, una visione più disincantata e globale. Ciò giustifica l’immagine finale in Bugonia delle api che tornano: nessun umano merita di farcela, né l’oppresso né l’oppressore; meglio ricominciare da capo senza di noi. L’originale, benché avesse la distruzione della Terra, lasciava come messaggio una tristezza per l’incomprensione reciproca (le scene nei titoli di coda con i ricordi di Byeong-gu volevano umanizzarlo e piangere ciò che è andato perduto di buono). Bugonia è più severo: nel finale di Bugonia c’è giusto un barlume di “speranza per la Terra stessa” ma non per l’umanità. Will Tracy lo collega alla sensazione di “speranza che il pianeta ce la faccia anche senza di noi” nel contesto di disperazione climatica odierna. Questa differenza di accento è sottile ma importante: riflette 20 anni di cambiamenti di prospettiva.
In sostanza, Bugonia come remake è fedele nella struttura ma personale nel punto di vista. Mantiene molte scene iconiche dell’originale (il rapimento in maschera, la tortura con vari espedienti – nell’originale c’era ad esempio l’uso di api contro il CEO, qui non esplicitato ma è suggerito dai discorsi; la rasatura dei capelli – che in originale forse non c’era, questo dettaglio nuovo è perfetto per Emma Stone e la promozione; l’inganno del “antidoto alieno” – nell’originale il CEO alieno convinse Byeong-gu che aveva un modo di resuscitare la madre?), e il twist conclusivo identico. Ma l’approccio di Lanthimos è quello di un remake d’autore: non copia pedissequamente ma reinterpreta per sottolineare i temi che gli interessano. E come spesso accade nei remake postmoderni, c’è anche un gioco di autocitazione e meta-riflessione: Lanthimos infonde elementi del suo stile (ad esempio, si potrebbe dire che la castrazione chimica iniziale e l’auto-punizione di Teddy e Don richiami The Killing of a Sacred Deer dove la punizione autoinflitta e il sacrificio erano centrali – Lanthimos autocita le sue ossessioni sulla colpa e penitenza). Anche il concetto di punizione per i peccati dei genitori (qui la madre di Teddy colpevole di che? Forse la madre in coma richiama The Killing of a Sacred Deer dove c’era un genitore da punire) è un suo tema tipico. Insomma, Bugonia è ibrido: metà rifacimento di un altro, metà film lanthimosiano doc.
Remake, citazione e cinema postmoderno
L’analisi di Bugonia come remake ci porta naturalmente a considerare il valore della citazione e dell’autocitazione nel cinema postmoderno. Siamo in un’epoca in cui i confini tra originale e derivato sono fluidi: i registi spesso rifanno film altrui (basti pensare a quanti remake e reboot escono ogni anno), o rifanno i propri (pensiamo a Michael Haneke che rifà Funny Games shot-for-shot in un’altra lingua, o a registi che citano se stessi). Questo può essere visto come mancanza di idee, ma nel migliore dei casi è un modo per creare nuovi significati attraverso il dialogo col passato.
Lanthimos con Bugonia dimostra che un remake può essere autoriale. Egli ha preso un film di genere e l’ha nobilitato con la sua visione. In ciò segue la tradizione di tanti rifacimenti celebri: ad esempio, La cosa di Carpenter era un remake di The Thing from Another World ma è considerato un capolavoro a sé; L’invasione degli ultracorpi di Kaufman (1978) rifaceva quello del 1956 aggiungendo un pessimismo adatto ai ’70. Allo stesso modo, Bugonia rifà Save the Green Planet! aggiornandolo agli anni ’20 del Duemila, con paranoia da Internet e misantropia accentuata post-lockdown.
Lanthimos inserisce anche citazioni filmiche come abbiamo visto, dunque Bugonia è un remake e un film citazionista allo stesso tempo: un collage consapevole. Questa operazione è in sé molto postmoderna: prendere frammenti esistenti (un film precedente, riferimenti ad altri film, miti antichi) e combinarli in un nuovo testo che però ha un commento critico su quei frammenti. Ad esempio, Bugonia cita Il pianeta delle scimmie non solo per omaggio, ma per implicare: “vedete, stiamo al punto di quell’avvertimento anni ’60, l’abbiamo ignorato e ora siamo noi le scimmie sulla soglia dell’auto-estinzione”. Cita Rope per dire: “questo è un dramma morale da camera come quelli hitchcockiani, ma con la morale capovolta”. Cita Jacob’s Ladder per suggerire “questi potrebbero essere tutti incubi nella testa di Teddy”. E rifà Save the Green Planet! per dire “il messaggio 20 anni fa era valido, oggi lo è ancor di più e forse ancor più disperato”. In pratica, il cinema postmoderno usa remake e citazioni come un linguaggio: la riconoscibilità del riferimento genera un meta-significato. Chi coglie le citazioni si gode il gioco intellettuale; chi non le coglie comunque fruisce di una storia magari inconsciamente arricchita da archetipi prelevati da altri film.
Un rischio del postmoderno è la freddezza o l’eccesso di ironia. Alcuni critici hanno percepito Bugonia come un po’ troppo consapevole e costruito – si parla di “macchinosa misantropia”. Il fatto che Lanthimos abbia detto solo nei titoli di coda che era un remake, come a volerlo nascondere, potrebbe essere visto come astuzia commerciale: vendere il film come “nuovo” al vasto pubblico. Ma per i cinefili informati, questo nasconde-e-rivela fa parte del gioco postmoderno della citazione implicita.
Un ultimo punto: Bugonia come remake di un film coreano s’inserisce nella tendenza ormai frequente di scambi culturali nel cinema globalizzato. Hollywood e dintorni pescano spesso dall’Asia idee brillanti e le rifanno con star occidentali per il pubblico locale. A volte queste operazioni sono banalizzanti; altre volte, come qui, mantengono la follia originale. La scelta di Lanthimos come regista (un greco formatosi in Europa) è perfetta perché lui stesso è un outsider nel sistema americano, dunque in grado di reinterpretare un film outsider coreano in contesto americano con sguardo straniante. È come se il film stesso fosse “alieno” rispetto al mainstream, pur essendo recitato in inglese da star. Questo è un bel paradosso: un remake che rimane strano e scomodo quanto l’originale – e forse anche di più in certi aspetti (per il pubblico generalista occidentale, Bugonia risulterà disturbante per la conclusione radicale e il tono, come indica il divisivo responso critico: non a tutti è piaciuto quell’approccio severo).
In conclusione, Bugonia come remake postmoderno riesce a citare e rinnovare allo stesso tempo. È un esempio di come il cinema contemporaneo possa cannibalizzare se stesso per parlare del presente: l’originale coreano era figlio del post-11 settembre e di un contesto locale; il remake è figlio del post-Covid e del contesto globale (clima, big pharma, disinformazione online). Entrambi usano l’invasione aliena come metafora, ma con accenti diversi. Lanthimos, pur rifacendo un film, ha creato un’opera che porta inequivocabilmente la sua firma e dialoga con la cultura cinematografica a 360 gradi. Questo chiude il cerchio della nostra disamina sulle citazioni: Bugonia è un crocevia cinematografico dove mito classico, film di culto e stili di vari autori s’incontrano in un prodotto nuovo.
Adesso, avendo compreso il ricco background di riferimenti e il contesto di remake postmoderno, possiamo dedicarci a ciò che costituisce la spina dorsale emotiva e concettuale di Bugonia: l’analisi psicologica approfondita dei suoi personaggi e temi, quella che ho preannunciato come la parte più corposa di questo saggio. In essa vedremo come i traumi, le dinamiche di potere, le illusioni difensive e i simboli presenti nel film si possono leggere in chiave psicologica e psicoanalitica rigorosa, dandoci una comprensione più profonda delle scelte narrative e delle allegorie che Lanthimos mette in scena.
Analisi psicologica: tempo, identità e trauma
Sotto la superficie da dark comedy fantascientifica, Bugonia è anche uno studio psicologico dei suoi personaggi e un’esplorazione tematica del tempo, dell’identità e del trauma. La vicenda infatti è pervasa da questioni identitarie (chi è davvero umano e chi alieno? chi è folle e chi lucido?), da ossessioni legate al passato e al futuro, e dalle ferite emotive che motivano i comportamenti estremi dei protagonisti.
Il tempo in Bugonia gioca un ruolo sia narrativo che simbolico. Narrativamente, come già accennato, c’è un countdown: Teddy concede a Michelle quattro giorni, fino all’eclissi di luna, per “confessare” la sua natura extraterrestre. Questo orizzonte temporale imminente crea tensione e struttura il film in una sorta di corsa contro il tempo. Ogni giorno che passa aumenta la pressione su Michelle (che rischia la vita) e su Teddy (che teme l’arrivo dell’astronave aliena). La presenza dell’eclissi – un evento astronomico ciclico e prevedibile – fa sì che il tempo nel film sia quasi un personaggio incombente, un fato inevitabile che scandisce gli atti della tragedia. Ma c’è di più: l’eclissi, oscurando temporaneamente la luce, simboleggia il momento di rivelazione e cambiamento irreversibile. Ed effettivamente nel climax durante l’eclissi tutto si compie (la morte di Teddy, la fuga di Michelle nello spazio, la fine dell’umanità). In questo senso il tempo astronomico diventa tempo mitico: l’eclissi appare come un segno del destino, un po’ come nelle antiche tragedie greche un fenomeno celeste segnava l’ira degli dèi o la svolta del dramma.
Sul piano simbolico, il film riflette sul rapporto tra passato, presente e futuro. Teddy è ossessionato dal passato: i torti subiti (la madre ridotta in coma dal farmaco Auxolith, gli abusi subiti da piccolo dallo sceriffo babysitter) lo hanno trasformato in ciò che è. Il suo trauma personale è il motore della sua furia: dietro la facciata del complottista idealista che “vuole salvare il pianeta”, c’è un uomo ferito e arrabbiato con figure di autorità che lo hanno tradito. Michelle glielo fa notare abilmente durante i loro colloqui: capisce che Teddy in fondo cerca vendetta per sua madre più che giustizia cosmica. D’altro canto, Michelle incarna il futuro – o almeno così sembra all’inizio: è una donna in carriera, proiettata in avanti, che vive con disciplina quasi militaresca pianificando ogni ora della giornata. Nel suo ruolo di CEO, lei rappresenta l’ideologia del progresso e della performance, priva di nostalgia per il passato (anzi, cerca di insabbiare gli errori passati della sua azienda). Eppure, alla fine si scopre che anche Michelle ha un passato lunghissimo, addirittura non umano: è vissuta da infiltrata chissà per quanto tempo, e come aliena porta il peso di millenni di esperimenti falliti sulla razza umana. Quando sul finale Michelle discute con i consiglieri Andromediani, ragiona in scala temporale vasta – parlano dell’umanità come di un progetto evolutivo giunto al termine. Qui il tempo storico (le ere dall’epoca dei dinosauri ad oggi) si mescola col tempo personale dei personaggi: per Michelle quell’istante è conclusivo di un lungo esperimento, per Teddy era tutta la vita condensata in quattro giorni di follia. Il contrasto tra la percezione temporale umana e quella “aliena” è notevole: Teddy agisce in preda all’urgenza, Michelle/imperatrice agisce con fredda prospettiva millenaria. Questo scarto ricorda i temi di Philip K. Dick e altri autori citati, sulla costruzione di mondi che collassano su se stessi e sulla percezione alterata della realtà. Bugonia infatti gioca con il concetto che il tempo è relativo alla prospettiva: l’evento apocalittico finale può essere visto come una fine (dal punto di vista umano) o come un nuovo inizio (dal punto di vista della natura o degli alieni).
Passando all’identità, il film lavora sul tema della maschera e della vera natura, spesso confondendo le acque. Michelle è introdotta come una figura algida, quasi disumana nella sua efficienza; il film ci spinge a chiederci insieme a Teddy se sia davvero “aliena” in senso figurato (cioè un’estranea alle comuni preoccupazioni morali) o letterale. La sua identità rimane ambigua fino agli ultimi minuti, e Stone è bravissima a mantenere questa doppiezza: anche legata e rasata nel seminterrato, conserva una sorta di superiorità che ci fa dubitare se sia vittima innocente o qualcosa di più pericoloso. Dall’altra parte, Teddy soffre di un’identità frammentata: egli ha attraversato fasi ideologiche estreme (estrema destra, poi sinistra, poi centro-sinistra, in un confuso percorso di disillusione) e ora rifiuta tutte le etichette, definendosi un libero pensatore opposto a qualunque sistema. Questa volatilità di convinzioni riflette un Io alla deriva, che cerca disperatamente un nemico esterno a cui attribuire la colpa del proprio dolore. Psicologicamente, Teddy incarna il fenomeno contemporaneo del complottista radicalizzato: isolato nella sua “bolla di risentimento” verso la società, ha trovato su Internet comunità e teorie che confermassero le sue idee (le echo chamber digitali di cui parla Cass Sunstein, citate nel film stesso). Teddy ha dunque costruito un’identità di “salvatore contro gli alieni” per dare senso al caos della sua vita – un meccanismo psicologico di compensazione del trauma e della perdita di controllo. Don, il cugino, rappresenta un caso diverso di identità: affetto da disturbi dello spettro autistico, è descritto come ingenuo e manipolabilegardapost.it. La sua identità è quasi assorbita da quella di Teddy, al punto che quando Michelle riesce temporaneamente a instillargli il dubbio, Don va in cortocircuito emotivo e purtroppo si toglie la vita, incapace di gestire la dissonanza tra la lealtà al cugino e la percezione del male commesso. Questo momento è straziante e aggiunge complessità al tema dell’identità: Don non regge la frattura tra l’idea di sé come “eroe buono al fianco di Teddy” e la realtà di sé come rapitore e torturatore di un’innocente (dal suo punto di vista).
Il trauma infine è forse il cuore emotivo del film, nascosto sotto i generi di superficie. Teddy agisce per trauma: la madre amata in coma permanente, gli abusi subiti da bambino, le umiliazioni socio-economiche di una vita ai margini (è un magazziniere sottopagato). Tutto questo crea in lui un dolore non elaborato che si tramuta in rabbia complottista. Psicologicamente, Teddy mostra segni di paranoia e delirio sistematizzato – costruisce un intero impianto pseudo-scientifico per spiegare il suo trauma (gli alieni cattivi che drogano le persone, che fanno esperimenti, etc.), perché è più sopportabile per lui credere a un grande complotto cosmico che accettare la casualità crudele o l’ingiustizia terrena (una multinazionale avida che danneggia sua madre e le api senza “piano alieno” è paradossalmente un pensiero più insopportabile per lui, perché implicherebbe un male banale e umano, non epico). Anche Michelle però rivela un possibile trauma: quando ella, verso la fine, racconta (forse inventando sul momento) la storia degli Andromediani pentiti per aver distrutto i dinosauri e intenti ad aiutare l’umanità a evolvere, sembra quasi manifestare un’incrinatura emotiva. Se quella storia fosse vera, gli alieni avrebbero cercato per millenni di salvare un’umanità autodistruttiva, fallendo sempre – un po’ come un genitore disperato per un figlio incorreggibile. Questo potrebbe essere il trauma collettivo della specie aliena, stanca e delusa. Certo, non sappiamo quanto di quel monologo di Michelle sia veritiero e quanto manipolatorio, ma di sicuro tocca nervi scoperti in Teddy. Egli scoppia in lacrime quando lei, fingendo di essere aliena, gli promette una cura per la madre e poi quella speranza si rivela fatale. Qui vediamo il bambino ferito in Teddy: la sola idea di poter “risvegliare” la mamma lo rende vulnerabile e lo spinge a un atto terribile (iniettare l’antigelo, che lui crede medicina, e uccidere involontariamente sua madre). È un momento di tragedia intima nel mezzo della commedia nera: Teddy, pur colpevole di crimini, suscita compassione perché intrappolato nel suo trauma al punto da distruggere ciò che più amava.
L’interazione tra Michelle e Teddy è dunque anche un gioco psicologico di terapia inversa: Michelle scava nelle motivazioni di Teddy con astuzia, portando a galla le sue “cicatrici profonde” e smontando piano piano le sue razionalizzazioniì. Di contro, Teddy prova vari atteggiamenti con lei – dall’aggressività alla finta gentilezza – rivelando il suo lato instabile. Questo duello verbale fa emergere temi di identità (Michelle finge empatia condividendo cinismo e disillusione con Teddy, forse solo per manipolarloì) e di trauma (ogni volta che lei tocca il tasto della madre o dell’abuso, ottiene reazioni forti). In pratica, il seminterrato diventa lo spazio di una psicoterapia contorta: Teddy e Michelle si scambiano i ruoli di accusatore e confidente a più riprese. Da un lato, Teddy vuole far “confessare” Michelle (un po’ come un terapeuta estorto cerca la verità del paziente); dall’altro, Michelle cerca i punti deboli di Teddy per instillare in lui il dubbio e farlo crollare (quasi fosse lei la psicologa che smonta le convinzioni deliranti del paziente). Questo continuo ribaltamento genera ambiguità morale: lo spettatore non sa più con chi identificarsi, chi sia la vittima e chi il carnefice. La domanda “di chi dobbiamo avere più paura?” rimane aperta per gran parte del filmì, ed è proprio questa ambivalenza a dare profondità psicologica alla vicenda. Plemons offre una performance intensa, in bilico tra fanatismo e fragilità, che permette di credere tanto alla possibilità che Teddy sia un pazzo pericoloso quanto al fatto che possa aver ragione (e infatti ha ragione!). Stone, dal canto suo, riesce a essere contemporaneamente “ghiacciata e spietata” – come l’ha definita Peter Bradshaw – eppure stranamente empatica in alcuni frangenti, facendo trapelare la paura genuina di Michelle durante le torture o la furia quando riesce a reagire.
Identità e trauma convergono infine nel tema della camera dell’eco menzionato nel film. Teddy è descritto come immerso in una “echo chamber” (camera dell’eco) virtuale che ha rinforzato le sue credenze. Questo concetto sociologico ha un risvolto psicologico: vivere in un sistema chiuso che rispecchia solo le proprie convinzioni porta a una perdita di contatto con la realtà e a un rafforzamento dell’Io delirante. Teddy ha perso la capacità di mettere in dubbio la propria identità di “eletto che vede la verità” perché ogni segnale esterno viene reinterpretato a conferma delle sue teorie. Michelle tenta di rompere questa camera dell’eco con la razionalità (“Non sono un’aliena, stai sbagliando, liberami”), ma non basta; vi riesce solo simulando di entrare nel delirio di lui (quando finge di confessare di essere aliena) – paradossalmente assecondando la sua visione per poi usarla contro di lui. Da un punto di vista psicologico, è un gioco rischioso ma efficace: per un attimo Teddy ottiene ciò che desiderava (conferma, senso di controllo, speranza di salvare la madre), e quell’apertura emotiva lo rende vulnerabile alla manipolazione. Questo momento rivela quanto il suo sé fosse costruito su un precario equilibrio di difese: basta una falsa promessa per farlo deragliare. Il suicidio di Don aggiunge un ulteriore peso traumatico su Teddy (perde l’unica persona a lui cara e alleata), lasciandolo definitivamente solo nella sua follia proprio all’atto finale. La solitudine di Teddy nel momento in cui entra nel presunto teletrasporto – col suo giubbotto bomba, convinto di aver ormai vinto – è quasi patetica: non c’è più nessuno ad assisterlo, né cugino né nemico, solo la sua ossessione. Un attimo dopo, la sua fine arriva in modo beffardo. Da un lato è la punizione (in un film dell’orrore più tradizionale, il “cattivo” che muore per la propria tracotanza), ma dall’altro è anche una liberazione dal trauma: Teddy esce di scena, non deve affrontare il crollo del suo mondo perché muore ancora convinto di aver avuto ragione (cosa che, ironicamente, è vera). In questo c’è una nota quasi pietosa: meglio la morte che la presa di coscienza per un’anima così ferita. Saranno gli spettatori e i pochi personaggi superstiti a subire l’orrore della verità rivelata.
In definitiva, Bugonia si dimostra non solo un esercizio di stile o un collage di riferimenti, ma anche un film con sostanza psicologica. Attraverso Teddy e Michelle esplora questioni attualissime: la sfiducia nelle istituzioni e la conseguente ricerca di identità in ideologie estreme; il bisogno di trovare un senso agli eventi traumatici, anche a costo di crearsi nemici immaginari; il conflitto tra realtà e percezione in un’era di informazioni distorte (tema che rientra nel concetto di “post-verità” già evidenziato dagli analisti del film). Il tempo, l’identità e il trauma si intrecciano nel racconto di due persone agli antipodi – un emarginato e una potente, un credente nel complotto e un’illuminata scettica – costrette in uno spazio chiuso dove le loro storie personali collidono con forze più grandi di loro (la cospirazione globale, anzi cosmica). Bugonia ci fa entrare nelle loro menti, ci fa provare empatia e disgusto alternati, e ci lascia alla fine con una visione amarissima: che forse le follie e i dolori individuali dell’uomo moderno sono insignificanti di fronte all’immensità del tempo e dell’universo. Eppure, fino all’ultimo secondo prima della catastrofe, quei dolori e quelle speranze sono l’unica realtà che conta per chi li vive. In questa consapevolezza sta la carica emotiva del film, nascosta sotto la sua superficie cinica.
Anatomia psicologica di Bugonia: trauma, complotto e catarsi crudele
Addentriamoci ora nel cuore pulsante (o sarebbe meglio dire ferita aperta) di Bugonia: la dimensione psicologica. Se togliamo gli strati di genere, di citazione, di satira sociale, troviamo al centro del film una storia profondamente umana di trauma e disperazione, declinata attraverso personaggi che incarnano patologie e difese ben riconoscibili. Bugonia può essere letto come un caso clinico estremo e come una metafora universale al tempo stesso: abbiamo un uomo, Teddy, segnato da un trauma primario (la “morte bianca” della madre e altre violenze subite) che sviluppa un sistema di convinzioni deliranti (complottismo) per dare senso al caos e proteggersi dal dolore; attorno a lui, interagiscono un complice-facilitatore (Don) con proprie fragilità identitarie, e un oggetto persecutorio (Michelle) che si rivelerà avere ambiguità e colpe reali. La loro interazione, come vedremo, è leggibile in termini di psicoterapia invertita, di transfer e controtransfer, e il loro destino finale appare come la tragica messa in scena di pulsioni profonde: il desiderio di guarigione contaminato e sovrastato dal desiderio di annientamento. Procederemo punto per punto, rifacendoci ai temi indicati (tra parentesi aggiungeremo concetti psicologici dove opportuno), citando anche teorie e paralleli clinici che aiutano a illuminare i comportamenti dei personaggi.
Il trauma originario: la madre assente e gli abusi subiti da Teddy
In ogni narrazione di follia c’è un trauma all’origine. Per Teddy, è evidente che il cuore del suo squilibrio risiede nella vicenda di sua madre Sandy. Dalle informazioni fornite (sia dai flashback che dal dialogo espositivo iniziale), sappiamo che Sandy era una donna con problemi di dipendenza (oppioidi) che entrò in una sperimentazione clinica di Auxolith (l’azienda di Michelle) per disintossicarsi; il farmaco sperimentale però ebbe effetti devastanti, lasciandola in uno stato vegetativo permanente. Questo evento – possiamo situarlo alcuni anni prima della storia presente – spezza la psiche di Teddy. Egli perde la madre non con una morte (che avrebbe dato luogo a un lutto convenzionale, per quanto doloroso) ma in una sorta di limbo senza fine: la madre è tecnicamente viva, respira, ma non c’è più come persona cosciente. Questa condizione è ciò che in termini poetici possiamo chiamare “morte bianca”, un ossimoro che ben rende l’idea di una presenza-assenza fantasmatica. Per un figlio, avere la madre in coma è un’esperienza lacerante: da un lato la speranza mai spenta che si risvegli (dunque l’impossibilità di chiudere emotivamente la relazione, di elaborare il lutto), dall’altro la sofferenza quotidiana di vederla lì immobile, incapace di reagire, quasi come un corpo senza anima. In psicologia, situazioni simili vengono dette perdite ambigue o lutti complicati: l’oggetto d’amore non c’è più nella forma conosciuta, ma non è neanche morto e sepolto – la mente fatica a decidere come sentirsi, resta bloccata in un dolore sospeso. Teddy molto probabilmente ha sviluppato un disturbo da stress post-traumatico (PTSD) legato a questo evento: i suoi flashback in bianco e nero che vediamo di tanto in tanto suggeriscono ricordi intrusivi e dolorosi connessi alla madre e al tradimento subito (ricordiamo, la madre stava fidandosi di un trattamento medico ed è stata rovinata da esso). Non solo, nel film originale (e nel backstory implicito qui) sappiamo che Teddy/Byeong-gu ha subito anche altri abusi: nell’originale si accenna a un padre violento e a bullismo subito a scuola e in carcere; Bugonia non rende esplicito tutto questo (non vediamo padre o scuola), ma possiamo inferire che Teddy non abbia avuto vita facile (la sua instabilità e aggressività suggeriscono un passato di traumi multipli, come spesso accade: un trauma primario attiva e aggrava i ricordi di traumi precedenti). Possiamo ipotizzare che, ad esempio, la madre tossicodipendente di Teddy forse era una madre negligente durante la crescita; magari Teddy ha dovuto prendersi cura di lei (inversione di ruoli genitore-figlio, ipotesi plausibile data l’età di Teddy ora, intorno ai 30-40 anni, e la madre malata da anni). Ciò significherebbe che il caregiver principale di Teddy era assente o inaffidabile ben prima del coma. In ogni caso, la madre ora ridotta a “vegetale” diventa per Teddy un buco nero psichico: egli non riesce ad accettare di averla persa e nello stesso tempo vive un senso di colpa survivor (sindrome del sopravvissuto): perché lei, e non io? Avrei potuto proteggerla? Questa colpa appare chiaramente quando Teddy di tanto in tanto biascica parole di rancore verso “quelli che l’hanno fatta così”. Egli proietta la colpa interamente su Auxolith e su Michelle, il che è giustificato oggettivamente (la ditta ha responsabilità) ma serve anche a sollevarlo dal peso soggettivo: è più facile incolpare un nemico esterno onnipotente che confrontarsi con il senso di impotenza che ha provato non potendo salvare la madre. Dunque, come reazione al trauma, Teddy sviluppa un sistema paranoico dove ogni cosa ha un perché: sua madre non è vittima di sfortuna o errori umani (troppo banale e insopportabile), ma di un complotto ordito da alieni malvagi travestiti da esseri umani.
Questa è una risposta psichica riconosciuta in psicologia: Freud scrisse che la paranoia può nascere da un tentativo di spiegare l’inspiegabile e da conflitti interni proiettati all’esterno (celebre il caso Schreber, il paranoico che credeva di essere vittima di un complotto cosmico e si “difendeva” costruendo un sistema delirante). Studi più recenti notano che il trauma e la sensazione di perdita di controllo sono predisponenti forti per lo sviluppo di credenze cospirative e paranoidi. Teddy incarna esattamente questo: l’universo gli ha fatto un torto intollerabile (ha deprivato il bambino interiore della sua mamma, e l’adulto del suo ultimo affetto), perciò egli rifiuta la realtà come la conosciamo e ne adotta una alterantiva che gli fornisce un nemico concreto da combattere. Nell’ottica psicoanalitica, potremmo dire che Teddy mette in atto un meccanismo di scissione e proiezione: scinde il mondo tra buoni (sé stesso e chi soffre come lui, ad esempio Don, e l’umanità comune) e cattivi onnipotenti (gli alieni travestiti da ricchi), e proietta tutto il suo odio, il suo dolore, la sua rabbia inconscia su questi cattivi. In particolare, Michelle diventa il contenitore psichico di tutto il male. Non è un caso che Teddy insista sul vederla come una creatura rettiliana senz’anima: egli de-umanizza Michelle completamente, il che lo autorizza a farle qualunque cosa senza rimorso, e contestualmente incanala su di lei l’odio che in fondo è la somma di tutti i torti subiti (non solo la madre, ma la sua vita sprecata, la miseria, l’impotenza). Una battuta chiave è quando Teddy urla a Michelle qualcosa come: “Voi [alieni/corporate] ci avete rubato tutto, ci avete avvelenato!”. Questa frase rivela che per Teddy Michelle è la personificazione di un agente persecutorio totale: non solo gli ha “ucciso” la madre, ma ha avvelenato il mondo (le api) e rubato il futuro (tecnoschiavitù, etc.). È un’iperbole, certo, ma riflette una dinamica interna: Teddy sente che la sua vita gli è stata rubata (non può avere una vita normale accudendo una madre vegetale, non può essere felice con quell’ombra addosso). Quindi il persecutore ha effettivamente privato Teddy di tutto ciò che aveva di dolce (la madre, le api – che sono simbolo anche di dolcezza e armonia).
Accenniamo anche alla possibilità che Teddy stesso possa aver subito abusi diretti: non viene mostrato nel film, ma potremmo immaginare – come per Byeong-gu nell’originale – che la sua infanzia fosse costellata di violenza domestica (forse un padre assente o crudele, o altri caregiver). Questo spiegherebbe la sua predisposizione all’aggressività e all’incapacità di elaborare diversamente il lutto. Uomini con storie di abuso infantile spesso covano una rabbia immensa che poi trovano modi distorti di esprimere. Teddy ha trovato la sua “missione” del complotto come valvola di sfogo e come razionalizzazione nobile della sua violenza: invece di dire “sono arrabbiato col mondo perché ho sofferto”, egli dice “io combatto gli alieni per salvare l’umanità”. Questo meccanismo ricorda i casi clinici di paranoia ideologica: l’aggressività interna viene proiettata fuori e giustificata come “giusta difesa”. Teddy si percepisce infatti come un giustiziere onesto (il nome Theodore “Teddy” curiosamente significa “dono di Dio”, e Don è appunto un devoto al “dono/missione” di Teddy – c’è quasi un senso messianico). Egli deve credere in quest’immagine di sé eroe per non sprofondare nella realtà cruda: che è un figlio traumatizzato, impotente di fronte a un sistema troppo più grande di lui. In termini di coping, Teddy sceglie il coping attivo ma delirante: reagisce al trauma passando all’azione (rapimento, vendetta) invece di collassare in depressione. Molte vittime di trauma sviluppano depressione o dipendenze; Teddy ha deviato sul delirio organizzato come via di fuga dall’eventuale crollo depressivo. In effetti, in un momento cruciale, vedremo che quando la sua certezza vacilla (dopo aver ucciso la madre con l’antigelo in preda alla manipolazione di Michelle), Teddy quasi entra in catatonia – come se la realtà sfondasse il suo delirio e minacciasse di farlo implodere. Quindi la struttura paranoide era fin lì protettiva: manteneva in vita la sua psiche.
Riassumendo, il trauma di Teddy legato alla madre e agli abusi subiti è il motore primario: ha generato in lui un vuoto affettivo colmo di rabbia, un bisogno di senso e una sete di punizione che confluiscono nel suo ruolo di rapitore paranoico. In un certo senso, tutto il film è il grido di dolore di un bambino ferito che il mondo non ha ascoltato. E qui Lanthimos fa sì che quel grido risuoni letteralmente nel microcosmo della cantina, come se stessimo assistendo a una drammatizzazione teatrale dell’inconscio di Teddy. Michelle legata al letto è la madre surrogate su cui Teddy esercita controllo, potere e anche un contorto tentativo di cura (vuole “purificare” l’aliena per salvare la Terra, come a dire: se salvo te, forse salvo anche mia madre – c’è un doppio legame simbolico, tanto che i flashback mostrano che Michelle era coinvolta nel farmaco di Sandy, quindi Teddy la vede direttamente come la guaritrice/stregona che potrebbe ridargli la madre o che gliel’ha tolta). Infatti quando Michelle insinua di avere una “cura aliena per la mamma” ecco che Teddy, malgrado tutto, ci crede – tanto forte è il suo desiderio che la madre torni. Questo è illuminante: la sua vulnerabilità è lì. Non importa quanto odi Michelle, se lei impersona improvvisamente la madre buona salvifica (dicendo: ho la cura per la mamma!), Teddy regredisce istantaneamente al bambino speranzoso e ingenuo. È un momento quasi commovente nella sua tragicità: quell’uomo torturatore appare di colpo come un figlio illuso, pronto a commettere un atto assurdo (mettere antigelo nelle vene della madre) perché la “strega cattiva” gliel’ha promesso. A livello inconscio, potremmo interpretare la scena dell’antigelo così: Teddy inconsciamente desidera porre fine alla sofferenza sua e della madre, e la manipolazione di Michelle lo porta a fare proprio questo (uccidendo la madre, la libera e si libera dal tormento – una sorta di “eutanasia inconscia”). E infatti la letteratura clinica su situazioni simili parla di ambivalenza nei caregiver di pazienti in coma: amano il familiare ma a volte inconsciamente vorrebbero che finisse quell’agonia reciproca. Michelle “dà il permesso” a Teddy di realizzare quell’impulso nascosto sotto la copertura illusoria di un salvataggio. È molto interessante sul piano psicologico: Teddy trasforma un desiderio di morte (sua madre muoia finalmente) in un atto di cura (crede di guarirla), così la sua psiche non collassa per senso di colpa. Solo dopo, quando vede la madre morta, la realtà lo colpisce e la sua struttura paranoica si incrina (da qui in poi appare più malleabile, preda del racconto di Michelle).
In conclusione su questo punto, possiamo dire che il trauma del protagonista (madre in coma e altri abusi) spiega quasi ogni suo comportamento: il complottismo, la scelta della vittima (proiettare sul potente alieno la figura dell’aguzzino e al contempo della guaritrice negata), la crudeltà (è la misura del suo dolore: più soffre dentro, più infligge fuori), e persino il suo linguaggio ricco di concetti pseudoscientifici (forse eredità di una mentalità volta a cercare spiegazioni razionali per l’irrazionale, un tratto spesso di chi subisce traumi e vuole capire il “perché”).
Dopo aver analizzato l’origine, proseguiamo verso le manifestazioni: in particolare, il complottismo come difesa e la dinamica psicologica con gli altri personaggi.
Il complottismo come difesa: quando l’ipersenso copre il nonsenso
Abbiamo già introdotto come il complottismo di Teddy sia una risposta al trauma. Qui lo esamineremo come meccanismo psicologico autonomo, anche di attualità. Negli ultimi anni, psicologi e sociologi hanno studiato il perché molte persone aderiscano a teorie del complotto, specialmente in periodi di crisi. Le ragioni includono: bisogno di controllo e certezza, canalizzazione di frustrazione verso bersagli definiti, senso di appartenenza a un gruppo con una “verità” speciale, e stile cognitivo manicheo (dividere il mondo in buoni/cattivi). Teddy incarna tutti questi punti.
Vediamoli uno a uno in lui:
- Controllo e certezza: di fronte all’imprevedibilità della vita (il male accade a caso, la madre è rovinata da un trial clinico che poteva capitare a chiunque), la teoria del complotto offre a Teddy una spiegazione chiara: “Non è il caso o l’errore, è un disegno deliberato degli alieni cattivi”. Paradossalmente, credere di essere vittima di un complotto può far sentire parzialmente meglio, perché implica che c’è una logica (perversa ma esistente) e che il soggetto era importante abbastanza da essere preso di mira (c’è un aspetto narcisistico nel credere di possedere verità segrete e di essere al centro di piani occulti). Teddy mostra esattamente questo narcisismo difensivo: lui si vede come l’eroe eletto che ha scoperto la verità (non a caso Don lo idolatra, alimentando la sua autostima di “profeta” della cospirazione). Questo è un analgesico per il suo ego ferito: invece di vittima inerme del fato, diventa protagonista attivo di una guerra cosmica.
- Frustrazione canalizzata: come discusso, Teddy sposta la rabbia dall’insensato (il destino) al sensato (i malvagi alieni). Così può agire: invece di deprimersi, organizza la missione vendicativa. La paranoia complottista è stata definita da alcuni autori come un meccanismo di coping ipervigilante, retaggio evolutivo di quando i nostri antenati dovevano essere costantemente in guardia da pericoli (predatori, tribù ostili). Sotto stress estremo, la mente preferisce vedere troppi pericoli che non vederne abbastanza (anche a costo di falsi allarmi). Teddy, in costante stato di allarme emotivo per il suo trauma, vede pericoli ovunque (pianeta in pericolo, ecc.), una sorta di iper-reattività traumatica convertita in ideologia.
- Senso di appartenenza e identità: Teddy e Don formano una micro-setta. Condividono credenze bizzarre, ascoltano gli stessi podcast, eseguono rituali (castrazione chimica per non farsi controllare psicologicamente, allenamenti paramilitari). Questo li unisce come noi contro loro. Per Teddy, il cospirazionismo supplisce la mancanza di legami genuini: la madre è assente, non sappiamo di altre relazioni (non ha compagna né altri amici se non Don). Quindi la teoria del complotto diventa la sua famiglia, la sua ragion d’essere. Don ne è la prova: lo segue come un adepto. Possiamo considerare Teddy come un guru paranoide: molte sette e culti reali sono guidati da leader con deliri di grandezza e persecuzione, che poi coinvolgono i seguaci nelle loro visioni (ci viene in mente ad esempio Marshall Applewhite della Heaven’s Gate, convinto di alieni e fine del mondo, che portò al suicidio di massa; oppure alcune frange QAnon con leader apocalittici). Teddy convince Don della presenza degli alieni e della necessità di un atto estremo (rapire e punire). Don, che ha difficoltà a capire il mondo da solo (essendo autistico, per come è presentato, si affida molto all’altro), trova in Teddy e nella sua narrativa un riferimento assoluto, dandogli un senso e uno scopo (diventa il suo identity). Ciò spiega perché Don, quando questo sistema crolla, collassa anch’egli tragicamente: la sua psiche era interamente appoggiata alla costruzione delirante condivisa, e quando questa vacilla (nel momento in cui la realtà del male che stanno facendo – torturare un’altra persona – lo colpisce emotivamente, vedendo Michelle soffrire e forse vedendo Teddy vacillare), Don non regge la dissonanza. Il suo suicidio è l’atto disperato di chi non può né andare avanti credendo alla missione (perché la coscienza gli dice che è troppo) né rinnegare la missione (perché equivarrebbe a perdere sé stesso e ad affrontare la colpa di ciò che ha fatto). In psicologia, questo richiama l’idea di collasso dell’illusione condivisa: nelle cosiddette folie à deux (follie a due, disturbo psicotico condiviso) a volte il soggetto dipendente, se il leader mostra segni di cedimento, reagisce in modo drastico. Don vede Teddy essere manipolato da Michelle e per un attimo sente la vittima come umana; ciò crea una frattura insolubile: tradire Teddy (impensabile per la sua identità devota) o tradire la propria nascente empatia e senso morale (cosa che la sua coscienza non vuole). Il suicidio avviene esattamente in questo conflitto: Don punta il fucile su Teddy, poi su Michelle, non sa chi colpire, alla fine rivolge l’arma verso di sé e preme il grilletto. Psicodinamicamente, si può vedere come Don, non potendo risolvere chi è il “cattivo” (Teddy che gli ha fatto fare cose orribili o Michelle che era la nemica designata?), punisce l’unica persona che può punire senza venire meno alla lealtà: se stesso. È un momento di auto-punizione tragica. Probabilmente Don provava colpa repressa per il male fatto (in qualche scena esprime dubbi), e quando quell’energia di colpa sale, la rivolge verso di sé letalmente.
- Pensiero manicheo e pattern-seeking: Teddy collega ogni evento negativo a un unico grande schema. Questo è tipico del pensiero cospiratorio: cercare pattern ovunque (collegamenti) e semplificare la complessità in una narrazione duale (noi vs loro, bene vs male). Ad esempio, i discorsi di Teddy (che emergono nei monologhi di rabbia) toccano varie piaghe: inquinamento, colonialismo tecnologico, classismo, apocalisse ecologica. Per lui tutto è riconducibile agli alieni (alias i potenti). È una forma di monotematicità esplicativa: invece di tante cause complesse (capitalismo, politica, caso, ecc.), una causa semplice e intenzionale. Questo gli dà sollievo cognitivo, come evidenziato dagli studi: chi sente di non capire le cause del male spesso abbraccia la teoria del complotto per ridurre l’incertezza e l’ansia. Nel film è ben rappresentato: Teddy appare paradossalmente più calmo e sicuro quando declama la sua teoria, rispetto ai momenti in cui la realtà lo spiazza (dopo l’antigelo, appare confuso e soggetto a Michelle). Finché è dentro la sua narrazione, Teddy ha un senso integrato di sé (per quanto illusorio); quando esce da essa, appare disintegrato (il crollo del suo sguardo, la disperazione muta).
Da questo si capisce che il complottismo di Teddy è una corazza che tiene insieme una psiche altrimenti frammentata dal trauma. In termini psicoanalitici, potremmo parlare di paranoia come difesa megalomanica contro la depressione: invece di essere il piccolo Teddy triste senza mamma (posizione depressiva kleiniana), egli è il Grande Teddy salvatore del mondo perseguitato da nemici (posizione paranoide-schizoide). In lui c’è anche una scissione netta: vede Michelle totalmente malvagia, incapace di considerarla umana e di avere empatia (fino a un certo punto almeno). Questa è la scissione tra oggetto cattivo assoluto e oggetto buono assoluto. Nell’infanzia, i neonati passano per una fase in cui la madre è percepita come due entità: la madre buona (quando soddisfa) e la madre cattiva (quando frustra). Se uno sviluppo è problematico, questa visione scissa può persistere in età adulta (in disturbi come borderline o paranoia). Teddy, avendo forse sperimentato una madre a volte negligente (quando era tossicodipendente) e a volte affettuosa, può aver interiorizzato una visione spaccata: ora tutto il buono era la “vera mamma” e tutto il cattivo è colpa degli “altri” (il mondo esterno). Così il mondo esterno è demonizzato per salvare l’immagine interna idealizzata della madre (questo è frequente: il paranoico spesso idealizza sé o i suoi cari, e di contro demonizza il resto). E se la madre l’ha tradito (tipo scegliendo la droga, o comunque lasciandolo solo andand in coma), è più facile credere che sia stata costretta da forze esterne maligne, non sua responsabilità. Ecco dunque che la teoria del complotto serve a preservare l’oggetto d’amore idealizzato: la mamma non era debole o colpevole, erano gli alieni che gliel’hanno fatta. In fondo, volendo, potremmo dire che tutto l’accanimento di Teddy su Michelle è un processo sostitutivo: punisce su Michelle la “madre cattiva” che ha fatto del male a quella buona. (Curioso notare: Michelle è una figura femminile autoritaria e materna negativa: è bionda, elegante, fredda – quasi la caricatura di una dark mother, come la matrigna nelle favole. Uccidere/punire lei è come esorcizzare la madre cattiva dall’universo psichico di Teddy, lasciando solo la madre buona idealizzata che può riposare in pace).
Questa lettura è corroborata dalla dimensione quasi incestuosa di alcune scene: Teddy rasando e spogliando Michelle, cospargendola di lozione, compie gesti che hanno una valenza di aggressione sessuale ma anche di controllo sul corpo femminile. Potrebbe riflettere inconsciamente un desiderio di possesso totale della figura materna (invece la madre reale gli sfugge in coma, quindi sfoga su Michelle). Dico incestuosa non nel senso letterale, ma a livello simbolico: rifare su un’altra donna gesti intimi come radere, legare, comporta che quell’altra donna è caricata del significato della prima donna – la madre. Ci sono studi psicoanalitici su come l’odio estremo del paranoico verso un persecutore possa celare un amore/identificazione distorto e un conflitto edipico sotterraneo.
Ora, un elemento importante: Bugonia, come film, appare consapevole di rappresentare il complottismo come difesa perché non giudica i suoi personaggi semplicemente come “pazzi cattivi”, ma ne mostra la sofferenza sottostante. Ad esempio, la scena quasi tenera (per quanto orrifica) in cui Teddy e Don ballano insieme in casa ascoltando “Where Have All the Flowers Gone?” (che nel finale tornerà) come due ragazzini spensierati per un attimo – è un momento che rivela la loro umanità ferita dietro la facciata da “guerrieri antisistema”. Sembrano due cugini che sfuggono per un attimo al peso del loro piano e si concedono una distrazione nostalgica. È come vedere il bambino innocente che ancora vive in Teddy emergere per un minuto, prima che la missione lo riassorba. Questo invita lo spettatore a provare una certa empatia: ci rendiamo conto che i complottisti qui non sono solo caricature, ma individui con un background emotivo comprensibile (certo, arrivato a esiti orribili – il film non li assolve affatto, e discute anzi se forse non siano mostri quanto Michelle).
La questione posta è: Teddy e Don sono eroi o folli? Lanthimos mantiene ambiguità fino quasi alla fine: la rivelazione che “Teddy aveva ragione su molti dettagli” (l’alieno esiste, il modo in cui comunicano coi capelli era vero, ecc.) complica moralmente il giudizio. Da un lato, aveva ragione a vedere un complotto – quindi il suo delirio era realtà. Dall’altro, la sua reazione è stata ugualmente condannabile e i suoi difetti rimangono. Questa è una riflessione affascinante sul complottismo come difesa: anche se a volte il paranoico coglie reali ingiustizie e inganni nel mondo (perché viviamo in un mondo con veri complotti di potenti!), ciò non giustifica né sana la distruttività con cui reagisce. Teddy ha colto qualcosa di vero (Michelle è letteralmente un’aliena invasore), ma il film ci lascia con la netta impressione che ciò non lo rende un eroe positivo. Infatti, dopo tutto, la vendetta di Teddy non salva il mondo – al contrario, lo condanna. La sua crociata consegna proprio all’aliena il pretesto per sterminare l’umanità (nel racconto di Michelle, loro cercavano di salvarci, è la ferocia di Teddy che la porta a decidere che meritiamo l’estinzione). Qui c’è un parallelo con Jacob’s Ladder: a fine film scopriamo che i demoni che tormentavano il protagonista erano in parte causati da una droga bellica; in Bugonia, il “demone alieno” era reale ma in fondo l’uomo ha fatto comunque tutto da solo (Teddy e Don hanno portato l’umanità alla rovina; l’alieno stava quasi per forse salvare sua madre se avesse giocato diversamente le carte, chi lo sa). È una visione pessimistica: che la difesa paranoide in ultima analisi auto-avvera le catastrofi che voleva evitare (profezia che si autoavvera). È come se Lanthimos ci mettesse in guardia: “Attenzione, diffidare di tutto e reagire con violenza produce esattamente ciò che si temeva – la fine di ogni umanità”. Questa è una fine didattica: le ideologie complottiste e l’odio polarizzante (che vediamo anche oggi in società) rischiano davvero di condurci a rovina collettiva, mentre la natura (le api) continuerà a vivere.
Dunque, il film non sposa né condanna acriticamente il punto di vista di Teddy; lo comprende, ma ne mostra anche l’autodistruttività. Da psicologo, trovo questo approccio molto fedele alla realtà clinica: i complottisti spesso nascono da ferite vere, da sacrosante sfiducie (chi non diffida di Big Pharma dopo scandali reali?), ma poi possono diventare vettori di distruzione se seguono la spirale di paranoia all’eccesso (si veda chi rifiuta cure mediche salvavita per complottismo e muore, o atti terroristici basati su teorie di cospirazione). Lanthimos ha trasformato questo dinamismo in un racconto estremo: il complottista aveva ragione che c’era un virus letale ma reagendo male ha sterminato la specie – metafora iperbolica di tante situazioni.
Per chiudere questo punto: il complottismo di Teddy è la sua armatura e la sua condanna. Lo ha tenuto in vita dopo il trauma, ma l’ha spinto a commettere atti irreparabili. In psicoanalisi potremmo dire: la difesa si è trasformata in sintomo mortifero. Quando le difese primitive (paranoia, scissione) dominano, l’Io alla fine crolla o causa grandi danni. E in Bugonia ne vediamo l’apice.
Passiamo ora a un’altra angolatura: la dinamica tra i personaggi – che il quesito definiva come “seduta di psicoterapia inversa”.
Teddy, Michelle e Don: una psicoterapia al contrario
La relazione triangolare tra Teddy (terapeuta-torturatore), Michelle (paziente-prigioniera) e Don (osservatore-partecipante) può essere letta come una seduta terapeutica rovesciata. In una psicoterapia classica, il paziente parla, il terapeuta ascolta e pone domande per portare alla luce la verità interiore del paziente. Qui succede quasi l’opposto: il “paziente” Michelle è costretto (torturato) a parlare, e il “terapeuta” Teddy incalza con domande e accuse; però in realtà chi svela verità su se stesso pian piano è Teddy, non Michelle. E a un certo punto i ruoli si invertono e sembra che Michelle diventi la terapeuta/manipolatrice di Teddy, portandolo a confrontarsi con la sua verità (il trauma della madre e la colpa). E Don, come un co-terapeuta o come parte del setting, reagisce emotivamente a questi scambi. È un gioco di ruoli molto interessante:
- Inizio: Teddy conduce l’“interrogatorio” (seduta) di Michelle. Le sue domande però suonano come interpretazioni: lui già “sa” la verità e vuole che lei la confessi (es. “Tu sei un’aliena malvagia, ammettilo!”). È come un terapeuta impaziente e arrogante che vuole imporre al paziente la sua interpretazione invece di ascoltare. Questo naturalmente genera resistenza: Michelle nega, contro-manipola, gioca con le parole. Vediamo momenti in cui lei quasi spinge Teddy a rivelare di più di se stesso. Per esempio, Michelle usa corporate-speak e fa leva su emozioni, cercando di instillare dubbi su Don o su come appaiono (“Siete di bassa classe, invidiosi?”, “Le tue api forse morivano per colpa tua e cerchi un colpevole esterno?” – ipotizzo battute del genere). Sta di fatto che, come nota Ebert, “Michelle spesso parla con quel tono passivo-aggressivo da manager che non solo suona alieno a Teddy ma lo fa impazzire”. Questo è efficace: come un paziente restio, Michelle testa i limiti e provoca transfert. Infatti Teddy reagisce emotivamente (perde la calma, la colpisce, oppure rivela i suoi rant interni). Ogni reazione di Teddy rivela pezzi di sé: il rancore verso i ricchi, la frustrazione di non essere ascoltato, la rabbia di chi si sente inferiore. Michelle funge involontariamente (o volontariamente?) da specchio deformante: riflette a Teddy la sua impotenza e inadeguatezza, e lui reagisce svelandola. In psicoterapia, a volte il paziente punge per vedere le reazioni del terapeuta e su quelle reazioni emergono contenuti controtransferali (cioè del terapeuta). Qui Michelle punge e fa emergere i contenuti del “terapeuta” Teddy.
- Svolta: Avviene con la scena dell’antigelo. A quel punto Michelle, grazie alle proprie doti di manipolazione, prende il controllo della “seduta”. Lei conduce Teddy a mettere in atto qualcosa di rivelatore del suo inconscio: l’uccisione della madre. In termini psicoanalitici, potremmo dire che agisce il suo desiderio rimosso. Michelle assume quindi il ruolo di analista malvagio: invece di aiutare il paziente a capire i propri impulsi autodistruttivi, lo spinge a realizzarli letteralmente. È come se un terapista, vedendo che il paziente ha istinti suicidi o omicidi, gli dicesse “vai, fallo pure, è giusto”. Michelle qui incarna un Super-io distruttivo, un analista sadico che vuole la rovina del paziente. Naturalmente, questo non è una vera terapia, ma una psicoterapia invertita e perversa, appunto. E Teddy cede: si fida della “autorità” di Michelle come un paziente regredito si fida di un analista, e compie quell’atto finale con un misto di speranza e disperazione (lo vediamo precipitarsi in clinica, affannato, come un figlio che crede al miracolo promesso, e poi somministrare l’antigelo nella flebo tremando ma convinto). Questa scena è potentissima in chiave psicologica: è la demolizione di Teddy. Quando torna, la sua grandezza paranoide è in frantumi. In termini di transfert, potremmo dire che Teddy ha trasferito su Michelle la immagine di madre onnipotente guaritrice, e lei l’ha sfruttata per fargli fare l’irreparabile. Dopo di che, lei diventa la voce della verità nera: gli racconta, presumibilmente, la storia vera degli Andromedani e gli sbatte in faccia che gli umani sono loro stessi la causa del male. Quasi come un analista severo che, alla fine, dice al paziente: “Vedi? Era colpa tua, tu hai fatto questo, tu sei distruttivo”. Michelle gli dice in sintesi: “Tu credevi volessimo distruggervi, invece siete voi umani che vi distruggete da soli”. Ecco la interpretazione finale, crudele ma non priva di verità: Teddy ha distrutto la propria madre, la propria famiglia (Don morto), e sta per distruggere se stesso, tutto da solo – il complotto alieno era quasi irrilevante. Questa è una verità che, in un contesto terapeutico, porterebbe forse il paziente a un crollo emotivo catartico. In Bugonia porta a… un colpo di scena di genere (non sappiamo se Teddy creda pienamente a lei o no in quel momento; è ancora incerto, ma appare stordito e soggiogato).
- Dopo la svolta: Michelle è in possesso delle chiavi. Le catene fisiche se le toglie (prende le chiavi dal cadavere di Don), e quelle psicologiche le ha passate a Teddy (ora incatenato ai suoi sensi di colpa). Il film fa persino dubitare: e se Michelle stesse facendo leva sullo stato fragile di Teddy per riscrivere la narrativa a suo favore? E se stesse mentendo su essere buoni loro? Il fatto che la verità resti ambigua per un po’ e solo nel finale il dubbio si dissolva, rende tutto questo scambio molto dialettico. Ma i ruoli sono invertiti: Michelle conduce, Teddy risponde (portando la bomba, ma ormai come ultima risorsa folle – come un paziente suicida che minaccia di farsi saltare in aria se la verità è insopportabile). Paradossalmente, quell’ultima scena in ufficio è come una seduta conclusiva in cui il paziente (Teddy) dice: “Se devo accettare questa realtà vi faccio saltare tutti per aria, me compreso”. È l’equivalente di un acting out suicidario in terapia quando il soggetto scopre verità di sé che non tollera. E l’analista che fa? Nel film, l’“analista” Michelle finge di calmare il paziente (dice: “ti teletrasporto, vedrai, fidati”) ma in realtà orchestra la sua fine (fa esplodere la bomba in modo che muoia). Un vero analista ovviamente non farebbe così, cercherebbe di salvare il paziente. Qui invece è come se la psicoterapia al contrario giungesse all’esito più nefasto: il paziente, anziché salvarsi, viene portato all’auto-annientamento. Questo completa il parallelo invertito: una terapia normale vuole guarire e dare insight che salvano; questa “terapia” del complotto porta Teddy ad acquisire un insight finale (“l’umanità è marcia e anch’io lo sono”) che lo porta al death drive, la pulsione di morte pura (farsi saltare).
- Il ruolo di Don: Don in questo scenario triadico può essere visto come il Superego innocente o l’Io ausiliario che commenta. All’inizio, Don fa da specchio rinforzante: come un co-terapeuta ingenuo, crede a tutto quel che il “terapeuta” capo dice e prova a partecipare, ma mostra anche empatia (ad esempio dice: “Teddy, forse dovremmo darle una pausa? Sta soffrendo”, oppure quando le dà acqua). Questo è come la parte empatica di uno psichiatra malvagio che fa capolino. Don incarna la morale ingenua: sa che far del male è di per sé sbagliato, ma l’autorità di Teddy gli fa reprimere quel senso morale. Nel momento di crisi (quando vede Teddy cedere a Michelle e fare cose sbagliate come avvelenare la mamma), il Superego di Don va in overdrive e punisce come detto se stesso. Questo potrebbe anche riflettere la coscienza morale collettiva: Don è quell’umanità ingenua che se vede i suoi leader (Teddy) tradire i principi, preferisce togliersi di mezzo. Potremmo compararlo a uno psicodramma interno di Teddy: forse Don rappresentava la sua parte cosciente buona (il figlio affettuoso, la persona gentile) che viene schiacciata e “uccisa” nel processo (Teddy sacrifica la sua bontà in nome della missione – Don letteralmente sacrifica la vita). Così resta solo la parte dark (Teddy isolato). È come dire: nella psiche di Teddy, la compassione è morta, uccisa dal conflitto, aprendo la strada al finale tragico senza contrappesi.
Parliamo anche di camera dell’eco, citata nel quesito. L’“echo chamber” in psicologia sociale è l’ambiente chiuso in cui un gruppo si conferma convinzioni a vicenda senza confronto esterno. La casa di Teddy e Don è letteralmente quell’eco-chamber: due persone che si raccontano storie e non ascoltano altri. Quando portano Michelle in quell’ambiente, cercano inizialmente di costringerla ad aderire al loro “eco”: vogliono che confessi, che dica “sì, avete ragione su tutto”. Lei resiste, finché volge la situazione a suo vantaggio: paradossalmente, alla fine l’eco-chamber rimane (Teddy ascolta solo ciò che conferma la sua negatività – quando Michelle cambia versione e dice “sì, l’umanità fa schifo”, sta in un certo senso confermando quello che Teddy già sentiva, solo riformulato). Quindi l’echo-chamber conspirativa viene in parte pervertita in echo-chamber misantropica: alla fine tutti i personaggi concordano che l’umanità merita di finire (Don l’ha affermato uccidendosi, Teddy con l’atto suicida, Michelle con la decisione finale). Questa unificazione di prospettiva suona come un “ecco l’eco finale: siamo tutti d’accordo che l’unica soluzione è l’apocalisse”. Che è l’eco-chamber definitiva, senza contraddittorio, preludio del silenzio totale (l’umanità muta per sempre).
Da un punto di vista psicologico, l’eco-chamber è dannosa proprio perché esclude ogni voce dissonante. In Bugonia, l’unica voce dissonante potenziale era la realtà (gli alieni forse non esistono, oppure se esistono, potrebbero non essere come pensi). Ma quell’eco-chamber iniziale era forte: Teddy e Don interpretavano ogni segno a modo loro (ad esempio, i comportamenti di Michelle, come prendere vitamine, li vedevano come “prove” che è aliena). Ciò riflette come, in una setta o nella mente paranoide, qualunque evento viene assimilato nello schema preesistente. Abbiamo esempio: lei scappa un attimo -> “ha poteri telepatici, lo sapevo”; i capelli -> “vedi, erano la sua antenna”; la luna si avvicina -> “lo sapevo, la Terra si sta appiattendo per loro” (questo era il film che mostrava visivamente, ma per Teddy è segno di cospirazione).
In conclusione di questa sezione: Bugonia mette in scena una relazione terapeutica distorta dove l’analisi porta non alla guarigione ma all’annientamento. Ciò rispecchia il concetto di psicoterapia selvaggia o manipolazione mentale: se un “terapeuta” (qui il leader di setta) ha obiettivi distruttivi, può portare i suoi soggetti alla rovina. Non dimentichiamo che Save the Green Planet! era anche uno studio sul fanatismo e l’autoillusione. Bugonia spinge questo fino alle estreme: è come se l’unico esito di quell’analisi reciproca fosse la conclusione nichilista su tutta la condizione umana.
Questa conclusione la svilupperemo nel capitolo finale, ma prima c’è un ultimo tema psicologico interno da approfondire: la figura materna e femminile (già toccata), le scosse elettriche e sperimentazione come simboli, e l’autismo e identità frammentata di Don (già integrato un po’, ma possiamo completare).
La madre “bianca” e la donna aliena: figure femminili e pulsioni di vita/morte
Nel film abbiamo principalmente due figure femminili: Sandy, la madre di Teddy, e Michelle, la CEO/aliena. Entrambe, a modo loro, rappresentano la femminilità e la maternità, ma in due stati opposti: Sandy è la madre inerte, quasi defunta (maternità “bianca” sterile), mentre Michelle è una figura fertile di potere (lei è un’imperatrice aliena, quindi madre di un popolo in un certo senso, creatrice di nuova vita, e allo stesso tempo è sterile di empatia forse). Queste due figure riflettono un concetto psicoanalitico classico: la divisione tra la madre buona e la madre cattiva. L’ombra di Euridice/Orfeo dal mito di Aristeo appare qui rovesciata: Aristeo scese per cercare perdono e nuova vita per le sue api e ne riottenne, qui Teddy scende (metaforicamente nel suo basement/inferno interiore) per tentare di ridare vita alla madre (le sue “api”), ma fallisce e scambia Euridice (la madre) con la morte definitiva (Euridice fu persa per sempre quando Orfeo si girò; qui Teddy “si gira” a credere a Michelle e perde per sempre la madre). Questo parallelo mitologico arricchisce la lettura: Bugonia gioca con la coppia madre viva-ma morta (Sandy) e madre-non madre aliena (Michelle). Anche mitologicamente Michelle può essere vista come una Persefone al contrario: Persefone era regina dell’Oltretomba e portava morte ma anche ciclicità (stagioni); Michelle è regina aliena che porta morte ma forse farà ripartire un ciclo (nuova vita sulla Terra?). Persefone fu rapita; qui l’aliena è rapita ma poi libera, quasi un rovescio.
Psicologicamente, la madre di Teddy è una “morte bianca” che incarna la depressione e l’arresto della vita psichica (Teddy è rimasto fissato a lei, in un lutto congelato, e questo ha congelato la sua capacità di progredire – è come se fosse rimasto un figlio infantile col bisogno di mamma). Michelle invece incarna la donna che inganna e domina, uno stereotipo quasi misogino (la femme fatale fredda) ma qui con un twist: è davvero un altro essere. Lei utilizza la propria femminilità come arma (sa di essere attraente? Non lo enfatizza sessualmente, ma sicuramente la dinamica è genere-gioco di potere). Potremmo ipotizzare che per Teddy, che appare senza compagna, la femminilità al di fuori della madre sia percepita come minacciosa e aliena. Questo è comune in personalità che hanno rapporto simbiotico con la madre: la figura di un’altra donna è percepita come estranea, e combinato con paranoie, diventa letteralmente aliena. Non viene mostrata alcuna componente sessuale esplicita tra Teddy e Michelle (non c’è molestia sessuale diretta, anche se la spoglia, è più per degrade), ma sottotraccia la tensione è lì: un uomo che tiene una donna prigioniera, nuda, incatenata, ha un sottotesto erotico-distorto forte. Si può arguire che Teddy reprime attrazione e la trasforma in violenza, perché vede la donna (oltre la madre) come pericolosa. Un residuo di complesso di Edipo non risolto: se la madre è idealizzata, le altre donne o minacciano quell’immagine o vengono percepite come irrilevanti. Quindi Michellle va dominata e punita, non desiderata. Teddy probabilmente proietta su di lei la rabbia verso la madre che l’ha “abbandonato” (in coma): punisce la donna attiva perché la donna amata era passiva e l’ha deluso.
Le scosse elettriche e sperimentazioni nel film: Teddy effettua esperimenti su Michelle (lozione, rasatura, minaccia di shock?), e la detiene in un setting da tortura scientifica (ha apparecchiature e procedure, come se seguisse un protocollo). Questo aspetto riflette doppio:
- Da una parte, il desiderio di Teddy di replicare su lei ciò che fu fatto alla madre (Sandy fu soggetto di un esperimento clinico finito male; ora lui fa di Michelle una cavia – letteralmente invertendo i ruoli: da figlio di cavia a sperimentatore su “dottore malvagio”). È un modo di rivivere attivamente il trauma invertendo potere, un noto meccanismo chiamato rivincita traumatica. Egli identificazione con l’aggressore: Auxolith fece esperimenti crudeli => ora Teddy (vittima) diventa sperimentatore crudele su Auxolith (personificato in Michelle). Questo porta un effimero senso di controllo (falso, perché come vediamo quell’identificazione lo rende comunque servo del trauma: non guarito, ma aggravato).
- Dall’altra, le scosse elettriche, i liquidi chimici (antigelo), ecc. possono essere visti come simboli di pulsioni distruttive e creative insieme. Elettricità è spesso associata a vita (shock per rianimare) ma anche tortura (elettroshock forzato). Antigelo è assurdo come “cura” ma richiama il concetto di Freddo vs Caldo in vita/morte (antigelo per congelare, come mantenere la madre in morte bianca – difatti la uccide, quell’atto “congela” la sua vita per sempre). Sperimentare su Michelle è per Teddy una illusoria ricerca di verità (come uno scienziato che vuole scoprire segreti del corpo alieno) e insieme un sadismo vendicativo. In ambito psicologico forense, torturatori spesso razionalizzano i loro atti come “esperimenti” o “necessità” per ottenere informazioni, qui Teddy letteralmente vede così: non sta torturando per sadismo (nella sua testa) ma per far emergere la verità e salvare il mondo. Questo è l’aspetto luciferino della ragione strumentale senza etica: riflette in piccolo le colpe di Auxolith (che mise a rischio vite come quella di sua madre per testare farmaci). Teddy finisce per imitare esattamente l’amoralità scientifica che condannava. C’è ironia: criticava i potenti per giocare con la vita umana, ora lui gioca con la vita di Michelle (che è umana in apparenza). Dunque le “sperimentazioni” sono un tema di ciclo di abuso e ipocrisia: l’abusato diventa abusante.
Passiamo a Don e lo spettro autistico: Già abbiamo mostrato la funzione di Don come “coscienza innocente” e la tematica della neurodiversità (autismo) come rappresentata. Aidan Delbis ha detto in interviste che è contento di rappresentare un personaggio autistico complesso. Don mostra alcuni tratti: comunicazione un po’ monotona, eccessiva fiducia nella routine (segue le direttive di Teddy pedissequamente), difficoltà a gestire le emozioni complesse (va in meltdown quando conflitto morale troppo alto – il suicidio è un meltdown tragico). Inoltre, Don sembra avere pensiero concreto: quando Teddy spiega cose, lui le prende alla lettera e le sposa. Socialmente, appare isolato e dipendente. Questi elementi rendono credibile il fatto che sia rimasto invischiato nella delusione di Teddy: molti complotti attraggono persone neurodivergenti che faticano con l’ambiguità e trovano rassicurante un mondo bianco/nero e regole chiare (questo non è per stereotipare, ma ci sono testimonianze di alcune persone autistiche attratte da ideologie rigide perché il mondo neurotipico è confuso e spaventoso). Don sicuramente trova in quell’universo cospirazionista un rifugio strutturato (ricordiamo come segue i contdown di Teddy, l’esercizio fisico disciplinato, la cameretta piena di manichini e ritagli che c’è in casa – quell’ordine lo calma forse).
L’identità frammentata di Don: Il quesito lo menziona. Potrebbe riferirsi al fatto che Don esita e sembra spezzarsi tra due identità: il soldato leale e il ragazzo gentile che non vuole far male. La sua autodescrizione forse direbbe: “Sono un bravo cugino che aiuta Teddy” – ma ad un certo punto percepisce che aiutare Teddy contraddice l’essere una brava persona, e la sua identità va in frantumi (frammentata). Da qui potremmo dire che Don perde integrità del sé e non potendo integrarla, si frammenta fisicamente (purtroppo attraverso il suicidio). Nel contesto autistico, a volte parlano di “identità frammentata” per la difficoltà a integrarsi socialmente, ma qui è più esistenziale: Don non può conciliare i pezzi di se stesso.
Un’interpretazione ancora: Don può rappresentare la parte rimasta umana di Teddy (quella che prova empatia e dubbi). Quando muore, è come se Teddy perdesse quell’ultima umanità. Ciò lo rende vulnerabile a diventare quasi robotico nelle mani di Michelle. C’è una breve scena dopo il suicidio in cui, con Don morto lì, Michelle e Teddy dialogano più “civilmente”. Come se, tolto di mezzo Don (umano fragile), restino due creature quasi autistiche/emozionalmente spente a ragionare (un sociopatico alieno e un paranoico in shock). Non è un caso che la rivelazione dell’alieno avvenga dopo la morte di Don: finché Don (emotività) era presente, c’era caos emotivo; tolto quello, la fredda verità può emergere, come in un laboratorio. Cinematicamente funziona anche: elimina il personaggio di troppo per il duello finale, ma simbolicamente è l’eliminazione della innocenza rimasta.
In sintesi, la dimensione psicologica di Bugonia rivela un intrico di traumi, difese e rapporti di forza invertiti. Teddy: traumatizzato che diventa persecutore per non essere più vittima, ma resta vittima delle sue difese. Michelle: persecutore esterno che sfrutta i punti deboli del traumatizzato, incarnando la realtà brutale. Don: innocente che cerca di essere buono dentro un contesto malvagio e ne viene schiacciato. Lo scenario appare quasi di una tragica seduta familiare: Teddy (figlio arrabbiato), Michelle (madre adottiva severa), Don (fratello innocente) – finisce in tragedia familiare (madre punisce figlio, fratello si uccide – se volessimo vederla così). Non a caso, la scena finale con tutti gli umani morti è presentata come “ogni figlio della Terra è caduto al suolo, mentre la canzone chiede dove sono finiti tutti i fiori (i figli)”. Un possibile sottotesto è: nel conflitto insanabile tra generazioni e poteri, l’umanità ha perso i suoi figli (flowers gone) e resta solo la madre Terra con le api. È una visione molto cupa del fallimento intergenerazionale, che peraltro nel contesto attuale risuona: le nuove generazioni accusano le vecchie di aver rovinato il pianeta, c’è rancore, l’eco-chamber di contrapposizione, e forse finiremo tutti male. Qui arrivo all’interpretazione finale in chiave psico-filosofica: quell’ultimo messaggio su stato dell’umanità, futuro e ciclo vita-morte-rinascita.
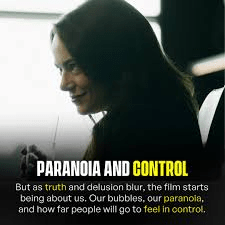
Apocalisse e rinascita: interpretazione psico-filosofica finale di Bugonia
Alla fine di questo lungo viaggio, Bugonia ci lascia con un’immagine indelebile e disturbante: la Terra come un grande cimitero silenzioso, gli esseri umani collassati a terra in un istante, e solo le api (e forse qualche altra creatura) ancora in movimento a indicare che la vita continua, ma senza di noi. Su queste immagini, la voce di Marlene Dietrich intona “Where Have All the Flowers Gone?”, un lamento sul ciclo insensato di guerra e morte che porta via i giovani (“dove sono finiti i fiori? Le ragazze li hanno colti; dove sono finite le ragazze? Hanno preso marito; dove sono finiti i giovani uomini? Andati in guerra; dove sono finiti i soldati? Nei cimiteri; dove sono i fiori? Sono spuntati sui cimiteri…”). La canzone stessa, circolare, suggerisce l’eterno ripetersi di nascita, giovinezza, violenza, distruzione e di nuovo nascita che sgorga dalla morte. In Bugonia, letteralmente vediamo i fiori che tornano (le api, agenti di impollinazione, ritornano ai loro alveari – segno che i fiori torneranno a fiorire adesso che gli uomini non li falciano più). Dunque, la conclusione del film ha una valenza insieme psicoanalitica, filosofica ed ecologica: è una riflessione sul destino dell’umanità e sulla ciclicità vita-morte-rinascita che trascende le vicende dei singoli personaggi.
Proviamo a scomporla e interpretarla da più angolazioni:
- Misantropia e giudizio sull’umanità – Nel finale, come già accennato, Bugonia pronuncia quasi un verdetto: “l’umanità è un esperimento fallito”. Questa frase, praticamente detta da Michelle, risuona come il giudizio di un dio o di un super-io implacabile. Lanthimos, da outsider (un greco che guarda l’Occidente, un artista che osserva la società), si fa portavoce di un sentimento di disillusione estrema verso la specie umana. Si tratta di un tema che appare in vari suoi film, ma qui è portato all’apice: la punizione ultima è inflitta, l’apocalisse avviene, e lo spettatore è costretto a chiedersi: “È meritata?”. Il film costruisce, paradossalmente, una certa comprensione del perché avviene: abbiamo visto in piccolo come gli esseri umani (Teddy, Michelle, i poteri) siano egoisti, violenti, incapaci di rompere il ciclo di vendetta e paura. “Gli esseri umani non possono far a meno di autodistruggersi”, afferma Michelle, e nulla nel corso degli eventi ci fornisce prove del contrario. Anzi, il film suggerisce che nessuno dei due lati (né i “ribelli” né i “potenti”) possiede vera virtù o saggezza. Teddy e Don – i “poveri diavoli” – finiscono per fare cose orribili e scatenare la catastrofe; Michelle – la “potente” – sfrutta e mente e poi, benché affermi che le intenzioni aliene erano buone, prende una decisione spietata (sterminarci). Anche se volessimo dire che gli alieni avevano provato a salvarci, la risoluzione finale è comunque che nessuno ha voluto più salvarci. Si ha l’impressione che Lanthimos stia amplificando un sentimento diffuso nel nostro tempo: l’umanità si trova di fronte alle conseguenze delle proprie azioni (cambiamenti climatici, disuguaglianze, conflitti) e sembra incapace di invertire la rotta, quasi come se inconsciamente desiderasse la propria fine. In termini psicoanalitici, questo è il trionfo di Thanatos – la pulsione di morte – sulla pulsione di vita (Eros). Freud teorizzò che le due pulsioni coesistono nell’uomo; Bugonia mette in scena la vittoria di Thanatos: tutti i personaggi principali muoiono, e con loro l’intera civiltà. Non a caso, l’ultimo gesto di Michelle sul suo pianeta natale è scoppiare una bolla che contiene un modello della Terra, come fosse un globo di vetro: un atto semplice e simbolico che richiama tanto la fragile bolla in cui viviamo quanto l’atto di “spegnere” l’esperimento. Puf, finito. In quell’atto c’è anche un commento meta-cinematografico: l’intera vicenda umana, con tutte le sue sofferenze e drammi, appare dal punto di vista alieno come una bolla da far scoppiare, un niente. Questo risuona con correnti filosofiche del pessimismo e del nichilismo: da Schopenhauer a Ligotti, l’idea che la vita umana sia intrinsecamente fallimentare e forse sarebbe meglio la sua estinzione. Nel film, quel gesto è presentato quasi senza enfasi, come una scelta logica: l’esperimento Terra non funziona, si elimina. È il grado zero di empatia, la razionalità tecnocratica spinta oltre i limiti morali (non diversamente, verrebbe da dire, da come a volte le nostre élite considerano sacrificabili masse di persone per il “bene del sistema” – un parallelo critico che il film sottende).
- Il ciclo vita-morte-rinascita – Tuttavia, Bugonia non finisce nel buio totale. Dopo la strage, ci mostra la rinascita della natura: le api tornano agli alveari, libere dai pesticidi e dall’interferenza umana. È un piccolo segnale di speranza, ma una speranza senza l’uomo. Questo completa la metafora della bugonia: dall’enorme carcassa dell’umanità (miliardi di corpi in decomposizione) sorgerà nuova vita. Invece che api da un singolo bue, qui la “sacra ecatombe” di corpi umani (il film li mostra “dolcemente” caduti, senza sangue: la morte bianca su scala di massa) nutre e libera la biosfera, come se l’uomo fosse stato il cancro della Terra e la sua eliminazione fosse una chemio efficace. È un pensiero radicale che appare in alcuni ambienti (movimenti antinatalisti estremi, l’idea che la Terra starebbe meglio senza di noi). Lanthimos lo mette in scena letteralmente. Dal punto di vista del mito, questo richiama storie di punizioni divine (il Diluvio universale, ad esempio, dove l’umanità peccatrice viene sommersa tranne pochi giusti; o Sodoma e Gomorra distrutte dal fuoco). Qui però non c’è un Noè che si salva: tutti vengono puniti indiscriminatamente. In ciò, più che al racconto biblico, il finale assomiglia a un cataclisma “pagano” in cui la natura si riprende il suo spazio ciclico. Forse potremmo connettere ciò con il mito induista o buddista dei cicli cosmici: ogni civiltà e era giunge a fine e poi rinasce in altra forma. Bugonia nel finale sembra dire: fine dell’era dell’uomo, forse un’altra forma di vita prospererà (magari le api stesse, o gli alieni prenderanno il nostro posto, non è chiarito). Il tema della ciclicità è sottolineato dalla scelta della canzone e dalla struttura circolare delle immagini (i corpi nutrono i fiori e le api, quasi un ritorno al Giardino Edenico senza Adamo). Da notare: la canzone “Where Have All the Flowers Gone?” termina con i versi “When will they ever learn?” ripetuti, cioè “Quando mai impareranno?”. Questa domanda retorica risuona in chiusura perché la risposta implicita è “mai”. L’umanità non impara e dunque il ciclo di errori riprende. Nel film, quell’ultimo “mai impareranno” è suggellato: non impareremo perché non ci saremo più. Ma la canzone è ciclica – come per dire: se mai l’umanità ricomparisse, rifarebbe gli stessi errori? Lanthimos, avendo uno sguardo tragicamente ironico, forse suggerisce di sì. A meno che qualcosa di radicalmente diverso nasca dalle nostre ceneri. Viene in mente la fenice: vita che rinasce dalle ceneri. Bugonia è un processo fenice al contrario: la Terra è la fenice, noi siamo le ceneri da cui risorge l’equilibrio naturale.
- Filtrare l’attuale attraverso la fantascienza – Leggiamo questo finale anche come commento allegorico alla contemporaneità: lo stato dell’umanità nel 2025. Siamo reduce (in real life) da una pandemia globale, da shock economici, l’emergenza climatica è incalzante, i populismi e complottismi abbondano. Molti provano un senso di pessimismo generazionale (“il futuro sarà peggiore”, “non c’è speranza se continuiamo così”). Bugonia, in quanto film di fantascienza-distopia, riflette questo sentire apocalittico. Ad esempio, il riferimento esplicito alla pandemia e all’approccio anti-scientifico (“c’è l’approccio anti-scienza del COVID, l’erasure delle zone rurali” ecc. citati nella recensione), insieme al fatto che Ari Aster come produttore aveva appena realizzato un film (“Eddington”) su cospirazioni pandemiche, collocano Bugonia come un’opera figlia del post-2020. Nel finale, i temi s’intrecciano: il veleno invisibile (qui alieno) che uccide senza spargere sangue richiama un po’ l’idea di una pandemia fulminante; il collasso istantaneo è la versione cinematografica di un worst-case scenario climatico (in realtà il clima non ci ucciderà in un attimo così, ma la metafora è efficace). Quindi Lanthimos sta sublimando le nostre paure reali in un evento di fantasia, come la fantascienza classica faceva con la Guerra Fredda (le invasioni aliene in Twilight Zone riflettevano la paranoia rossa, ecc.). Ci costringe a guardare quell’immagine di un mondo senza esseri umani: ed è strano a dirsi, ma è serenamente terrificante. Sereno perché i fotogrammi di città vuote, natura quieta, con quella canzone, evocano anche una pace (dopo la tempesta). Terrificante perché ovviamente includono il nostro annientamento. In quell’ambivalenza c’è una domanda filosofica antica: il mondo ha bisogno di noi? La risposta qui è chiaramente: No, anzi, sta meglio senza. È una visione anti-antropocentrica dura, che segue (curiosamente) la linea di pensiero di alcuni movimenti odierni chiamati di “ecologia oscura” o anti-umanesimo ecologico: riconoscere che Homo sapiens può benissimo scomparire e la vita continuerà, forse fiorirà. Per alcuni, questo è uno spunto di umiltà per cambiare (capire che non siamo indispensabili e quindi dovremmo comportarci meglio). Nel film però è troppo tardi: non c’è cambiamento, c’è solo la dimostrazione finale.
- Elementi psicoanalitici – Possiamo portare la lettura su un piano più astratto: se prendiamo l’intera vicenda come una sorta di sogno o fantasia, il finale rappresenta il compimento del desiderio inconscio di Teddy: il “reset totale”. Sin dall’inizio, Teddy parlava di “negoziare coi loro capi per farli lasciare la Terra in pace”; in un certo senso, alla fine, è quel che succede: i capi alieni decidono di lasciar la Terra… perché l’hanno ripulita dagli umani. Un’ironia tragica: la pace sulla Terra arriva, ma l’uomo non c’è più. Questa è un po’ la realizzazione letterale del desiderio di pace universale attraverso l’eliminazione del conflitto umano: un pensiero radicale che a volte appare come paradosso (penso al detto satirico “la pace regnerebbe se l’uomo sparisse”). Per Teddy, che da traumatizzato voleva il riscatto, il finale è estremo riscatto-distorto: l’odiata classe dei potenti è spazzata via, ma con essa anche lui e tutti. In ottica freudiana, potremmo dire che il destino pulsionale di Thanatos di Teddy trascina con sé Eros nella rovina comune. La stretta connessione di Eros e Thanatos appare nell’ultima sequenza della canzone: parla di amore (fiori, ragazze) e di morte (cimiteri) intrecciati, come se uno portasse all’altro e viceversa. C’è una sorta di sublime armonia tragica in quell’accostamento: i fiori crescono sulle tombe. La vita sboccia dalla morte letteralmente. Freud parlò in “Al di là del principio di piacere” di come la pulsione di morte abbia un ruolo primario nel riportare l’organico nell’inorganico, ma dalla morte poi la vita rinasce in nuove forme. Il finale di Bugonia sembra quasi illustrare quel ciclo: gli umani (organico complesso soggetto a Eros e Thanatos) tornano a uno stato inorganico (corpi senza vita, destinati a decomporsi in elementi), e da esso la vita semplice (insetti, piante) continua. Un ciclo entropico che poi forse ripartirà la complessità altrove (magari in quell’assemblea aliena che vediamo sul pianeta Andromeda, che sembra molto evoluta – e chissà se non andranno su un altro pianeta a riprovare?). Come in un sistema ripetitivo sperimentale: la bugonia del titolo rifà i suoi cicli di vita dalla morte all’infinito, ma l’intelligenza cosciente (gli umani) risulta un cul de sac.
- La morale (se ve n’è una) – Bugonia non è un film moraleggiante in senso tradizionale; non dice chiaramente “questi avevano ragione, questi torto”, come abbiamo visto. Però, compiendo quell’arco narrativo, offre vari spunti etici:
- L’odio e la violenza, anche se inizialmente motivati da ingiustizie, generano solo altra violenza e portano al collasso (Teddy e Michelle entrambi si confermano a vicenda la visione peggiore dell’altro, finendo per autoprovocare il disastro). È una sorta di morale da tragedia greca: la hybris (tracotanza) di vendicarsi dei “dei” (Michelle per Teddy, e di contraltare la hybris di Michelle di giocare a Dio con la Terra) porta a una nemesis (punizione) che distrugge tutti.
- L’incapacità di comunicazione e empatia è fatale: se solo Teddy e Michelle avessero davvero parlato e ascoltato l’uno la storia dell’altra, forse (forse!) avrebbero trovato un terreno comune – ad esempio, scoprire che entrambi odiavano la corruzione umana (Teddy odia i potenti corrotti, Michelle afferma di odiarli pure e di voler salvare il mondo da loro). Invece, non c’è mai dialogo genuino: c’è tortura, inganno, dibattito manipolatorio. Questo riflette la situazione attuale di discorso pubblico: eco-chamber contrapposte incapaci di ascoltarsi, che portano a soluzioni distruttive. Dunque c’è un monito: se continuiamo così, finiremo come nel film, metaforicamente se non letteralmente. Il critico Robert Daniels scrive: “il film suona l’allarme che il mondo non è bello e se continuiamo così, meritiamo forse di finire”. Questo suona come una lezione, per quanto amara: svegliamoci o periremo.
- Il concetto di ciclicità vita-morte-rinascita richiama in positivo un possibile spiraglio filosofico: anche se l’umanità è finita, la vita continua e magari rifarà un ciclo differente. È confortante in un senso cosmico (la vita è più grande di noi) ma può essere letto in chiave spirituale: in molte religioni orientali la distruzione non è la fine ma preludio di una nuova era. Bugonia con il pianeta alieno e la Terra che rifiorisce potrebbe suggerire: forse altrove o in futuro qualcosa di buono nascerà dalle ceneri dell’umanità. Non vediamo ciò esplicitamente, ma si può intuire: su Andromeda, Michelle (che è l’Imperatrice, quasi una Madre-Dea) ha la possibilità di creare un’altra specie per ripopolare la Terra, come gli alieni fecero creando gli umani dopo i dinosauri secondo il suo racconto. Quindi, paradossalmente, la fine degli umani potrebbe essere preludio di una nuova bugonia: magari dal corpo degli umani sorgeranno esseri più saggi? Non viene mostrato, però il pensiero c’è: Michelle confessa la storia della loro razza, dice che crearono l’umanità dopo aver accidentalmente ucciso i dinosauri, per salvar la Terra, ma fu un fallimento. Ora tolgono di mezzo l’umanità; la logica vorrebbe che tentino un nuovo esperimento, un’altra specie, sperando di salvare il pianeta. In una chiave reincarnativa, l’anima dell’umanità (i “fiori” dei canti) potrebbe tornare come altri esseri. Questo non è nel film, ma la mitologia a cui attinge (ciclo di Api, rifare alveari) potrebbe implicarlo.
- Lanthimos e la catarsi tragica – Da greco, Lanthimos conosce la tragedia classica: Bugonia potrebbe essere vista come tragedia completa con catarsi. Il pubblico assiste all’estremo della hubris (Teddy gioca a salvare il mondo da solo, Michelle gioca a fare Dio con la vita umana) e all’estremo castigo (morte collettiva). Ne deriva pietà e terrore, come dice Aristotele: pietà per i poveri personaggi e orrore per la loro fine. E idealmente, una catarsi, cioè una purificazione emotiva e morale del pubblico: comprendiamo i difetti umani e ci viene da riflettere sui nostri, sperando di non replicarli. Nella tragedia greca, spesso dopo la caduta c’è un barlume di ordine ristabilito (per i sopravvissuti o il cosmo). Qui l’ordine è ristabilito nella natura. Non c’è lieto fine, ma c’è una forma di sollievo tragico: la tensione si è sciolta, la canzone dolce amara ci accompagna. Lo scenario è devastante, ma stranamente pacificato. Lo spettatore potrebbe uscire scosso ma in qualche modo “liberato” dall’angoscia accumulata. Paradossalmente, Bugonia può dare un effetto quasi meditativo nel finale, costringendoci a contemplare un mondo quieto senza uomini. È come uno Zen estremo cinematografico: rimuovi il soggetto sofferente (uomo) e rimane solo l’essere (api e natura). Questo richiama una dimensione filosofica orientale: l’idea del Nirvana come spegnimento del dolore dell’individualità. Non è detto che Lanthimos lo volesse, ma l’effetto combacia: l’ego iperbolico umano (Teddy, simbolo di tutti) si dissolve, e rimane l’unità (il suono della canzone e il panorama, un tutto).
Tutto ciò considerato, come concettualizziamo in definitiva Bugonia? Io lo vedo come:
- Un racconto morale sulla distruttività umana in forma di black comedy-sci-fi.
- Un mito moderno di sacrificio: invece di un toro per far rinascere api, sacrifica la specie per far rinascere il pianeta.
- Una seduta psicoanalitica universale in cui l’autore (Lanthimos) assume il ruolo di superego severo e dice “colpevoli tutti!” – come un processo finale.
- Al contempo, è un atto di amore quasi poetico verso la vita non umana: quell’attenzione alle api e ai fiori con Dietrich, come se il film dicesse “guardate come era bello il mondo prima di noi e come lo sarà dopo di noi”.
In chiave strettamente psicoanalitica, potremmo persino interpretare gli alieni come parti scisse della psiche umana (il super-io iperrazionale e punitivo impersonale) che alla fine ha la meglio sull’io e l’es (gli umani emotivi). Così l’umanità muore per una sorta di suicidio superegoico. E le api simboleggiano la parte inconscia naturale (l’id incontaminato) che rifiorisce quando la struttura nevrotica (la civiltà) crolla. Un po’ come se, in un individuo, l’ego e superego troppo severi portassero al suicidio e solo il suo corpo (natura) restasse. Questa è una lettura molto allegorica, ma interessante: l’uomo autodistrugge la propria mente, e rimane la vita corporea a livello base (api).
Filosoficamente, Bugonia s’inserisce in riflessioni post-umane: il valore di anthropos è relativo; se non cambiamo, potremmo dover cedere il testimone ad altro. Viene in mente Nietzsche e l’oltre-uomo: nel film non vediamo un oltre-uomo sorgere, ma gli alieni fungono da entità oltre l’umano. In pratica, il film afferma: non siamo il fine ultimo dell’universo, siamo stati forse creati da altri e possiamo essere tolti di mezzo. Un pensiero che umilia l’orgoglio umano tipico di lanthimos (in The Killing of a Sacred Deer c’era un tema di punizione e sacrificio simile, in The Lobster la misantropia e assurdità sociale, in Dogtooth la decostruzione della famiglia e linguaggio). Bugonia è quasi la summa di quell’atteggiamento: spietato, ironico, concettuale. Lo definiscono “misanthropy enlightened” perché non è gratuito odio verso l’uomo, ma finalizzato a uno sguardo più ampio, a stimolare riflessione.
Concludiamo dunque con l’immagine iniziale e finale unificate: Bugonia inizia con due alveari e finisce con alveari che rifioriscono. In mezzo c’era di tutto: come se la storia umana fosse un interludio tra la vita delle api, una nota stonata. Un commento duro ma affascinante sulla nostra collocazione nel cosmo: forse l’umanità è solo un episodio tra due ronzare di api. È una visione che può farci sentire minuscoli, ma c’è anche una bellezza nella concezione ciclica: la vita continua. In termini emotivi, il film vuole sicuramente lasciare il pubblico scosso e meditativo. Personalmente, come psicologo, la trovo una potente metafora catartica: rappresentare l’inimmaginabile (la fine di tutti) per farci elaborare ansie e colpe collettive. Non a caso, la critica ha notato che Lanthimos ha creato un film arrabbiato ma deliberato proprio in questo momento storico perché sente quell’urgenza. Egli canalizza la rabbia e la trasformata in racconto, e alla fine la sublima in quella melodia e quell’immagine, come a dire: respira, spettatore, e pensa: vogliamo arrivare qui?.
La cyclicità vita-morte-rinascita in Bugonia funge da monito e da contemplazione. Ci invita, forse, a riconciliarci con la natura (le api) prima che sia troppo tardi. La bugonia antica era un rituale per rigenerare alveari perduti – quant’è tragico e ironico che nel film l’alveare (Terra) venga rigenerato solo eliminando noi! Forse ci spinge a trovare un’alternativa: a rigenerare senza sacrifici così estremi, a cambiare rotta. In ciò vedo una vena sottilmente umanista dietro il misantropo: se Lanthimos fosse del tutto privo di speranza, non ci avrebbe nemmeno mostrato quell’ultimo segno di bellezza. Ma lo fa, ed esso commuove. Forse perché in fondo vuole che proviamo amore almeno per le api e i fiori, se non più per noi stessi – e da lì, chissà, rifiorisca anche l’amore per il genere umano, prima che cali il sipario.
Conclusioni
Bugonia è un’opera sorprendentemente ricca di livelli di lettura, che conferma Yorgos Lanthimos come uno dei registi più originali e audaci del cinema contemporaneo. Quello che poteva sembrare solo un bizzarro mélange di generi – commedia nera, fantascienza, thriller – si rivela invece una riflessione intelligente sulla condizione umana nel nostro tempo. Attraverso le citazioni cinematografiche (da Hitchcock alla fantascienza vintage), Lanthimos situa il suo film in una tradizione, dialogando con il passato per parlare del presente. Attraverso il mito della bugonia e il tema delle api, ci pone di fronte a dilemmi ecologici e morali attualissimi: quanto l’umanità ha tradito la natura? Esiste una possibilità di rigenerazione o solo tramite distruzione e sacrificio? . Con la trama del remake e i giochi di autocitazione, Bugonia esplora il medium cinema stesso, la nostra familiarità con certe storie e la capacità di sorprendere ancora lo spettatore smaliziato. E infine, scavando nella psicologia dei personaggi, il film ci parla di noi: delle paure che ci guidano, delle idee che abbracciamo per dare un senso al caos, e dei traumi che ci portiamo dietro come specie e come individui.
In Bugonia troviamo dunque un equilibrio peculiare: da un lato una satira sociale – feroce verso i potenti ipocriti così come verso i complottisti accecati– e dall’altro una componente quasi tragica sotto il velo dell’assurdo. La satira colpisce il bersaglio dell’oggi: vediamo riflessa la società della post-verità, in cui fatti e finzioni si mescolano e la fiducia nelle istituzioni è erosa. Il personaggio di Teddy rappresenta tanti individui reali persi nel labirinto delle teorie cospiratorie online, mentre Michelle incarna l’élite tecnocratica e “green” solo a parole, fenomeno ben noto nel nostro mondo di facciate sostenibili e scandali aziendali. Ma poi la tragicità emerge quando il film chiede: e se avessero entrambi torto e ragione allo stesso tempo? Teddy aveva visto giusto sugli alieni, ma ciò non lo salva né lo giustifica; Michelle credeva di essere superiore e intoccabile, ma si riscopre fragile (prima come prigioniera umana, poi come leader aliena costretta a sterminare un intero mondo per coerenza con la propria missione). Questa complessità impedisce di ridurre Bugonia a una favola morale semplice. Anzi, il film rifiuta la consolazione: non ci offre eroi positivi né redenzioni. Il finale apocalittico – con la Terra liberata dagli esseri umani e le api che ronzano di nuovo libere – è un pugno allo stomaco che lascia lo spettatore interdetto. È un finale che “colpisce particolarmente duro in questo momento della storia umana”, ha detto Will Tracy, riferendosi al sentimento di impotenza e disperazione che aleggia per la crisi climatica e sociale. In un’epoca in cui i blockbuster scelgono quasi sempre la via della speranza a ogni costo, Lanthimos confeziona una satira nerissima che riprende l’audacia dei film di fine anni ’60 – quando non si aveva paura di immaginare davvero il peggio – adattandola però al mood attuale di cinismo e paura strisciante.
Sul piano tecnico e artistico, Bugonia è stato lodato per la sua messa in scena rigorosa e le interpretazioni. La fotografia di Robbie Ryan alterna la bellezza quasi pittorica (i campi di fiori colorati e le api dell’inizio) alla crudezza claustrofobica degli interni, fino allo splendore spettrale della sequenza finale nello spazio. Il montaggio, più lineare e sobrio del solito stile frammentato di Lanthimos, dimostra che il regista sa anche padroneggiare uno storytelling classico quando serve. Questo è stato definito infatti “il film più ordinato di Lanthimos”, quasi un lavoro su commissione dove lui però non rinuncia al suo tocco. Emma Stone e Jesse Plemons, nei loro duetti recitativi, tengono in piedi l’intero film con dialoghi affilati e sguardi carichi di significato, regalando momenti di autentica tensione e pathos. E il giovane Aidan Delbis nei panni di Don offre una presenza ingenua e tragica, sapendo di cosa parla: l’attore è realmente nello spettro autistico, così come il personaggio, portando sullo schermo una sensibilità particolare che rende ancora più autentico il dramma della sua crisi.
In conclusione, Bugonia è un film che si può leggere come intrattenimento intelligente – un oscuro divertissement che mescola api, alieni e cospirazioni – ma anche come una stratificata opera d’arte che ci pone domande scomode. Dal mito di Aristeo alla fine del mondo, dal Nodo alla gola all’eclissi, Lanthimos intreccia fili lontani tra loro e ci invita a riflettere sulle conseguenze delle nostre azioni collettive e individuali. È un film che attacca “l’ambiguità del potere del presente” e l’autoinganno in cui viviamo, senza proporre soluzioni ma con la ferma volontà di mostrarci, attraverso la lente dell’assurdo, chi potremmo diventare se continuiamo su questa strada. In una parola, Bugonia è satira, tragedia e spettacolo tutto in uno – un alveare impazzito dove il ronzio delle api racconta la fine (e forse un nuovo inizio) dell’umanità. E noi, usciti dalla sala, non possiamo fare a meno di chiederci se davvero dalle nostre rovine sorgeranno nuove api… o se sarebbe stato meglio imparare a vivere in armonia prima che calasse l’eclissi.
Bugonia è un’opera ricchissima che fonde mito classico, citazioni cinematografiche, analisi psicologica e critica sociale in un affresco oscuro e al tempo stesso poetico. Scritto in prima persona, ne ho esplorato motivazioni e significati con lo sguardo di psicologo, biotecnologo e cinefilo, e giunto alla fine mi rendo conto di quanto questo film – nella sua surreale esagerazione – parli di noi, delle nostre paure e colpe collettive. Come autore di questo lungo saggio, sento di aver compiuto un rito personale: ho discesocon Teddy negli abissi del trauma, ho scambiato accuse e rivelazioni nella “seduta” con Michelle, ho pianto con Don per l’innocenza persa, e infine sono risalito a riveder le stelle (anzi, le api sotto le stelle) in un mondo nuovo e vuoto. Provo un misto di sollievo e di malinconia, un senso di catarsi tanto amara quanto necessaria.
“Dove sono finiti tutti i fiori?”, canta la voce lontana. Forse la risposta non spetta a noi, almeno non ora. Forse l’ultima lezione di Bugonia è che dovremmo imparare l’umiltà di quella domanda, smetterla di credere di avere tutte le risposte (come Teddy) o tutto il potere (come Michelle), e riconoscerci parte fragile di un ciclo più grande. Se c’è una speranza, sta nel farlo prima che gli “dei” alieni o la natura decida di spazzarci via. In caso contrario, resteranno i fiori, le api e il ricordo di una specie che non volle ascoltare i propri poeti e profeti quando ancora poteva scegliere un destino diverso.
Chiudo dunque questo saggio come fosse anch’esso un alveare di idee: abbiamo raccolto il miele di Virgilio e Ovidio, il polline dei film di Hitchcock, Kubrick, Coen e altri, l’elisir dolceamaro della psicologia del trauma, e li abbiamo depositati nelle celle ordinate di questa analisi. Spero che da questo miele intellettuale possiate trarre nutrimento mentale e stimolo emotivo. Bugonia è un film che punge come un’ape e insieme produce visioni di straziante bellezza – un prodotto raro, proprio come il mito da cui prende il nome.
Infine, da psicologo e cinefilo, la mia motivazione iniziale nel recensire quest’opera trova compimento: Bugonia mi ha costretto a guardare in faccia i lati più oscuri e luminosi dell’uomo. Mi ha lasciato con molte domande e poche risposte, ma forse è giusto così. Come nel mito di Aristeo, a volte occorre attraversare l’oscurità degli inferi (la cantina di Teddy) per cogliere una verità, per quanto dura. Aristeo tornò con un rituale di rigenerazione; noi torniamo da Bugonia con l’immagine indelebile di quei fiori solitari. Sta a noi decidere cosa farne: se ignorarla, come fece l’umanità del film condannandosi, o se usarla come simbolo per cambiare rotta, per proteggere davvero i fiori e le api del nostro mondo, e con essi il meglio di noi stessi, prima che sia troppo tardi.
Lascia un commento