Negli ultimi anni la vulnerabilità emotiva – un tempo vissuta nell’intimità o addirittura nascosta per paura dello stigma – è divenuta paradossalmente una merce culturale. Nella società iperconnessa odierna, soprattutto sui social media e nei prodotti dell’industria culturale, mostrare le proprie fragilità è spesso incoraggiato e valorizzato. L’autenticità è diventata un ideale da raggiungere e “mettere in vetrina”: condividere ansie, sofferenze e traumi personali pubblicamente può attirare attenzione, consenso e perfino vantaggi economici o sociali. In altre parole, la vulnerabilità emotiva è assurta a moneta di scambio nell’odierno mercato dell’attenzione digitale. Questo fenomeno si manifesta in molteplici forme – post confidenziali su Instagram, video confessionali su TikTok, canzoni e prodotti culturali incentrati sul disagio interiore – e porta con sé implicazioni complesse sia sul piano psicologico che psichiatrico.
Da un lato, la maggiore visibilità del disagio mentale ha contribuito a ridurre pregiudizi e vergogna: oggi è più accettabile parlare apertamente di depressione, ansia o trauma, e molte persone trovano conforto nel sapere di non essere sole nelle proprie difficoltà. Dall’altro lato, però, questa esposizione massiva della sofferenza rischia di sfociare in una romanticizzazione o mercificazione del dolore emotivo. Il pericolo è che il malessere psichico venga estetizzato e sfruttato – dai media, dalle aziende o dagli individui stessi – perdendo autenticità e serietà. Si assiste così al proliferare di contenuti che rappresentano la tristezza e l’angoscia in modo patinato e accattivante, talora trasformando la malattia mentale in un elemento di fascino o in un marchio identitario. La sofferenza diventa tendenza, qualcosa da esibire per ottenere approvazione o like, e talvolta un vero e proprio brand.
Questo saggio clinico-narrativo esplorerà in profondità “l’estetica della vulnerabilità” intesa come mercato: analizzeremo come e perché la vulnerabilità emotiva viene commercializzata e spettacolarizzata nella cultura contemporanea e nei media, discutendone le conseguenze psicologiche. Verranno esaminati i principali disturbi psichiatrici coinvolti – depressione, disturbo borderline di personalità, disturbo narcisistico di personalità, disturbo d’ansia sociale e il trauma complesso – con riferimenti ai criteri diagnostici del DSM-5 e dell’ICD-11, per contestualizzare scientificamente il fenomeno. Considereremo gli effetti di queste dinamiche sulle popolazioni più vulnerabili, in particolare adolescenti e giovani adulti, cresciuti nell’ecosistema dei social media. Infine, discuteremo le implicazioni per la pratica clinica, dalla diagnosi alla terapia, fornendo spunti su come i professionisti della salute mentale possano navigare in un’epoca in cui i pazienti arrivano spesso in studio con un bagaglio di autodiagnosi da internet e un’identità forgiata anche attraverso le narrazioni mediatiche del disagio. Il tono sarà professionale ma accessibile, con uno sguardo critico e al contempo empatico: l’obiettivo è comprendere questo fenomeno complesso senza demonizzarlo, individuando rischi e opportunità per il benessere psicologico individuale e collettivo.
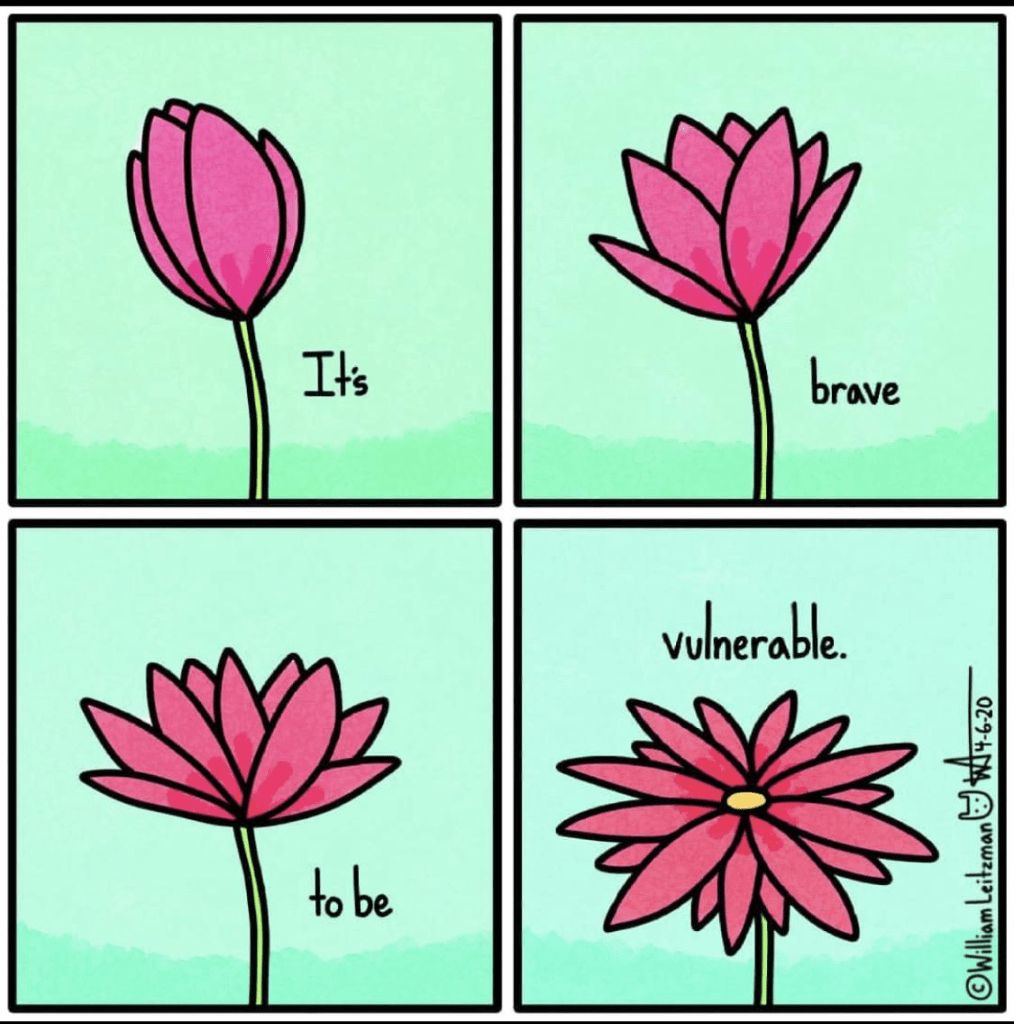
Vulnerabilità ed “autenticità” nella cultura contemporanea
Viviamo in una cultura che celebra l’autenticità e la condivisione dei sentimenti. Sulla scia di movimenti di sensibilizzazione sulla salute mentale, mostrarsi vulnerabili è divenuto sinonimo di coraggio e onestà. In ambito digitale, i contenuti “raw” e genuini – confessioni intime, lacrime davanti alla telecamera, racconti di fallimenti e ferite emotive – attraggono milioni di visualizzazioni. Si è sviluppata così una vera e propria estetica della vulnerabilità: un insieme di immagini, linguaggi ed esperienze che mettono in scena la fragilità umana in modo tale da risultare emotivamente coinvolgente e spesso esteticamente curato.
Nei feed di Instagram e TikTok, ad esempio, compaiono foto e video dai toni cupi o nostalgici: stanze in penombra, occhi lucidi col trucco sbavato, frasi sussurrate o scritte in sovrimpressione del tipo “mi sento rotto, ma bellissimo nella mia tristezza”. Questo tipo di contenuto riceve frequentemente commenti di incoraggiamento e condivisioni virali. La vulnerabilità diventa un valore: esporsi con le proprie debolezze può far guadagnare popolarità e simpatie, in contrapposizione all’epoca (non troppo lontana) in cui si mostrava solo il lato perfetto e patinato della vita. Oggi il pubblico, specialmente giovanile, sembra affamato di “verità” emotive dietro le quinte delle vite altrui.
Questa tendenza, per certi versi positiva perché favorisce un clima di empatia e umanizzazione (ci si rende conto che anche dietro le vite apparentemente perfette c’è sofferenza), ha però un risvolto ambiguo: l’autenticità può facilmente trasformarsi in performatività. Molti utenti imparano che condividere il proprio dolore genera attenzione; alcune figure pubbliche e influencer sviluppano un vero personaggio basato sul proprio trauma o sulla propria fragilità esibita. La linea tra uno sfogo autentico e una messa in scena studiata della vulnerabilità diventa sottile. In casi estremi, le emozioni difficili vengono strumentalizzate per mantenere l’engagement: più il racconto è drammatico e toccante, più attira follower. Si crea così un circolo per cui la vulnerabilità, da esperienza umana sincera, viene plasmata in un prodotto mediatico da consumare.
Un termine emblematico emerso in questo contesto è “sadfishing”: crasi tra “sad” (triste) e “fishing” (pescare), indica il “pescare” attenzione online attraverso la tristezza. Gli utenti che praticano sadfishing postano contenuti volutamente vaghi ma emotivamente carichi – ad esempio un selfie in lacrime con una didascalia allusiva a un dolore indefinito – allo scopo di sollecitare commenti di supporto e vicinanza. Questo comportamento, identificato inizialmente tra gli adolescenti, è diventato così diffuso da attirare l’attenzione di psicologi e media. Dietro la condanna facile (“lo fa solo per attirare attenzione”) può in realtà celarsi un grido d’aiuto genuino; tuttavia, la natura pubblica e ripetitiva di questi post spesso innesca reazioni contrastanti: alcuni offrono sostegno, altri accusano di drammatizzare. Il sadfishing evidenzia il paradosso della vulnerabilità online: il bisogno autentico di aiuto si mescola con la ricerca di convalida sociale. Studi recenti suggeriscono che chi indulge in sadfishing tende ad avere determinati tratti, come un’attaccamento ansioso nelle relazioni, ovvero il timore dell’abbandono e il desiderio costante di rassicurazione. Queste persone possono usare il social quasi come “amo” affettivo, cercando nel conforto degli sconosciuti un surrogato del supporto che sentono mancare.
Purtroppo, molti adolescenti che hanno provato a condividere online la propria tristezza riportano esperienze negative: commenti cinici, accuse di esagerazione, oppure silenzio e indifferenza che finiscono per acuire il senso di solitudine. In alcuni casi sono stati anche vittime di bullismo per via del loro sfogo, aggravando il disagio originale. D’altro canto, episodi eclatanti di sadfishing (come quello della modella Kendall Jenner, criticata per aver rivelato problemi di acne solo per lanciare una pubblicità di cosmetici) hanno alimentato il cinismo generale, inducendo molti a dubitare della sincerità di chiunque condivida sofferenze sul web. Il risultato è un clima ambiguo: le richieste di aiuto reali rischiano di passare inosservate o di venire banalizzate, perché sommerse da contenuti analoghi creati magari con intento manipolatorio o commerciale.
Parallelamente al sadfishing, il panorama digitale vede un altro fenomeno: l’oversharing emotivo. Alcuni individui – spesso giovani con difficoltà a regolare le emozioni o con tratti di personalità impulsivi – tendono a condividere senza filtro dettagli molto intimi del proprio vissuto emotivo. La rabbia per un litigio familiare, il panico di una notte insonne, i pensieri autolesivi: tutto può essere riversato in tempo reale su Twitter o Instagram Stories. Se un tempo il diario segreto custodiva questi sfoghi, oggi diventano post pubblici. Ricerche su adolescenti e giovani adulti con sintomi di disturbo borderline di personalità (BPD) hanno evidenziato che essi sono particolarmente a rischio di oversharing online. Il disturbo borderline, secondo il DSM-5, è caratterizzato da instabilità nelle relazioni interpersonali, nell’immagine di sé e nell’umore, con impulsività marcata e frequenti comportamenti autolesivi. Un tratto tipico è la difficoltà a gestire emozioni intense e un disperato bisogno di conferme dagli altri. Con l’avvento dei social, i ragazzi borderline trovano un palcoscenico immediato per esprimere il turbinio emotivo che li travolge – salvo poi magari pentirsi di aver messo in piazza sentimenti e pensieri così personali. Uno studio olandese del 2022 ha confermato che i giovani con sintomi borderline tendono a divulgare online più informazioni intime rispetto ai coetanei, e sperimentano più spesso rimorso dopo aver condiviso post personali impulsivi.
Questa sovraesposizione può generare ulteriori complicazioni: conflitti interpersonali (quando amici o partner si sentono esposti), cyberbullismo da parte di chi stigmatizza quelle emozioni “esagerate”, e rischi per la privacy e la sicurezza personale. Ancora una volta, vediamo come la struttura dei social – che premia la condivisione costante e la spettacolarizzazione di sé – incontra tratti psicologici vulnerabili amplificando i comportamenti disfunzionali invece di mitigarli.
In sintesi, la cultura contemporanea spinge ad essere vulnerabili in pubblico in nome dell’autenticità, ma questa esposizione non è priva di insidie. La vulnerabilità può trasformarsi in performance, l’attenzione può sostituire l’autentico sostegno, e le piattaforme digitali tendono a monetizzare ogni emozione condivisa. Nel prossimo capitolo approfondiremo come il mercato – dalle aziende ai media mainstream – ha intercettato questa tendenza, sfruttandola a fini commerciali.
La mercificazione della vulnerabilità nei media e nel marketing
Come ogni elemento che attira l’interesse delle masse, anche la vulnerabilità emotiva è divenuta terreno fertile per la mercificazione. Il mercato ha fiutato l’appeal della sofferenza sincera e l’ha incorporato in strategie pubblicitarie, prodotti e contenuti mediatici. Si è sviluppata quella che alcuni commentatori hanno chiamato la “economia della vulnerabilità”, in cui il dolore psichico e le insicurezze vengono usati come strumenti per vendere.
Un esempio lampante è l’industria del wellness e della salute mentale. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un boom di prodotti e servizi che promettono benessere emotivo: dalle app di meditazione guidata, ai kit di auto-cura (le cosiddette self-care box), ai libri di memorie traumatiche diventati best-seller. Questo trend ha certamente aspetti positivi – ha contribuito a normalizzare l’idea di prendersi cura della propria psiche – ma ha anche un lato manipolativo. Molte campagne marketing sfruttano il linguaggio della salute mentale in modo semplicistico per indurre all’acquisto: slogan come “Liberati dall’ansia con la nostra tisana calmante” oppure “Prenditi cura di te con questo abbonamento di self-care mensile” presentano soluzioni facili e consumistiche a problemi complessi. Alcune app di meditazione e rilassamento, pur avendo valore, vengono pubblicizzate come panacee immediate: basta scaricare l’app e i tuoi anni di stress e depressione svaniranno. Questa promessa illusoria non solo è ingannevole, ma rischia di banalizzare la realtà clinica di disturbi come il disturbo d’ansia generalizzato o la depressione maggiore, che richiedono spesso interventi terapeutici o farmacologici prolungati. La semplificazione commerciale del malessere – “se sei triste, compra questo prodotto e starai meglio” – riduce la sofferenza a un bisogno da soddisfare con un acquisto, scoraggiando implicitamente la ricerca di un aiuto professionale più impegnativo ma realistico.
Anche il settore della bellezza e moda ha cavalcato la vulnerabilità come tema. Diverse campagne pubblicitarie mostrano modelle e influencer che confessano insicurezze (acne, cellulite, ansie sociali) per poi proporre il prodotto miracoloso che ha dato loro “sicurezza in sé stesse”. Queste narrazioni, costruite ad arte, sfruttano l’empatia e l’identificazione: il consumatore si riconosce nella fragilità esibita dal testimonial e viene spinto a credere che acquistare quel prodotto sia la chiave per superarla. Un caso divenuto celebre è quello citato in precedenza di Kendall Jenner, che annunciò sui social di voler rivelare la sua “grande insicurezza” e, dopo aver attratto enorme attenzione mediatica, svelò trattarsi di una partnership commerciale per un trattamento contro l’acne. L’episodio suscitò critiche diffuse: molti si sentirono traditi nell’aver empatizzato con la sua vulnerabilità, scoprendo poi che era strumentalizzata per una sponsorizzazione. Questo evidenzia il rischio etico quando la vulnerabilità è piegata al marketing: il confine tra condivisione autentica e manipolazione si infrange, e il pubblico sviluppa cinismo verso qualunque espressione di sofferenza, sospettando che dietro possa esserci un secondo fine commerciale.
Un ruolo di primo piano nella mercificazione della vulnerabilità lo giocano gli influencer e le celebrità. Molti creator sui social media basano il proprio personal brand su un’immagine di autenticità “difettosa”: parlano apertamente delle proprie giornate storte, degli attacchi di panico vissuti, dei traumi passati, costruendo una relazione di fiducia con il pubblico. In sé, questo può avere un impatto positivo – funge da esempio di accettazione di sé e incoraggia i follower ad aprirsi a loro volta. Tuttavia, quando la notorietà e gli introiti economici dell’influencer dipendono anche da queste narrazioni, può instaurarsi un meccanismo perverso. Da un lato, l’influencer sente la pressione di condividere continuamente parti vulnerabili di sé per mantenere l’engagement (“il pubblico mi vuole vera e fragile”); dall’altro, le aziende sfruttano la credibilità emotiva di questi individui per vendere prodotti. Così, capita di vedere influencer che in un video raccontano la propria depressione e in quello successivo promuovono integratori “che li hanno aiutati a uscirne”, oppure mostrano il diario su cui scrivono quando stanno male – casualmente venduto in affiliazione su un e-commerce. La linea narrativa personale si intreccia col messaggio pubblicitario. Ciò confonde i follower: il racconto intimo era finalizzato al marketing o sincero? Spesso è entrambe le cose insieme, in una commistione ambigua. I follower più giovani, che tendono a idealizzare le web star, possono finire col credere davvero che quel prodotto sponsorizzato sia la chiave della salute mentale, o che per ottenere approvazione anche loro debbano mettere a nudo costantemente il proprio cuore online.
Anche la cultura pop più in generale riflette questa estetica della vulnerabilità mercificata. Nel mondo della musica, per esempio, ha trovato spazio la figura della “sad girl” – cantautrici che nelle loro canzoni e nel look incarnano una tristezza affascinante e poetica. Cantanti come Billie Eilish, Lana Del Rey o Phoebe Bridgers hanno costruito un’immagine artistica intrecciata a temi di depressione, alienazione, trauma. Va sottolineato: in molti casi la loro espressione è autentica e dà voce a vere esperienze di disagio, offrendo peraltro conforto ai fan con problemi simili. Tuttavia, l’industria discografica e i media amplificano e packaggiano questa tristezza in un prodotto vendibile. Le copertine degli album, i video musicali, il merchandising (magliette con frasi malinconiche, ecc.) contribuiscono a vendere un’esperienza emotiva oltre che musicale. Il rischio è che la sofferenza diventi un espediente narrativo prevedibile per attrarre pubblico: quasi ogni artista emergente oggi è spinto a raccontare qualche ferita emotiva per risultare più interessante e “profondo”. In ambito letterario e cinematografico, critici come Parul Sehgal hanno parlato di un “trauma plot” onnipresente – molte storie contemporanee inseriscono un trauma psichico come fulcro del personaggio, talvolta in modo artificioso, perché il trauma vende, tiene incollato lo spettatore. Si pensi a serie TV come 13 Reasons Why, basata sul suicidio di un’adolescente: pur avendo aperto un dibattito sul bullismo e la depressione giovanile, la serie è stata accusata di aver spettacolarizzato il suicidio presentandolo come uno scenario quasi romantico di vendetta postuma. È significativo che dopo l’uscita di 13 Reasons Why nel 2017, uno studio statunitense abbia registrato un aumento del 28,9% nel tasso di suicidi fra i ragazzi 10-17 anni nel mese immediatamente successivo.
Ciò suggerisce un effetto contagio e la pericolosità di certe rappresentazioni non responsabili: il dolore psichico, messo in scena senza adeguati contrappesi, può esercitare una sorta di macabro fascino sui giovani spettatori vulnerabili, inducendoli all’imitazione.
In questo contesto, per i media e le piattaforme digitali l’autenticità emotiva è diventata un argomento di vendita tanto quanto l’aspirazione al lusso o alla bellezza. Siamo bombardati da storytelling che attingono alle vulnerabilità per creare engagement: dalle pubblicità progresso strappalacrime sponsorizzate da grandi marchi, ai talk show dove personaggi pubblici rivelano traumi infantili di fronte a milioni di telespettatori, fino ai reality show in cui i concorrenti vengono incoraggiati (se non provocati) a crolli emotivi davanti alle telecamere per alzare gli indici di ascolto. La vulnerabilità è così penetrata nel circuito del consumismo e dell’intrattenimento: il pubblico la consuma, ne viene persino assuefatto, e occorrono dosi emotive sempre più forti per suscitare reazioni. Questo provoca una certa dissociazione empatica: quando ogni giorno scorriamo decine di storie di trauma e sofferenza sul telefono, possiamo finire per sentirci anestetizzati, oppure al contrario sopraffatti da più dolore di quanto possiamo gestire, tanto da diventare insensibili come difesa.
Riassumendo, la mercificazione della vulnerabilità rappresenta un delicato gioco di equilibrio: se da una parte normalizza il discorso sul disagio psichico e crea connessioni, dall’altra rischia di strumentalizzare e banalizzare esperienze umane profonde. Il dolore non dovrebbe essere ridotto a mera estetica o a leva di mercato. Nel prossimo capitolo passeremo in rassegna le principali patologie coinvolte in questo fenomeno, per capire come disturbi specifici vengono rappresentati e talora mistificati nella cultura odierna della vulnerabilità esibita.
Vulnerabilità e psicopatologia: disturbi chiave nella narrazione del disagio
L’“estetica della vulnerabilità” mercificata coinvolge soprattutto alcuni quadri psicopatologici, spesso citati e discussi sia nei media che dalle persone comuni online. Depressione, disturbi di personalità come il borderline e il narcisistico, disturbi d’ansia (in primis l’ansia sociale) e i traumi psicologici complessi sono diventati termini di uso corrente nel linguaggio popolare, talvolta lontani dal loro reale significato clinico. In questa sezione analizzeremo ciascuno di questi disturbi, delineando brevemente la cornice diagnostica del DSM-5 e dell’ICD-11 e discutendo come vengono rappresentati o fraintesi nella cultura contemporanea.
Depressione e l’estetica della tristezza
La depressione – in particolare il disturbo depressivo maggiore – è forse la patologia mentale più visibilmente romanticizzata nell’immaginario collettivo recente. Secondo il DSM-5, la depressione maggiore è caratterizzata da umore depresso persistente e perdita di interesse/piacere per quasi tutte le attività per almeno due settimane, accompagnata da sintomi cognitivi e fisici come affaticamento, sentimenti di colpa o inutilità, pensieri di morte, alterazioni del sonno e dell’appetito. L’ICD-11 la classifica in base a gravità (lieve, moderata, grave) a seconda del numero e dell’intensità dei sintomi presenti. In termini clinici, dunque, la depressione è una condizione invalidante che compromette il funzionamento quotidiano e provoca sofferenze profonde.
Nel mondo dei social e della cultura pop, però, la depressione è spesso rappresentata in modo edulcorato e poetico. Si parla di “tristezza” quasi fosse una moda: immagini di pioggia sui vetri, diari pieni di pensieri malinconici, frasi di canzoni struggenti condivise con hashtag tipo #depressed #sadquotes. Come accennato, è nato addirittura un filone artistico definito “sad aesthetic” o estetica del “mal di vivere”: colori freddi, posture dimesse, mascara colato dalle lacrime – iconografie che rendono la sofferenza visivamente suggestiva. Nei film e serie TV, il personaggio depresso viene talvolta ritratto come il “genio tormentato” (lo scrittore depresso ma brillante, il musicista autodistruttivo ma talentuoso), consolidando l’idea di un legame quasi romantico tra depressione e profondità d’animo o creatività. Questa narrazione, per quanto possa sembrare un tributo empatico, rischia di trivializzare la gravità clinica della depressione: nella realtà, infatti, la depressione non è affatto affascinante – comporta apatia, isolamento, pensieri suicidari, e spesso una dolorosa incapacità di provare emozioni (anedonia). Non è “poesia”, è paralisi dell’anima.
Sui social network molti giovani dichiarano di “essere depressi” quando magari attraversano normali periodi di tristezza o delusione. L’uso disinvolto del termine può portare a misconoscere il disturbo vero e proprio. Al contrario, chi soffre di depressione clinica può sentirsi incompreso o sminuito in un contesto in cui “tutti” dicono di esserlo. Come evidenziato in un articolo divulgativo recente, la sovraesposizione di contenuti sulla tristezza può far apparire la sofferenza quasi attraente, un tratto identitario a cui ispirarsi, soprattutto in adolescenza.
Si diffonde l’idea che stare male sia la norma, quasi un passaggio obbligato della giovinezza sensibile; questo può portare alcuni ragazzi a non distinguere più tra un umore depresso passeggero (magari reattivo a eventi di vita) e una depressione clinica che richiede cura. Inoltre, la glamourizzazione della depressione rischia di inibire la richiesta d’aiuto: se “siamo tutti depressi” e fa parte di ciò che ci rende interessanti, allora perché cercare di stare meglio? Alcuni adolescenti riferiscono di aver quasi provato “vergogna” nel guarire, come se perdere la propria aura di tristezza li privasse di personalità.
Dal punto di vista clinico, è importante ribadire che la depressione non è un semplice stato emotivo, né un tratto caratteriale, ma un disturbo che ha criteri specifici e trattamenti efficaci (psicoterapia, farmacoterapia o combinazioni di entrambe). Purtroppo, la narrativa mediatica a volte presenta scorciatoie illusorie: meme in cui basta “ascoltare la tua playlist preferita sotto le coperte” per curare la depressione, oppure all’opposto film in cui l’amore romantico del protagonista “salva” magicamente dalla depressione. Questi messaggi semplificati possono creare false aspettative nei pazienti (delusione quando scoprono che la terapia richiede tempo e impegno, ad esempio) o far sottovalutare segnali di allarme. Suicidalità e depressione: un aspetto raramente incluso nell’estetica romantica è il pensiero suicida, e ancor meno il suicidio nella sua crudezza. Eppure circa il 10-15% dei pazienti con depressione maggiore muore per suicidio. Quando la depressione viene ritratta come “bella tristezza”, si tende a escludere questi aspetti scomodi e spaventosi, offrendo un quadro incompleto. Un adolescente che si identifica nei personaggi depressi idealizzati potrebbe non capire la necessità di interventi seri finché la propria situazione non degenera.
In sintesi, la depressione reale va distinta dalla sua versione estetizzata: riconoscere questa differenza è fondamentale sia per chi soffre, sia per chi li circonda e per i professionisti. Il ruolo della cultura pop e dei social dovrebbe essere quello di promuovere comprensione ed empatia verso la depressione, ma evitando di mitizzarla come segno di profondità o di scoraggiare la guarigione presentandola come condizione quasi desiderabile.
Disturbo Borderline di Personalità: fragilità estreme e identità social
Il disturbo borderline di personalità (DBP) è al centro di molte narrazioni mediatiche sul tema della vulnerabilità. Nel DSM-5 il DBP è descritto da un pattern pervasivo d’instabilità nelle relazioni interpersonali, nell’immagine di sé e nell’umore, con marcata impulsività. Alcuni criteri diagnostici chiave includono: sforzi frenetici per evitare abbandoni reali o immaginari, relazioni interpersonali intense e instabili (oscillanti tra idealizzazione e svalutazione), disturbo dell’identità (sensazione di sé molto labile o incerta), comportamenti impulsivi e autolesivi ricorrenti (minacce o tentativi suicidari, tagli), instabilità affettiva con oscillazioni di umore rapide, sentimenti cronici di vuoto, rabbia intensa e inappropriata, e talora ideazione paranoide o sintomi dissociativi transitori legati allo stress. L’ICD-11, pur avendo modificato l’approccio ai disturbi di personalità in senso dimensionale, prevede uno specificatore di “pattern borderline” per i disturbi di personalità, con caratteristiche molto simili (instabilità di sé e relazioni, impulsi autodistruttivi, intense oscillazioni emotive, ecc.).
Insomma, il borderline è caratterizzato da un’estrema sensibilità all’abbandono e da emozioni fuori controllo, che rendono il paziente vulnerabile in modo drammatico: queste persone soffrono profondamente e spesso faticano a trovare stabilità nella vita.
Nel discorso pubblico, il termine “borderline” è diventato fin troppo comune, spesso usato a sproposito per indicare genericamente qualcuno di “instabile” o “esagerato” emotivamente. Film e serie TV hanno ritratto personaggi borderline tipicamente come donne giovani, autodistruttive e volubili (esempi celebri includono il personaggio di Lisa in Girl, Interrupted o certi ruoli interpretati dall’attrice Asia Argento in film italiani). Queste rappresentazioni mettono l’accento sulle manifestazioni esterne e clamorose del disturbo – scenate di rabbia, comportamenti promiscui o impulsivi, tentativi di suicidio – a volte esasperandole per esigenze di trama. Il risultato è un’immagine un po’ stereotipata: la persona borderline come “pazza per amore”, affascinante e pericolosa, imprevedibile ma anche magnetica nella sua intensità emotiva. Tale raffigurazione, se da un lato ha portato alla ribalta la diagnosi (prima poco nota al grande pubblico), dall’altro ha contribuito a uno stigma specifico: le persone borderline vengono talvolta bollate come manipolative, ingestibili, “vampiri emotivi”. Sui social, non è raro imbattersi in discussioni tossiche dove ex-partner arrabbiati definiscono l’ex ragazza “borderline” in senso dispregiativo, o meme che ironizzano crudamente sull’instabilità borderline.
Al contempo, un aspetto interessante è che molti giovani, soprattutto donne, si auto-identificano come borderline sui social media, a volte senza una diagnosi formale. Parecchi video su TikTok con hashtag #borderline mostrano utenti (spesso giovanissimi) che raccontano le proprie altalene emotive, l’autolesionismo, la sensazione di vuoto interiore, trovando in questa “etichetta” un senso di appartenenza comunitaria. In gruppi online dedicati al DBP, c’è condivisione di strategie di coping ma anche il rischio di rinforzare certe credenze disfunzionali (“Nessuno potrà mai amarmi perché sono borderline”, “Se hai questo disturbo farai sempre del male a chi ami”, ecc.). Si crea cioè una sorta di echo chamber che, pur offrendo comprensione reciproca, potrebbe involontariamente cronicizzare un’identità di malattia. Alcune adolescenti raccontano addirittura di ambire a essere diagnosticate borderline per spiegare il proprio dolore e sentirsi “viste”: ciò è emblematico di come la vulnerabilità, in questo caso estrema, sia assurta a simbolo identitario.
Dal punto di vista clinico, però, è fondamentale sottolineare che il DBP è trattabile – con adeguata psicoterapia (come la terapia dialettico-comportamentale, DBT, o altri approcci) e a volte farmacoterapia per sintomi specifici – e molte persone con tratti borderline superano i periodi più critici con l’età adulta. L’ICD-11 addirittura enfatizza un continuum dimensionale, riconoscendo che i tratti borderline possono attenuarsi col tempo e che la diagnosi di disturbo di personalità non è fissa e immutabile. Purtroppo, la narrazione mediatica tende a dipingere il borderline come “incurabile” o destinato al dramma perpetuo. Questo può scoraggiare chi ne soffre a cercare aiuto (“se sono destinato a sabotare ogni relazione per sempre, a che serve la terapia?”) e può far perdere speranza anche ai familiari. È importante invece comunicare che si può guarire o migliorare notevolmente: molte persone con DBP sviluppano identità più integrate e relazioni stabili una volta ricevute cure adeguate e supporto.
Un altro elemento problematico della mercificazione della vulnerabilità borderline è la spettacolarizzazione dell’autolesionismo e del suicidio. Alcuni contenuti online mostrano senza filtro cicatrici da tagli sulle braccia, oppure raccontano in dettaglio tentativi di suicidio, rischiando un effetto emulativo su spettatori fragili. Le linee guida mediatiche raccomandano estrema cautela nel descrivere atti autolesivi, per evitare l’effetto Werther (imitazione). Tuttavia, nel contesto di gruppi borderline su internet talvolta c’è una normalizzazione di questi comportamenti (“oggi mi sono tagliata, capita, ecco le foto”). Questo è molto pericoloso: la sofferenza borderline non va normalizzata al punto da diventare parte di uno stile di vita accettato.
In definitiva, il disturbo borderline di personalità incarna una vulnerabilità estrema che attrae e inquieta la cultura contemporanea. Va trattato con rispetto e competenza, né demonizzato come etichetta di inguaribilità, né romanticizzato come sinonimo di passionalità e sregolatezza. Dietro ogni persona con DBP c’è un individuo che lotta con emozioni ingestibili e paura dell’abbandono: ridurre tutto ciò a un trend o a un “tipo psicologico da film” significa mancare di rispetto alla complessità della condizione.
Disturbo Narcisistico di Personalità: il paradosso della vulnerabilità esibita

Il disturbo narcisistico di personalità (DNP) è un altro concetto psichiatrico che ha sfondato nel linguaggio comune, spesso in maniera semplificata. Il DSM-5 definisce il narcisismo patologico attraverso tratti come grandiosità (nelle fantasie o nel comportamento), necessità di ammirazione e mancanza di empatia. I soggetti con DNP hanno un senso esagerato della propria importanza, si considerano speciali, richiedono eccessive conferme e spesso sfruttano gli altri, mostrando arroganza. Curiosamente, però, la teoria distingue due sottotipi di narcisismo: il narcisismo grandioso (il classico vanitoso dominante, sicuro di sé) e il narcisismo vulnerabile (più nascosto, caratterizzato da ipersensibilità alle critiche, insicurezza profonda e bisogno costante di rassicurazioni). Quest’ultimo sottotipo – il narcisista vulnerabile – è particolarmente interessante in relazione all’estetica della vulnerabilità. Si tratta di individui che bramano attenzione e validazione, ma lo fanno più con atteggiamenti da “anima ferita” che non da arroganti. Possono assumere pose umili, lamentarsi di non essere compresi, mostrare insicurezze, ma in maniera finalizzata comunque a porre sé stessi al centro. In un certo senso, strumentalizzano la vulnerabilità come strategia relazionale: il loro mostrarsi fragili serve ad attrarre cure e ammirazione.
Nella cultura social, molti commentatori hanno osservato un aumento di comportamenti riconducibili a narcisismo (grandioso e vulnerabile). Piattaforme come Instagram, basate su like e autorappresentazione, offrono un palcoscenico ideale per tendenze narcisistiche. Ciò può sembrare contraddittorio col tema della vulnerabilità, ma non lo è: in realtà alcuni narcisisti “2.0” hanno capito che mostrarsi perfetti suscita invidia, mentre mostrarsi imperfetti e vulnerabili suscita empatia – e quindi seguito. Ecco allora che influencer notoriamente egocentrici ogni tanto condividono sfoghi sul proprio stress o pianti in diretta, recuperando il sostegno emotivo del pubblico. Non è detto che tutti lo facciano in modo manipolatorio consapevole, ma il pattern è osservabile: la vulnerabilità performativa può essere uno strumento di autopromozione. Ad esempio, un/una creator che abitualmente posta foto glamour, in un momento di calo di engagement potrebbe pubblicare un lungo post confessando un periodo buio o complessi personali: questo lato umano inatteso intenerisce i follower, che rispondono con un’ondata di commenti amorevoli. L’influencer in questione ottiene così l’attenzione e l’affetto desiderati – in un meccanismo di gratificazione che alimenta ulteriormente la dinamica narcisistica di fondo (ricerca di approvazione esterna continua).
Parallelamente, esiste un fenomeno ampio di “diagnosi pop” di narcisismo, soprattutto legato alle relazioni amorose tossiche. In rete abbondano articoli e video su come riconoscere un “partner narcisista”, come difendersi dal “narcisista perverso”, ecc. Da un lato, ciò ha aumentato la consapevolezza sulle dinamiche di abuso emotivo (gaslighting, love bombing, etc.), il che è positivo. Dall’altro, però, l’etichetta di “narcisista” è diventata un marchio infamante usato con disinvoltura, spesso senza un reale fondamento clinico. Ogni ex fidanzato egoista o traditore viene etichettato come narcisista patologico, ogni genitore severo come “genitore narcisista”. Questa inflazione del termine può banalizzare un disturbo che in realtà ha una sua precisa complessità. Inoltre, in queste narrazioni l’enfasi sulla vittimizzazione (chiunque abbia avuto a che fare con un narcisista viene presentato come vittima di abusi psicologici) può portare alcune persone a utilizzare la diagnosi di DNP come giustificazione esterna per ogni dinamica relazionale negativa, evitando di analizzare obiettivamente conflitti o responsabilità reciproche. In certi casi, paradossalmente, c’è chi interpreta il ruolo della “vittima del narcisista” quasi con una certa gratificazione, perché questo dona uno status di sopravvissuto resiliente – nuovamente, la vulnerabilità elevata a distintivo identitario.
Dal punto di vista diagnostico, va ricordato che nell’ICD-11 il disturbo narcisistico come categoria separata scompare: il nuovo sistema preferisce valutare il livello di gravità del disturbo di personalità e specificare tratti disfunzionali (ad esempio “tendenza all’autocentratura e ricerca di attenzione” può emergere come tratto di dissocialità o negatività). Questo cambiamento riflette una certa difficoltà della diagnosi narcisistica, spesso comorbida con altre, e il rischio di etichettare in modo rigido persone che possono mostrare tratti narcisistici in alcune fasi di vita. Per la discussione qui, ciò che importa è sottolineare che non ogni persona vanitosa è un narcisista clinico, e non ogni “narcisista” mediatico lo è in senso patologico. C’è una tendenza generale alla narcisizzazione della società (promossa anche dai social), ma il DNP vero riguarda una minoranza e si associa a sofferenza (spesso celata dietro la maschera di sicurezza) e a importanti difficoltà relazionali.
In relazione all’estetica della vulnerabilità, il paradosso del narcisista vulnerabile evidenzia come anche la fragilità possa essere esibita in modo non autentico. Un narcisista vulnerabile può raccontare traumi dell’infanzia o attuali crolli emotivi, ma farlo con l’aspettativa implicita di essere ammirato per la sua sensibilità o compatito come merita. Mancando di vera empatia, costui non è tanto interessato a uno scambio emotivo reciproco, quanto a riempire il proprio vuoto attraverso l’attenzione altrui. In clinica spesso queste persone sono difficili da trattare: dietro lamentele e insicurezze mostrano una forte resistenza a mettersi in discussione, e possono manipolare anche il terapeuta ricercandone l’ammirazione. Nel mondo online, se un tale soggetto diventa influencer “fragile”, il rischio è di diffondere un modello in cui la vulnerabilità è performata solo per ottenere like, diseducando il pubblico riguardo al valore genuino della condivisione emotiva.
In definitiva, il disturbo narcisistico e l’egocentrismo diffuso ci ricordano che non tutta la vulnerabilità esibita è autentica. Alcuni la usano come mezzo e non come fine. Per il pubblico e per i clinici è importante saper distinguere queste situazioni, coltivando empatia per il dolore altrui ma anche un sano senso critico di fronte a possibili strumentalizzazioni.
Disturbo d’Ansia Sociale: paura e ricerca di conferme nell’era digitale
L’ansia sociale, nota anche come fobia sociale, è un disturbo d’ansia caratterizzato da intensa paura di situazioni sociali o prestazionali in cui la persona è esposta al possibile giudizio altrui. Il DSM-5 definisce il disturbo d’ansia sociale come un timore marcato e persistente di una o più situazioni sociali in cui l’individuo teme di agire in modo imbarazzante o umiliante; l’esposizione a tali situazioni provoca ansia immediata fino a veri e propri attacchi di panico, e le situazioni temute sono evitate o sopportate con forte disagio. Questa paura interferisce significativamente con la vita quotidiana. L’ICD-11 include la fobia sociale tra i disturbi d’ansia, con criteri simili focalizzati sull’ansia marcata nelle interazioni o esibizioni in pubblico e sui comportamenti di evitamento. È un disturbo relativamente comune, che tipicamente esordisce nell’adolescenza.
L’ansia sociale, più di altri disturbi, è stata influenzata e al contempo rappresentata dalla diffusione dei social network. Da una parte, internet offre rifugio agli ansiosi sociali: interagire dietro uno schermo è percepito come meno minaccioso che di persona. Molti ragazzi timidi o con fobia sociale riescono a esprimersi meglio online, trovano amici virtuali, partecipano a community senza l’impatto diretto dello sguardo altrui. Durante la pandemia di COVID-19 questo aspetto è emerso chiaramente. Tuttavia, dall’altra parte, la cultura social ha creato nuove fonti di ansia: il bisogno di apparire, l’ansia da confronto costante (vedere gli altri divertirsi, avere mille amici, mentre l’ansioso sociale si sente isolato), e anche nuove situazioni valutative (ad esempio parlare in video su Zoom, mostrarsi in foto profilo, scrivere post e attendere like – tutte micro-situazioni sociali che possono innescare timori di giudizio). La cosiddetta “FOMO” (Fear of Missing Out), cioè la paura di restare esclusi dalle esperienze che gli altri vivono, colpisce molti giovani utenti dei social ed è strettamente legata all’ansia sociale: chi è insicuro nelle relazioni teme doppiamente di essere tagliato fuori o di non essere invitato perché non all’altezza. Studi hanno indicato che persone con tratti di ansia sociale elevata possono sviluppare una vera dipendenza dai social network, in un uso compensatorio: li controllano compulsivamente per restare aggiornati su ciò che fanno gli altri e tentare di sentirsi connessi, ma questo può peggiorare il loro umore ed ansia. È un circolo vizioso: più tempo online a vedere vite altrui apparentemente brillanti -> più senso di inadeguatezza e isolamento -> più ansia e timore di interagire realmente -> ancora più rifugio nel mondo online.
Nella rappresentazione mediatica, l’ansia sociale è qualche volta banalizzata come semplice “timidezza”. Personaggi con ansia sociale severa vengono talvolta ridotti a figure buffe (il classico nerd impacciato nei film teen) oppure a individui dolcemente introversi che trovano poi magicamente coraggio grazie all’amore o ad un amico. Nella realtà clinica, la fobia sociale può essere gravemente invalidante: c’è chi abbandona la scuola perché non riesce a parlare in classe, o rifiuta lavori pur di non dover affrontare riunioni e contatti con estranei. Su internet però è facile trovare meme sull’essere “socialmente imbranati” o “anti-sociali” usati quasi con autoironia affettuosa: ad esempio, vignette dove una persona ansiosa rifiuta inviti e resta a casa con il gatto e Netflix. Questi contenuti possono essere un modo per sdrammatizzare e sentirsi meno soli, il che è utile, ma possono anche involontariamente normalizzare l’evitamento come fosse una caratteristica innocua della personalità. Un adolescente con severa ansia sociale potrebbe convincersi che è normale e accettabile isolarsi sempre, perché tanto “io sono fatto così, sto meglio solo online”. Il confine tra accettazione di sé e rinuncia a migliorare è delicato.
Un altro aspetto dell’estetica della vulnerabilità riguarda la confessione pubblica di ansie. Molte persone più o meno note raccontano la propria ansia sociale online – ad esempio noti Youtuber che dichiarano di essere in realtà introversi e di aver avuto attacchi di panico durante meet-and-greet con fan. Questo aiuta a sensibilizzare sul disturbo e a far capire che può colpire chiunque, anche chi appare spigliato. Tuttavia, c’è anche chi, non avendo un vero disturbo, parla di “ansia” come di un vezzo caratteriale (“sono asociale, odio tutti, preferisco stare tra i miei libri”): ciò può offuscare la comprensione dell’ansia sociale clinica, che non è misantropia snob ma paura intensa e sofferenza.
Clinicamente, l’ansia sociale è ben trattabile con terapie cognitivo-comportamentali (esposizioni graduali alle situazioni temute, ristrutturazione dei pensieri negativi sul giudizio altrui) e, se necessario, ansiolitici o antidepressivi. Un giovane che scopre su Instagram di soffrire forse di ansia sociale perché si riconosce nei post al riguardo, dovrebbe essere incoraggiato a vedere quella vulnerabilità non come un marchio immodificabile (“sono destinato ad essere per sempre escluso”), ma come un problema affrontabile con l’aiuto appropriato. Purtroppo, la normalizzazione eccessiva del disagio sui social può portare al messaggio implicito “stare male è normale, quindi perché cercare cure?”. Riconoscere i sintomi in sé stessi è il primo passo, ma deve essere seguito dalla ricerca di strategie per stare meglio, non dall’adagiarsi in un’identità di ansioso cronico.
Trauma complesso e narrativa del trauma
Negli ultimi anni la parola “trauma” è diventata ubiqua nel discorso pubblico. Non si parla più solo di disturbo da stress post-traumatico (PTSD) in riferimento a grandi traumi singoli (guerre, disastri, aggressioni), ma anche di trauma complesso (spesso indicato con la sigla C-PTSD dall’inglese Complex PTSD). L’ICD-11 ha riconosciuto formalmente il Disturbo da stress post-traumatico complesso come entità a sé: oltre ai sintomi tipici del PTSD (rivivere l’evento, evitamento e iperattivazione psicofisiologica), il C-PTSD include difficoltà persistenti nella regolazione delle emozioni, convinzioni di sé profondamente negative (sentimenti di vergogna, colpa, valore personale diminuito) e problemi interpersonali significativi (incapacità di sentirsi vicini agli altri).
Questo quadro è tipico di esperienze traumatiche prolungate e ripetute, spesso nell’infanzia (come abusi cronici, violenza domestica protratta, negligenza grave). Anche se il DSM-5 non elenca separatamente il C-PTSD, riconosce nei commenti clinici che traumi infantili estesi possono portare a sindromi complesse spesso diagnosticate nei pazienti come PTSD associato a disturbi di personalità, dissociativi, ecc. In parole semplici, il trauma complesso cattura quegli effetti pervasivi di traumi relazionali prolungati sulla personalità e sul funzionamento emotivo globale di una persona.
Nel dibattito mediatico e sui social, il concetto di trauma è diventato un ombrello sotto cui molti collocano svariate esperienze dolorose. Da un lato, questo riflette una maggiore consapevolezza: oggi si riconosce che anche gli abusi psicologici, l’abbandono emotivo, il bullismo prolungato possono lasciare cicatrici profonde e non visibili – insomma, c’è sensibilità sul fatto che il trauma non è solo l’incidente stradale o l’evento singolo scioccante. Dall’altro lato, tuttavia, l’uso inflazionato del termine “trauma” rischia di allontanarsi dal rigore diagnostico. Su TikTok e Twitter si vedono spesso affermazioni del tipo: “se hai questa abitudine strana, potrebbe essere dovuta a un trauma” oppure “mi ha tradito, è stato un trauma e ora ho PTSD”. Alcuni psicologi hanno criticato il modo in cui tutto diventa trauma online: un video virale sosteneva ad esempio che guardare più volte lo stesso show televisivo sia segno di trauma irrisolto, oppure che essere molto perfezionisti derivi sicuramente da traumi passati. In realtà, come fanno notare gli esperti, queste sono generalizzazioni eccessive e fuorvianti: se è vero che molti comportamenti possono correlare a storie traumatiche, non c’è un rapporto di causa-effetto così semplicistico (ci sono persone perfezioniste per temperamento o educazione, senza per questo aver subito “traumi”). Il rischio di vedere “trauma dappertutto” è duplice: da un lato si patologizza ogni difficoltà normale (si tende a chiamare trauma anche ciò che potrebbe essere semplicemente un’esperienza dolorosa ma non traumatica in senso clinico), dall’altro si genera confusione sui criteri reali di PTSD e C-PTSD. Come chiarito dal DSM-5 e dall’ICD-11, per diagnosticare un disturbo post-traumatico deve esserci stato un evento minaccioso estremo (pericolo di morte, violenza grave, abuso sessuale, ecc.); nel C-PTSD, questo evento è tipicamente protratto o ripetuto, da cui l’effetto devastante su identità ed emozioni. Dire “ho un trauma” per indicare, ad esempio, le delusioni amorose che mi rendono insicuro, è un uso metaforico comprensibile nel parlato, ma che non equivale a un PTSD. Tuttavia online spesso queste distinzioni sfumano: molte persone si autodiagnosticano C-PTSD per aver vissuto relazioni tossiche o infanzie disfunzionali, magari senza presentare davvero tutti i sintomi specifici richiesti. Ciò può portare a una sorta di auto-etichettamento che da un lato legittima il proprio dolore (“se sto male è perché ho un trauma, quindi è giusto che io stia così”), dall’altro però rischia di incasellare la persona in un ruolo di eterna vittima traumatizzata, con una prospettiva pessimistica di recupero.
Nei media mainstream, la narrazione del trauma è dilagante: romanzi, film e serie spesso includono rivelazioni di abusi passati per dare profondità ai personaggi. Se fatto con rispetto, questo può aiutare a evidenziare quanto certi mali sociali (violenza domestica, abusi sui minori) siano diffusi e devastanti. Ma quando il trauma diventa un espediente narrativo ricorrente, c’è il rischio di assuefare il pubblico o di trattare il tema con superficialità. Alcuni critici hanno parlato di “trauma plot” come di un cliché contemporaneo, dove il valore di un personaggio sembra direttamente proporzionale alla gravità del trauma che può esibire nella trama. Questo può portare a una competizione del trauma anche nella vita reale: ad esempio, sui social a volte chi ha vissuto traumi “maggiori” tende (comprensibilmente) a irritarsi nel vedere altri sbandierare come traumatiche esperienze per loro ben meno estreme. Si generano frizioni: “tu non sai cosa sia il vero trauma, io sì”. Anche tra i pazienti stessi, si osserva in gruppi di mutuo aiuto una sorta di confronto (“il mio trauma è più grave del tuo, quindi tu non puoi capire il mio dolore”). Tutto ciò frammenta la solidarietà e complica la guarigione, perché ognuno si chiude nel proprio guscio di dolore rivendicando una unicità che lo rende intoccabile.
Un effetto collaterale dell’estetizzazione del trauma è la diffusione del concetto di trigger (innesco). Ormai comune nel linguaggio online, indica quegli stimoli che possono riattivare i ricordi traumatici causando angoscia. È importante conoscerli e rispettarli (ad esempio, mettere avvisi di “trigger warning” prima di contenuti che mostrano violenza, sangue, abusi, etc.). Tuttavia, anche qui la deriva è dietro l’angolo: c’è chi invoca trigger warning per qualunque tema scomodo o emozionante, e chi accusa altri di averlo “triggerato” per discussioni ben lontane da traumi reali. La cultura del trigger warning, nata per tutela, se applicata indiscriminatamente può finire per infantilizzare il pubblico o per convincere le persone traumatizzate che il mondo debba essere completamente ripulito da ogni ricordo del passato (cosa impossibile, e neanche auspicabile in ottica di resilienza). L’approccio clinico al trauma insegna piuttosto a aiutare il paziente a integrare il ricordo traumatico, in modo che perda la sua carica distruttiva; non potremo mai eliminare tutti i potenziali trigger dall’ambiente, ma possiamo lavorare sulle reazioni della persona a quegli stimoli. Su internet, al contrario, a volte si alimenta un’iperprotettività che rischia di cronicizzare la fragilità: se mi autodefinisco “traumatizzato” e chiedo al mondo di adeguarsi, potrei non impegnarmi mai nel mio percorso interno di guarigione, restando prigioniero di quel ruolo.
In conclusione, il discorso sul trauma nella sfera pubblica evidenzia un delicato bilanciamento: è fondamentale riconoscere e dare voce alle vittime di traumi (rompendo tabù e colpevolizzazioni che per troppo tempo le hanno silenziate), ma bisogna stare attenti a non inflazionare il concetto o a non farne un’etichetta identitaria intoccabile. Il trauma complesso in particolare va compreso nella sua gravità: chi ne soffre presenta sintomi simili ai pazienti borderline (difficoltà emotive, di fiducia e identità) ma con un’eziologia fortemente legata a prolungate esperienze traumatiche reali. In clinica, trattare il C-PTSD richiede percorsi integrati (terapie focalizzate sul trauma come l’EMDR, unite a interventi sul sé e le relazioni).
La cultura attuale, con la sua estetica della vulnerabilità, ha meriti nel portare il trauma alla luce, ma al contempo deve evitare di farlo diventare solo un dispositivo narrativo accattivante. Le storie di trauma non dovrebbero servire a vendere più biglietti o a ottenere più click in rete, ma a generare comprensione reale e, si spera, cambiamenti sociali che prevengano quei traumi. Quando il trauma diventa merce, c’è il rischio di perdere di vista il dolore vero delle persone coinvolte.
Effetti sulle popolazioni vulnerabili: adolescenti, giovani adulti e utenti dei social
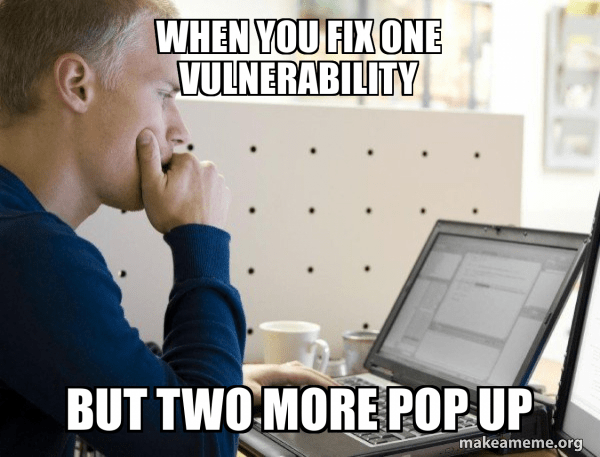
Le dinamiche fin qui descritte – l’esposizione della vulnerabilità, la sua romanticizzazione e mercificazione – hanno un impatto particolarmente forte su chi si trova in una fase di sviluppo identitario e sociale: gli adolescenti e i giovani adulti. Questa fascia di età è naturalmente vulnerabile, poiché i ragazzi sono ancora in cerca di sé stessi, molto influenzabili dal giudizio altrui e in fase di acquisizione di strumenti critici. L’avvento dei social media ha immerso le giovani generazioni in un ambiente costantemente comparativo e performativo. Quali sono dunque gli effetti di questa “cultura della vulnerabilità” sugli utenti più giovani?
Un primo effetto è la normalizzazione del disagio. Come sottolineato in un articolo recente rivolto ai giovani vedere continuamente sui social contenuti di coetanei che dichiarano di star male, di essere depressi o ansiosi, fa percepire queste condizioni come qualcosa di quasi ordinario. Da un lato c’è un aspetto positivo: diminuisce lo stigma, un ragazzo oggi ha meno paura a dire “soffro di attacchi di panico” rispetto a vent’anni fa. Dall’altro lato però, la normalizzazione può portare a sottovalutare la gravità di certi sintomi o a rassegnarsi passivamente. Se la propria timeline è piena di tiktoker che parlano di suicidio o autolesionismo con naturalezza, un adolescente con pensieri suicidari potrebbe convincersi che non valga la pena cercare aiuto, tanto “anche altri ci convivono e lo raccontano semplicemente in giro”. All’estremo opposto, c’è il fenomeno della competizione del dolore: alcuni giovani finiscono per confrontare la propria sofferenza con quella altrui sui social. Purtroppo esistono comunità online (specialmente su alcune piattaforme come Tumblr in passato) dove si creava quasi una gerarchia implicita: più sei “rotto” dentro, più sei interessante. Ragazze con disturbi alimentari o ragazzi con depressione pubblicavano immagini dei propri corpi scheletrici o delle proprie cicatrici, e innescavano commenti di ammirazione malata (“sei così distrutta eppure così bella nella tua malinconia”). Questo culto del dolore ha seri rischi: c’è chi, per sentirsi accettato nel gruppo, può essere portato a estremizzare i propri comportamenti (ad esempio perdere ancora più peso, o tagliarsi più a fondo) perché la sofferenza diventa un simbolo di status in quel microcosmo deviato.
Un altro fenomeno tra i giovanissimi è l’autodiagnosi online. Indagini hanno rivelato che circa un terzo degli adolescenti della Generazione Z si è autodiagnosticato qualche disturbo mentale basandosi su informazioni trovate su internet. I disturbi più “gettonati” in queste autodiagnosi sono risultati l’ansia (quasi la metà dei casi) e la depressione. Inoltre, c’è una differenza generazionale: i più giovani tendono a fare queste ricerche e test su piattaforme nuove come TikTok, mentre i più anziani (millennial) usano di più Facebook o Google. Da un lato, è positivo che i giovani cerchino di capire il proprio malessere; dall’altro, un’autovalutazione inesperta può portare a errori e paure ingiustificate. Un ragazzo introverso e triste può convincersi di avere un disturbo depressivo grave quando magari sta attraversando una normale fase di adattamento, oppure – scenario opposto – un ragazzo con veri sintomi di bipolarismo può confondersi leggendo informazioni superficiali e credere di avere solo “un po’ di stress”. La conoscenza parziale è pericolosa: molti siti o video semplificano i criteri diagnostici in liste di segni “se hai 5 di questi 10 sintomi hai il disturbo X”, senza un contesto clinico. E spesso i giovani non colgono aspetti fondamentali come la durata e l’intensità dei sintomi richiesti per porre diagnosi. In più, l’autodiagnosi può diventare un’autogiustificazione: ad esempio alcuni ragazzi su forum dichiarano “Non posso migliorare le mie relazioni perché ho la BPD (disturbo borderline)”, sebbene non vi sia mai stata una valutazione professionale a confermarlo. Così facendo si ingabbiano in un ruolo e si precludono la possibilità di cambiamento.
L’effetto dei media digitali sui giovani vulnerabili si manifesta anche a livello comportamentale. L’imitazione è un meccanismo potente nell’adolescenza. Se un influencer popolare racconta di come si autolesiona o di come ha smesso di mangiare, alcuni fan potrebbero esserne influenzati (un effetto copycat). Un esempio macroscopico è stato citato: la serie 13 Reasons Why e il picco di suicidi giovanili correlato. Questo ha sollevato l’allarme tra psicologi e genitori, evidenziando la responsabilità dei media nel trattare certi argomenti con cautela. Di conseguenza, in stagioni successive la serie ha introdotto avvertimenti e risorse di supporto, ma ormai il messaggio era stato lanciato.
C’è poi il rischio di bullismo e reazioni negative verso chi esprime vulnerabilità online. Non tutti i contesti digitali sono empatici: alcuni adolescenti hanno subito prese in giro feroci dopo aver condiviso i propri sentimenti. Ad esempio, un ragazzo che posta una poesia sulla sua depressione potrebbe essere sminuito da coetanei cinici (“Ma smettila di fare la vittima per attenzione”). Questo può aggravare enormemente il suo stato, aggiungendo umiliazione e senso di colpa per essersi esposto. Vi sono persino stati casi di “suicide shaming”, in cui utenti deridono chi ha tendenze suicide dicendo frasi orribili del tipo “fallo davvero allora”. Questi fenomeni di violenza verbale sono facilitati dall’anonimato e dalla disinibizione online, e rappresentano un incubo per i giovani già fragili, talvolta con esiti tragici (ci sono cronache di adolescenti che si sono tolti la vita dopo episodi di cyberbullismo legati al loro esprimere disagio).
D’altra parte, non bisogna ignorare che la condivisione online di vulnerabilità può avere effetti positivi su molti giovani. Per chi è isolato o non trova comprensione in famiglia, scoprire community di persone che vivono le stesse sfide (ad esempio gruppi di supporto per adolescenti LGBT+ con traumi familiari, o forum per ragazze con disturbi alimentari in via di recupero) può rappresentare una ancora di salvezza. Quel senso di appartenenza e di essere accettati con tutte le proprie cicatrici può prevenire esiti peggiori, come depressioni gravi o gesti autolesivi. Molti testimoniano che seguire influencer o YouTuber che parlano apertamente delle loro difficoltà e di come le affrontano li ha aiutati a chiedere aiuto a loro volta, o semplicemente a non sentirsi “mostri”. In pratica, l’effetto dipende molto da come la vulnerabilità è narrata: se c’è un messaggio di speranza, di incoraggiamento a fare qualcosa (ad esempio andare in terapia, parlare con qualcuno di fiducia, provare tecniche di coping sane), allora il giovane ne trae uno stimolo costruttivo; se invece la narrazione è fatalista (“stiamo tutti di m***, la vita fa schifo e basta”) oppure ambigua (glamour del dolore fine a se stesso), allora può trascinare verso il basso chi ne fruisce.
Un concetto utile per capire questi effetti è quello di resilienza. Idealmente, esporre i giovani a storie di vulnerabilità dovrebbe servire anche a mostrare percorsi di resilienza – come cioè dalle ferite si possa guarire o comunque convivere in modo sano. Se invece manca questo pezzo e si glorifica solo la ferita, i giovani non apprendono strategie di ripresa, ma solo di caduta. Purtroppo, i contenuti più “virali” non sempre coincidono con quelli più equilibrati: un video drammatico di un adolescente che piange disperato avrà milioni di view, mentre un video dove lo stesso adolescente spiega come è riuscito a stare meglio con mesi di terapia probabilmente ne avrà meno, perché meno sensazionalistico. Ciò crea un bias: i social amplificano l’urlo di dolore iniziale, ma spesso tacciono sul lungo e paziente lavoro di guarigione, che è meno spettacolare da guardare.
Infine, i giovani utenti dei social subiscono anche l’influenza di trend diagnostici passeggeri. Ogni tanto su TikTok emerge la moda di un disturbo: un periodo tutti parlano di ADHD (disturbo da deficit di attenzione/iperattività), un altro di autismo “livello 1” (Asperger), poi tocca al disturbo dissociativo dell’identità, ecc. Molti ragazzi facilmente suggestionabili iniziano a interpretare i propri comportamenti alla luce di quel disturbo di cui sentono parlare – spesso confondendo caratteristiche comuni con sintomi clinici. È il fenomeno del medical student syndrome in salsa social: come gli studenti di medicina si diagnosticano addosso tutte le malattie che studiano, così gli adolescenti digitali si “ritrovano” in tutti i disturbi trendy presentati. Chiaramente alcuni possono effettivamente scoprire condizioni prima ignorate (es. ragazze con ADHD sottodiagnosticato possono riconoscersi in descrizioni diffuse online e decidere di fare valutazione: ciò è un esito positivo). Ma altri assumono etichette erronee e magari le comunicano in giro (a scuola, agli amici) ottenendo reazioni confuse e potenzialmente stigmatizzanti.
In conclusione, l’effetto sulle giovani generazioni dell’estetica della vulnerabilità come mercato è un mosaico complesso di influenze positive e negative. C’è più apertura e dialogo sulle emozioni, ma anche rischio di confusione e scarsa profondità. Per massimizzare i benefici e ridurre i danni, sarà cruciale l’educazione digitale ed emotiva: aiutare i ragazzi a sviluppare pensiero critico (distinguere contenuti affidabili da quelli sensazionalistici), alfabetizzazione emotiva (comprendere le proprie emozioni e quelle altrui senza cadere in estremi di drammatizzazione o negazione) e conoscenza di base sulla salute mentale (sapere, ad esempio, cosa costituisce davvero un PTSD o una depressione clinica, e come chiedere aiuto). Su questo hanno responsabilità sia le scuole che le famiglie, oltre che le stesse piattaforme social e i creatori di contenuti.
Implicazioni per la pratica clinica e terapeutica
Di fronte a questo panorama socio-culturale in rapido mutamento, anche i professionisti della salute mentale – psichiatri, psicologi, psicoterapeuti – sono chiamati ad adattare e ampliare le proprie prospettive. La “mercificazione della vulnerabilità” pone sfide specifiche nella clinica, che riguardano la diagnosi, la relazione terapeutica, gli approcci di trattamento e perfino l’etica professionale.
1. La diagnosi nell’era dell’autodiagnosi e dell’over-sharing:
Sempre più spesso, i clinici accolgono in studio pazienti (soprattutto giovani) che arrivano con già in tasca una “diagnosi” formulata da sé o dalla rete. “Dottore, credo di avere il disturbo borderline perché ho fatto un test online” oppure “Ho letto un thread su Twitter e penso di avere un trauma complesso”. Il terapeuta deve in questi casi equilibrare due esigenze: da un lato validare la sofferenza e l’esperienza del paziente (che attraverso quell’etichetta sta cercando di comunicare un disagio reale), dall’altro fare chiarezza diagnostica basata su criteri scientifici. Può essere utile esplorare con il paziente cosa significa per lui quella diagnosi che porta: ad esempio, un’adolescente che dice “sono borderline” magari esprime un sentimento di identità frammentata e relazioni turbolente; indipendentemente dal fatto che soddisfi tutti i criteri DSM per DBP, è importante riconoscere la verità soggettiva del suo vissuto e poi guidarla a distinguere tra l’uso colloquiale dell’etichetta e il significato clinico. Spesso un lavoro psicoeducativo è necessario: spiegare in modo semplice ma accurato cosa caratterizza davvero un certo disturbo, quali sono i possibili percorsi di cura, può aiutare a ridurre paure infondate o false convinzioni che il paziente ha assorbito online. Ad esempio, può emergere che quel paziente non ha un disturbo borderline ma piuttosto un disturbo dell’attaccamento o un trauma non elaborato; va allora aiutato a comprendere la differenza, senza invalidare il nucleo del suo problema. Le classificazioni come DSM-5 e ICD-11 forniscono criteri utili come guida, ma il clinico deve anche saper contestualizzare: oggi più che mai occorre dire “questo sintomo potrebbe dipendere da più fattori, non saltiamo subito all’etichetta”. Il paradosso è che mentre il pubblico sembra essersi appassionato alle diagnosi (fino all’eccesso di vedersi affibbiare ogni sorta di disturbo), il clinico talvolta deve fare un passo indietro e de-patologizzare ciò che non rientra davvero in un quadro clinico. Ad esempio, normalizzare certe reazioni: “Ciò che descrivi – ad esempio soffrire intensamente per la fine del primo amore – è doloroso ma non è una malattia; vediamo come attraversare questo dolore senza necessariamente incasellarlo come disturbo depressivo”. Questo ridimensionamento va però fatto con tatto, perché il paziente potrebbe vivere la correzione diagnostica come una svalutazione (“allora non mi prende sul serio”). Spiegare la differenza tra disagio e disturbo, e far capire che anche se non c’è una diagnosi X la sofferenza è reale e merita attenzione, è un passaggio cruciale.
2. La relazione terapeutica in un mondo di sovraesposizione:
I pazienti di oggi potrebbero aver già condiviso frammenti delle proprie storie su blog, forum o social, ottenendo vari tipi di feedback. Alcuni arrivano in terapia quasi come “star del trauma” sui loro profili, abituati a un pubblico che commenta. Questo può influenzare la terapia in modi diversi: per alcuni, abituati a ricevere supporto immediato online quando stanno male (seppur superficiale), può essere frustrante trovarsi nel setting terapeutico dove il clinico restituisce interpretazioni magari sfidanti o attende che il paziente elabori da sé. Il terapeuta potrebbe essere visto come “meno empatico” perché non fornisce quella scarica di conforto istantaneo a cui la persona era abituata dal suo pubblico social. Bisogna allora negoziare le aspettative: chiarire il ruolo del terapeuta (non è un amico né un follower, ma un professionista che aiuta anche mettendo di fronte a verità scomode), e costruire pian piano un’alleanza basata su fiducia autentica e non su ricerca di like. Altri pazienti invece, paradossalmente, in terapia fanno più fatica ad aprirsi che online: perché? Perché in terapia c’è uno sguardo umano diretto e la prospettiva di un lavoro sul cambiamento, mentre su internet puoi rivelare molto di te protetto dallo schermo e senza dover cambiare nulla. È noto che rivelare emozioni in pubblico non equivale a elaborarle: un paziente può aver scritto decine di pagine sul suo trauma su Facebook, ma raccontarlo una volta in seduta può risultargli più difficile o toccante, perché in quel momento lo sta affrontando davvero, con qualcuno che ascolta attivamente e pone domande. Il clinico deve dunque accogliere ciò che il paziente ha già espresso altrove (a volte il terapeuta potrebbe persino leggere blog o post del paziente, se questi li condivide, come materiale utile per capire il suo mondo), ma anche guidarlo verso un livello di introspezione diverso. Ci si può complimentare con il paziente per il coraggio di aver condiviso la sua storia pubblicamente, ma poi invitarlo a esplorare in terapia aspetti che forse non ha mai approfondito neppure con sé stesso. In un certo senso la terapia offre uno spazio meno esibitivo e più trasformativo, e ciò va fatto percepire come valore aggiunto rispetto al “sfogarsi online”.
3. L’intervento terapeutico: integrare la realtà digitale del paziente
Un buon clinico oggi non può ignorare la dimensione digitale nella vita del paziente. Ciò significa che in sede di valutazione e anche nel corso della terapia bisogna esplorare domande tipo: Quanto tempo passi sui social? Che tipo di contenuti consumi? Segui influencer o gruppi legati a temi di salute mentale? Ti è mai capitato di sentirti peggio dopo aver visto certi contenuti? Queste informazioni sono rilevanti come lo sono quelle sul contesto familiare o scolastico. Per esempio, se un giovane con ansia sociale passa la notte su Instagram a confrontarsi con la vita patinata altrui, è evidente che quell’abitudine alimenta il problema: la psicoeducazione dovrà includere anche suggerimenti su igiene digitale (es. limitare l’uso prima di dormire, magari “silenziare” account che scatenano confronto negativo). Oppure, se una ragazza depressa frequenta un forum pro-ana (pro-anoressia) o comunità in cui la negatività è pervasiva (“siamo tutti senza speranza”), il terapeuta dovrebbe discuterne con lei, magari cercare insieme alternative più sane (forum di supporto al recupero, ecc.) o incoraggiarla ad una pausa da quegli ambienti tossici. Questo senza demonizzare internet – altrimenti i giovani si chiudono – ma con approccio collaborativo: “vediamo se il tuo contesto online ti sostiene o ti affossa, e cosa possiamo modificare”.
Sul fronte opposto, il terapeuta può anche prescrivere in qualche modo risorse online utili: ad esempio consigliare un podcast psicoeducativo di qualità, segnalare un canale YouTube affidabile che spiega l’ansia, incoraggiare l’uso di app evidence-based per monitorare l’umore o praticare mindfulness. La tecnologia e i social non devono essere solo nemici: usati bene, possono potenziare la terapia (ad es., alcuni terapeuti utilizzano chat tra una seduta e l’altra per dare supporto nei momenti critici, oppure fanno usare ai pazienti gruppi Facebook chiusi di mutuo aiuto moderati da professionisti). Bisogna però vigilare su una cosa: il sovraccarico informativo. Un paziente di oggi può arrivare con una mole di informazioni confuse raccolte dal web, convinto di dover fare mille cose (dieta X, yoga, 10 tipi di psicoterapia diversi citati su Reddit…). Il clinico deve aiutare a mettere ordine, magari stilare insieme una gerarchia di priorità realistiche, e spesso sfatare miti (es. “ho letto che con la mia diagnosi non guarirò mai”, oppure “tutti dicono che gli psicofarmaci rovinano, quindi ho paura”: qui il medico deve fornire dati reali per controbilanciare i miti online).
4. Neutralità e self-disclosure del clinico:
Un altro aspetto su cui riflettere è l’impatto di questa cultura dell’autenticità sul ruolo del terapeuta. Tradizionalmente, specialmente in approcci come quello psicoanalitico, il terapeuta mantiene una neutralità e riservatezza personale molto elevate. Oggi però alcuni pazienti, abituati a scambi emotivi diretti, possono trovare alienante un terapeuta che non lasci trasparire nulla di sé. Non è un caso che anche diversi psicologi abbiano cominciato a usare i social per comunicare – con tutte le cautele – una maggiore vicinanza umana. Per esempio, alcuni psicoterapeuti creano blog o account Instagram dove parlano (in generale, mai dei propri pazienti) di salute mentale, talvolta condividendo anche piccole parti di sé (emozioni comuni, esperienze superate). Lo scopo è ridurre la distanza e combattere lo stigma, mostrando che il terapeuta è sì un professionista, ma anche una persona comprensiva. Tuttavia, qui bisogna stare attenti a non cadere nell’eccesso opposto: il terapeuta non deve mai spostare l’attenzione su di sé a scapito del paziente. Ogni eventuale self-disclosure (condivisione di informazioni personali) in seduta va ponderata: può essere utile dire “capisco quel che provi, anch’io ho sperimentato lutti nella vita”, se questo serve a far sentire compreso il paziente; ma raccontare in dettaglio i propri lutti sarebbe sconveniente e potenzialmente controproducente. La tentazione di “essere amici” del paziente va resistita, nonostante la cultura dell’autenticità possa far pensare a qualcuno che uno psicologo “dovrebbe” aprirsi di più. Professionalità ed empatia possono coesistere: il terapeuta mostra autentica partecipazione emotiva senza però trasformare la seduta in un talk-show sui propri problemi.
5. Aspetti etici e deontologici:
L’ultimo punto riguarda il ruolo pubblico dei clinici e la responsabilità verso il discorso mediatico. Molti professionisti sono chiamati dai media a commentare fenomeni come quelli discussi (es. “lo psicologo in TV che parla dei social e adolescenti”). È fondamentale che la categoria fornisca un contributo scientificamente fondato e ponderato, per arginare la marea di disinformazione. Ad esempio, quando in televisione o sui giornali esplode un caso di cronaca legato magari a un suicidio giovanile in diretta social, lo psicologo ha il dovere di non semplificare né colpevolizzare (“è colpa dei social” sarebbe una spiegazione semplicistica), ma di spiegare le complessità, sottolineare i campanelli d’allarme e promuovere la prevenzione. Allo stesso modo, nel commentare la tendenza di giovani a diagnosticarsi disturbi, il professionista dovrebbe evitare toni denigratori (“sono tutti esibizionisti, moda di TikTok”) e invece capire il bisogno che c’è sotto e offrire consigli costruttivi (ad esempio: “Ragazzi, se vi ritrovate in questi sintomi, parlatene con uno specialista invece di affidarvi solo al web”). Una comunicazione pubblica rispettosa e chiara può fare molto per educare la comunità e ridurre i rischi di mercificazione scorretta della vulnerabilità.
In conclusione su questo capitolo clinico, la pratica della salute mentale si sta ridefinendo in rapporto alla cultura della vulnerabilità pubblica. I clinici devono sviluppare nuove competenze culturali: conoscere le piattaforme digitali, i linguaggi giovanili, perfino le mode terminologiche (sapere cos’è il “sadfishing” o un “trigger” oggi è importante quanto sapere il transfert, perché fa parte della realtà del paziente). Devono inoltre lavorare su di sé per evitare di reagire con bias o irritazione di fronte ai “figli di internet”, mantenendo quell’equilibrio tra accoglienza del racconto del paziente e guida verso una verità clinica più oggettiva. Diagnosi prudenti, psicoeducazione, empatia strutturata e considerazione del mondo online divengono ingredienti imprescindibili del lavoro terapeutico. Così facendo, il clinico può aiutare il paziente a integrare la propria vulnerabilità (né negarla né esibirla a vuoto) e a utilizzarla come leva per la crescita personale, anziché come etichetta di mercato in cui restare intrappolato.
Conclusioni
L’estetica della vulnerabilità come mercato è un fenomeno che riflette le tensioni profonde della nostra epoca: da un lato la genuina sete di autenticità ed empatia, dall’altro la tendenza a commodificare qualsiasi aspetto dell’esperienza umana, anche il dolore. In una cultura satura di immagini e narrazioni, la vulnerabilità emotiva è diventata un potente elemento narrativo, capace di suscitare identificazione e partecipazione. Ciò ha contribuito a rompere molti silenzi su sofferenze un tempo indicibili – pensiamo al dibattito pubblico sulla salute mentale, alimentato anche dalle confessioni di persone famose, o alla sensibilizzazione sulle molestie e i traumi grazie a movimenti come #MeToo. Tuttavia, lungo questo processo, abbiamo visto come il discorso sul disagio possa deviare verso la spettacolarizzazione e la semplificazione eccessiva: il rischio è di trovarci con tanta “estetica” e poca sostanza.
Le implicazioni psicosociali e cliniche analizzate in questo saggio suggeriscono alcune linee guida per il futuro:
- Educare alla complessità: È fondamentale che educatori, media e anche i cosiddetti influencer trasmettano il messaggio che i disturbi mentali non sono accessori di moda né identità fisse con cui auto-etichettarsi, ma condizioni serie e spesso complesse. Bisogna promuovere una cultura della salute mentale informata, magari inserendo programmi di alfabetizzazione emotiva nelle scuole, e incoraggiando i giovani a cercare fonti affidabili. Allo stesso tempo, è utile insegnare a distinguere tra emozioni comuni (tristezza, paura, rabbia che tutti proviamo) e sintomi clinici che indicano un disturbo: non per fare gerarchie di validità, ma per sapere quando è il caso di chiedere aiuto professionale.
- Valorizzare la condivisione autentica, scoraggiare la performance: I social e i media potrebbero adottare linee guida o campagne per incoraggiare contenuti di condivisione emotiva responsabile. Ad esempio, promuovere testimonianze non solo del “momento di crisi”, ma anche del “percorso di ripresa”, così da veicolare speranza e strumenti. Gli algoritmi delle piattaforme potrebbero – in un mondo ideale – privilegiare contenuti di utilità pubblica (come informazioni di supporto, contatti di centri aiuto) quando rilevano parole chiave su suicidio o depressione. Viceversa, si potrebbe intervenire per limitare la viralità di contenuti palesemente pericolosi (come challenge autolesive o video che romanticizzano disturbi alimentari).
- Supportare i creatori di contenuti responsabili: Ci sono influencer e figure pubbliche che trattano questi temi con grande rispetto e autenticità, spesso collaborando con psicologi per diffondere informazioni corrette. Queste voci dovrebbero essere amplificate. Un esempio positivo è quello di alcuni cantanti o attori che, dopo aver reso pubblici i loro problemi di salute mentale, finanziano fondazioni o campagne di sensibilizzazione (piuttosto che limitarsi a usare la “confessione” per promuovere un film o un album). Questo mostra un modo etico di condividere la vulnerabilità: non fine a se stessa o per guadagno, ma come leva per il bene comune.
- Clinici e pazienti come alleati contro lo stigma 2.0: Se nel passato il nemico era lo stigma del silenzio, oggi paradossalmente dobbiamo combattere uno stigma di segno diverso ma altrettanto insidioso: la banalizzazione. Dire “siamo tutti un po’ matti” non è lotta allo stigma, è negazione delle specificità. I pazienti e gli ex-pazienti (personaggi pubblici e non) possono testimoniare che da depressione grave si può guarire, che vivere con l’ansia sociale si può eccome con gli aiuti giusti, ma anche che non è stato semplice né glam. I clinici devono sostenere queste testimonianze e magari lavorare fianco a fianco con i media per diffondere conoscenza e non sensazionalismo.
- Proteggere i minori online: Si parla tanto di regolamentare i social per i contenuti violenti o sessuali, ma altrettanto importante sarebbe vigilare sui contenuti che riguardano atti autolesivi o suicidari. Piattaforme come Instagram hanno iniziato a bandire o oscurare immagini di cutting (tagli) e simili – passi nella giusta direzione. Servirebbero anche ambienti sicuri moderati dove i giovani possano discutere di ciò che li turba con la presenza magari di psicologi volontari, in modo da intercettare chi è a rischio e orientarlo verso aiuto concreto (ci sono iniziative isolate, come chatbot della prevenzione suicidi su Facebook, ma andrebbero potenziate).
In definitiva, è necessario un approccio equilibrato: riconoscere che la vulnerabilità condivisa può unire le persone e abbattere muri, ma toglierle il suo contesto (clinico, storico, personale) e ridurla a prodotto da consumare rischia di svuotarla di senso e di efficacia. Come clinici, accademici e cittadini interessati alla psicologia, abbiamo il compito di riportare la complessità laddove la discussione pubblica tende al bianco o nero: né idolatrare la sofferenza come marchio di identità, né tornare a nasconderla sotto il tappeto come vergogna. La vulnerabilità può e deve essere ascoltata, rispettata e capita – non venduta.
Per concludere con una metafora, possiamo immaginare la vulnerabilità emotiva come una opera d’arte delicata: esposta al pubblico, può suscitare empatia e catarsi, ma se viene mercanteggiata in serie perde la sua autenticità e rischia di rompersi. Sta a tutti noi – clinici, media, educatori, utenti – custodirne il significato, usando il potere della condivisione per creare ponti di comprensione, senza svilirla a semplice moneta di scambio nel bazar delle emozioni.
Bibliografia (selezione)
- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5). Arlington, VA: APA Publishing.
- World Health Organization. (2019). International Classification of Diseases 11th Revision (ICD-11). Ginevra: WHO.
- Ahuja, J., & Fichadia, P. A. (2024). Concerns Regarding the Glorification of Mental Illness on Social Media. Cureus, 16(3): e56631.
- Petrofes, C., Howard, K., et al. (2024). Sad-fishing: Understanding a maladaptive social media behavior in college students. Journal of American College Health, 72(8): 2352-2356.
- Deutz, M. H. F., et al. (2022). Associations Between Borderline Personality Disorder Symptoms and Online Self-Disclosure in Clinically Referred Youth. Journal of Personality Disorders, 36(3): 359-376.
- Rutter, L. A., et al. (2023). “I haven’t been diagnosed, but I should be” – Insight into self-diagnoses of common mental health disorders: Cross-sectional study. JMIR Formative Research, 7: e39206.
- Bridge, J. A., et al. (2019). Association Between the Release of Netflix’s 13 Reasons Why and Suicide Rates in the United States: An Interrupted Time Series Analysis. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 58(6): 725-733.e6.
- Dolan, E. W. (2025). Why narcissists overuse social media — and how mindfulness can help. PsyPost (15 marzo 2025) – sintesi dello studio di Giancola et al., Int. J. of Human–Computer Interaction.
- Kadora, R. (2024). Why Do We Romanticise Mental Illness? Medium.com (12 nov 2024).
- Disparti, D. (2025). La normalizzazione del disagio sui social network: quando la sofferenza diventa estetica. Studenti.it (7 lug 2025).
- Beckmann, J. (2024). “It’s Kind of My Job to Post Perfect Stuff, But Kind of Not” – How Influencers with Borderline Personality Organisation Become Activists for a Salutogenic Personal Recovery in Instagram Stories. Human Arenas.
- Guha, A. (2022). How TikTok and Twitter Get Trauma So Wrong: Understanding mental health misinformation on social media. Psychology Today (30 set 2022).
Lascia un commento